Incidente nella grotta
“Degrado di monumenti storici”. È questa l’accusa che viene mossa contro André Breton, padre del movimento surrealista ora sotto processo come un vandalo qualsiasi. La vicenda, poco conosciuta, merita di essere ricostruita.
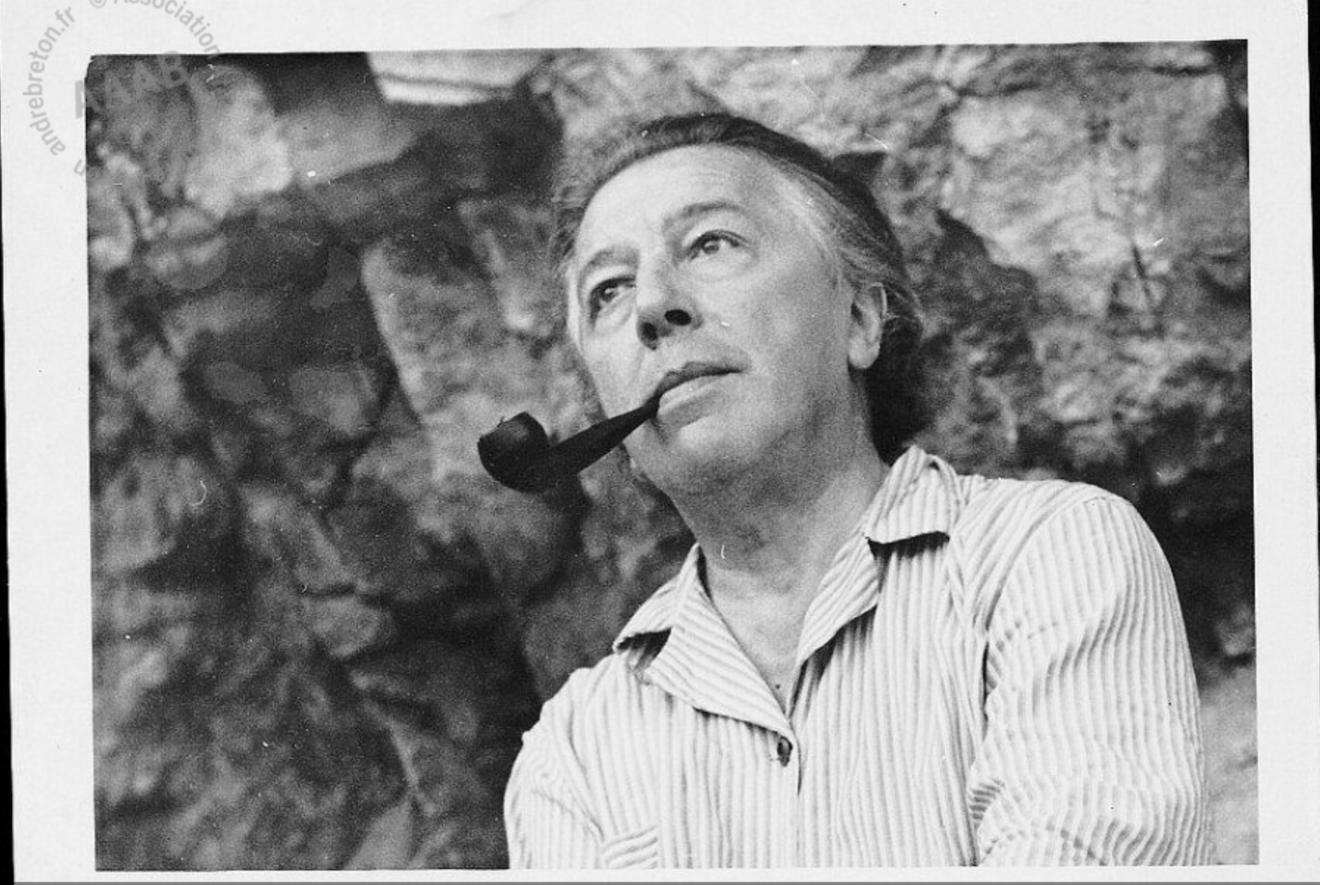
Incidente nella grotta
“Degrado di monumenti storici”. È questa l’accusa che viene mossa contro André Breton, padre del movimento surrealista ora sotto processo come un vandalo qualsiasi. La vicenda, poco conosciuta, merita di essere ricostruita.
Sono talmente tante le avventure intellettuali che Yona Friedman ha affrontato nel corso della sua lunga vita che, oggi che è venuto a mancare (il 20 febbraio scorso per l’esattezza), viene da chiedersi se la sua essenza non assomigli più a quella delle piante che a un uomo, vale a dire non un’entità univoca, ma una comunità di enti viventi. Forse questo ragionamento è valido per tutte le grandi figure del passato, specie quelle leonardesche come la sua, ma vale la pena provare ad enumerarle brevemente, almeno le principali.
Studente
Dapprima viene Janos-Antal Friedman nato a Budapest nel 1923 da una famiglia di avvocati, media borghesia ebraica, durante il “falso fascismo” dell’ammiraglio Miklós Horthy che, nonostante alcune pesanti concessioni come le leggi razziali, manterrà una certa autonomia dall’alleanza con la Germania nazista fino alla primavera del 1944. Prima di questo momento, il giovane Friedman ha modo di iscriversi ad architettura con un permesso speciale e di seguire le lezioni pubbliche (dove non vigono cioè le leggi razziali) di Károly Kerényi, oppositore conservatore del regime, e due importanti conferenze di Werner Heisenberg. Entrambe queste figure lasciano un’impronta indelebile, anche a distanza di anni Friedman tornerà a utilizzare il mito come psicologia collettiva ad esempio nei suoi film d’animazione realizzati insieme con la moglie Denise o sulla fisica teorica da usare come lente per costruire un’immagine unica del mondo con forti ricadute sull’architettura e l’urbanistica.
Combattente
Arriva poi l’occupazione tedesca nella primavera del 1944, il conseguente regime fantoccio delle Croci frecciate di Ferenc Szalasi – responsabili di indicibili atrocità verso gli ebrei – e il trasferimento a Budapest di Adolf Eichmann in persona per organizzare la più grande deportazione (500.000 persone) della comunità ebraica, rimasta fino ad allora pressoché intatta, verso Auschwitz. Friedman si unisce a un piccolo gruppo di resistenza sionista assumendo il nome di battaglia Yona (“colomba”), falsificando documenti e sperimentando tecniche di comunicazione da guerriglia, ma subisce una delazione e si salva solo perché imprigionato dalla Gestapo come oppositore politico e non in quanto ebreo. Il caos sopraggiunto con la rapida avanzata dell’Armata Rossa, ricordato magistralmente da Sándor Márai in Liberazione (Adelphi), gli restituisce la libertà, ma è vivo per miracolo: un soldato tedesco che avrebbe potuto sparargli alla testa lo lascia andare, forse sapendo che in poche ore avrebbe potuto capitargli la stessa sorte.
Profugo
Amareggiato dalla distruzione della sua società di appartenenza, decide di emigrare nella Terra promessa, ma il Regno Unito ostacola l’immigrazione degli ebrei europei verso la Palestina, perciò è costretto a trascorrere un anno a Bucarest dove c’è una sede dell’agenzia ebraica per l’Aliyah. Qui fa l’esperienza di profugo insieme a molti altri, costretto a vivere in grandi appartamenti insieme con molti altri nuclei famigliari che vanno e vengono ogni giorno, cosa che stimola il suo primo progetto per un abitare mobile e flessibile dove anche gli impianti possano essere spostabili a piacere per meglio fronteggiare l’emergenza.
Kibbutznik
Emergenza che incontra anche appena sbarcato finalmente a Haifa nel 1946, dove ogni giorno sbarcano centinaia di persone da allocare in baracche o centri d’accoglienza riadattati velocemente in attesa di una destinazione più certa (ricorda qualcosa?). Yona fa allora l’esperienza comunitaria del kibbutz di Kfar Glikson, con altri ebrei ungheresi e rumeni, iscrivendosi al Technion di Haifa per finire i suoi studi e mantenendosi lavorando come muratore. Questi però sono di nuovo interrotti dalla guerra d’Indipendenza del ’48 dove lui è addetto alla progettazione delle trincee, che per loro natura si muovono di continuo.

Architetto
La mobilità diventa dunque il fil rouge dei suoi studi di architettura, che proseguono con la laurea e le esaltanti lezioni del visiting professor Konrad Wachsmann, alfiere della prefabbricazione e di strutture leggere estendibili a piacere. Ecco allora che le sue prime idee sul tema sono presentate all’ultimo CIAM di Dubrovnik del 1956, dove ottengono molto ascolto specie fra i più giovani. Qui presenta The Settlement Revolution, che è una critica radicale alla pianificazione urbanistica:
«L’autodeterminazione degli utenti fa funzionare gli insediamenti.
L’autodeterminazione degli utenti è migliore della pianificazione governativa. L’autodeterminazione degli utenti risolve problemi che i governi non possono risolvere…
La rivoluzione dell’insediamento è un “voto per atti”: gli utenti fanno ciò che i funzionari non fanno per loro. I problemi degli insediamenti non possono essere risolti da altri che non siano gli effettivi utenti».
Questo resterà il cuore del suo Manifeste de l’architecture mobile, pubblicato in ciclostile dopo il suo trasferimento a Parigi nel 1957 – nel frattempo il nuovo preside di architettura del Technion lo aveva cacciato perché riteneva le sue idee futili –, continuamente ristampato con aggiornamenti e distribuito non come libro, ma come brochure a lezioni, convegni e mostre che freneticamente organizza o è invitato a tenere in giro per l’Europa. Si costituisce così il GEAM, Groupe d’étude pour l’architecture mobile, che non avrà lunga vita perché schiacciato dalla personalità di Friedman che intanto ha modo di conoscere Jean Prouvé, Frei Otto, Constant e anche Le Corbusier, il suo idolo, che lo incoraggia ad andare avanti. Il primo a pubblicarlo in Italia è Alessandro Mendini, giovane redattore di “Casabella”. Ecco allora che si unisce a Michel Ragon, anche lui appena deceduto, animatore del GIAP Groupe International pour l’Architecture Prospective, al fianco di architetti come Paul Maymont e scultori come Nicolas Schöffer. Alle sue lezioni assistono da studenti i futuri componenti di Archigram, Bernard Tschumi e tanti altri cui vengono sottoposti concetti come l’Urbanisme mobile (1957) e la Ville spatiale (1959), vale a dire le idee più ambiziose e radicali dell’ottimismo tecnologico all’apice del modernismo che Reyner Banham inserirà retrospettivamente nel novero delle megastrutture, sebbene Friedman abbia sempre rifiutato questa categorizzazione perché a differenza di tutti gli altri prevedeva un grande margine di adattamento da parte degli abitanti.

Ville spatiale sopra Parigi, 1959.
Professore
Alla fine degli anni ’60 Friedman comincia la sua carriera di professore in numerose università americane, attirato soprattutto dalle possibilità offerte dai nuovi computer che allora erano grandi come una stanza e impossibili da usare in Europa, dove di norma erano riservati all’esercito. Discutendo processi di democratizzazione dell’architettura come il Flatwriter e i meccanismi urbani, confluiti nel volume dal titolo lecorbusieriano Per una architettura scientifica (Officina 1971). Friedman conosce così Nicholas Negroponte, laureato in architettura, che insieme al suo The Architecture Machine Group sviluppa un software per l’auto-progettazione da parte degli abitanti che chiama “The Yona System”.
Funzionario Unesco
Poi all’inizio degli anni ’70, Friedman comincia a occuparsi repentinamente solo di tecniche povere, tecnologie semplici e partecipazione, in linea con altri architetti e designer di quegli anni (Riccardo Dalisi, Enzo Mari, Ugo La Pietra, Victor Papanek, i Superstudio della cultura materiale extra-urbana ecc.) e comincia perciò a collaborare con l’Unesco in diversi programmi di autocostruzione dedicati ai paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa e India. Nascono così L'architettura di sopravvivenza. Una filosofia della povertà (1978) e Alternative energetiche (1982) pubblicati in italiano entrambi da Bollati Boringhieri così come Tetti (a cura di Andrea Bocco, Quodlibet 2017), che riunisce dispense sul riuso di materiali di scarto per l’edilizia destinate all’India, in specie alla zona di Madras/Chennai dove nel 1987 costruisce insieme con Eda Schaur il Museum of Simple Technology a scopo dimostrativo e didattico. In questo Friedman è stato anche un precursore della sostenibilità, nell’esplorazione di vie alternative a quelle imposte dal progresso tecnologico: «I problemi della casa non riguardano solo i poveri. Vogliamo proporre soluzioni interessanti per tutte le società. Ma poiché dobbiamo stabilire delle priorità, abbiamo privilegiato le tecniche accessibili alle persone più povere». Giancarlo De Carlo, che conosce dai tempi dei CIAM, lo pubblica sulla sua rivista “Spazio e società”.
Saggista
Tuttavia è forse Utopie réalisables, ripubblicato nel 2000 con la casa editrice L’éclat di Michel Valensi e Patricia Farrazzi che inaugura un lungo e solido sodalizio editoriale – sono loro infatti a dare finalmente una casa alle sue erratiche pubblicazioni –, il testo più ambizioso e un po’ la sua summa teorica. L’originalità di fondo di Utopie realizzabili (Quodlibet 2003) e di Come vivere con gli altri senza essere né servi né padroni (a cura di Franco Bunčuga, Elèuthera 2017), che colpì anche Ivan Illich, consiste nel trovare una posizione autonoma e molto personale. Tratta dell’organizzazione della società, ma a differenza di qualsiasi analisi sociologica rinuncia a utilizzare numeri e statistiche, rigettando anzi il concetto di uomo medio. Ciò che Friedman analizza è anzitutto il linguaggio e la comunicazione, con i relativi effetti che le loro storture comportano anche in termini di città e territorio. Se ad esempio la città rappresenta l’utopia per eccellenza, «forse persino la prima utopia umana realizzata», essa allora andrà intesa come sintesi di organizzazione umana (software) e territorio (hardware) alla luce dei due concetti intimamente correlati di “gruppo critico” e “villaggio urbano”. In questi due libri correlati – uno è infatti la trasposizione a fumetti dell’altro – è leggibile in controluce una vicinanza ideologica alle posizioni del Kulturzionism di Martin Buber, Moshe Sharett e altri, linea politica e culturale più conciliante verso la minoranza araba, ma perdente nella costruzione dello Stato d’Israele.

Fax di Alessandro Mendini, spedito dopo aver ricevuto una copia di Utopie realizzabili, 2003.
Artista
A cavallo del 2000, la sua figura intellettuale così anomala e originale fu scoperta dal mondo dell’arte contemporanea, si vedano le partecipazioni di Friedman a Documenta di Kassel nel 2002 o alle Biennali d’Arte di Venezia del 2003, 2005 e 2009, su invito di curatori come Catherine David, Hans Ulrich Obrist e Daniel Birnbaum. Nel 2006 al Mart di Rovereto e proprio quest’anno nelle gallerie Minini di Milano e Brescia, Maurizio Bortolotti ha curato delle retrospettive del suo lavoro in chiave artistica analogamente a quanto fatto da Hou Hanru al MAXXI nel 2017, da Caroline Cros e altri in vari musei francesi e dei Paesi Bassi o ancora da María Inés Rodríguez al MUSAC di Léon nel 2011. Singoli artisti vanno a trovarlo per affinità o per studiarne l’opera da vicino, come Camille Henrot, Margherita Morgantin, Stefano Graziani, Emmanuele Lo Giudice e molti altri. Sulla scia di questa nuova circolazione anche la cultura architettonica ha ricominciato a interessarsi del suo lavoro e la sua opera è tornata a essere discussa, come nel 2004 quando è stato ospite della Fondazione Targetti di Firenze, quindi analizzata nei manuali, sulle riviste come nella “Domus” diretta da Stefano Boeri (2004-2007) e rimessa in mostra (ad esempio da Nader Seraj e Cyril Veillon alla Galleria Archizoom dell’EPFL di Losanna nel 2012 e in “La città nuova/oltre Sant’Elia”, curata da Marco De Michelis a Villa Olmo di Como nel 2013), dopo essere praticamente sparita negli anni del postmoderno. Anche i suoi articoli, oltre ai libri, sono stati antologizzati e pubblicati in varie lingue vedi ad esempio l’antologia Pro Domo pubblicata da Actar nel 2006 in inglese e in spagnolo. Nel 2008 il Getty Center di Los Angeles ha acquisito tutto l’archivio cartaceo di Yona Friedman, accanto ai fondi di Aldo Rossi, Bernard Rudofsky, Lebbeus Woods, Pierre Koenig etc. Di recente A&Mbookstore Edizioni di Milano ha pubblicato il volume Untitled, a cura di Maurizio Bortolotti, Jean-Baptiste Decavèle et al.

L'ordine complicato. Come costruire un'immagine, Quodlibet 2011 (Fotografia di copertina di Stefano Graziani).
Fisico
Perciò, nei suoi ultimi anni Friedman, protetto dalla sua sorprendente casa-museo di Boulevard Garibaldi, ha se possibile intensificato la sua attività di conferenze, workshop, installazioni – soprattutto insieme con Jean-Baptiste Decavele –, senza rinunciare a disegnare, scrivere e realizzare brevi film d’animazione disponibili su Vimeo spesso a tema animale, in particolare ai cani – la Balkis Production è un omaggio al suo amato, ultimo cane. Uno dei suoi ultimi libri è stato L’ordine complicato. Come costruire un’immagine (Quodlibet 2011), un testo in cui affronta la fisica teorica, materia che lo ha sempre nutrito sin dai tempi di Heisenberg, dove nell’introduzione c’è un passo che ha l’aria di un testamento: «Io non conosco la realtà, ma mi sembra che la si possa affrontare solo con l’immagine. È ciò che fanno i cani, ma che può capitare di fare anche a noi. L’intera storia dell’umanità può essere rappresentata da una sequenza di immagini. Architettura: saper costruire. Non solo degli edifici: il campo è più vasto. Si parla di architettura di un romanzo, di una sinfonia, ma anche del corpo umano o del diritto romano. L’uso del termine “architettura” è frequente, in relazione a un sistema informatico. “Architettura” significa anche assenza di regole prestabilite: è essa stessa a condurre alla creazione di regole. “Architettura” implica una costruzione strutturata, una costruzione bastante a se stessa. È questo che ho cercato di fare in queste pagine. Non so se le mie proposte siano giuste o sbagliate, ma ho fatto il possibile per renderle coerenti. Una costruzione ha il dovere di esserlo».
Presentologo
Ci sarebbero ancora molte cose da raccontare su Yona, su quanto detestasse essere definito utopista o futurologo (“sono un presentologo!”), sul suo amore per sua moglie Denise Charvein che lo aiutò moltissimo specie nelle sue pubblicazioni o ancora sulle sue predilezioni, come ad esempio la città preferita che, mi disse una volta, era senza dubbio Sana’a, la martoriata capitale dello Yemen, sublime esempio di “architettura senza architetti” (Rudofsky, il suo architetto preferito) che ricorda moltissimo i suoi progetti, ricchi di semplici decorazioni. O di quella volta nello studio losangeleno di Frank Gehry, dove seminò il panico tra gli assistenti e le segretarie armeggiando il plastico di uno degli ultimi mastodontici edifici disegnati dall’architetto canadese, apostrofandolo «ma questa facciata non si muove, costa così tanto e neanche si muove, stai sbagliando tutto Frank, lo sai?», e lui, preso alla sprovvista, balbettava che no, la gente si sarebbe spaventata, l’assicurazione non avrebbe capito, insomma non era proprio possibile… «Everything is possible!» fu la risposta serafica che non ammetteva obiezioni.
Ciò che più conta è che i suoi concetti e progetti, in maggior parte ancora inattuati, al contrario delle soluzioni mainstream del passato, restano vivi e pronti all’uso come dei semi per risolvere i problemi insoluti del nostro presente e dunque, resta valida anche per lui l’antica poesia di Avraham Ben Yitzhak: «beati coloro che seminano e non raccolgono».
Camminando verso la Galleria Giò Marconi per visitare la mostra Qualcos’altro, mi sono chiesta che senso possa avere oggi visitare una mostra di monocromi. La prima ragione è evidente: per uno studioso o un appassionato, una mostra di questo stampo ha un valore documentale indiscutibile, permette di inquadrare l'esperienza di un artista in una prospettiva situata, testimoniando una fase specifica della sua produzione. Ma per un visitatore che non abbia un’urgenza di studio, quale può essere la ragione, il senso di visitare una mostra di monocromi degli anni '60 nel 2020? Non si tratta forse di un momento pienamente documentato delle avanguardie del secondo Novecento, analizzato sin nei minimi dettagli e in un certo modo ormai cristallizzato, inchiodato sulla carta come una farfalla da uno spillo?

Mario Schifano, Qualcos’altro 22.01.2020 – 20.03.2020, Installation view Gió Marconi, Milan, photo: Filippo Armellin Courtesy: Gió Marconi, Milan.
Il nucleo di opere presentate in mostra da Alberto Salvadori, in collaborazione con l’Archivio Mario Schifano di Roma, è compreso tra il 1960 e il 1962, quando l’artista ha già alle spalle alcuni esperimenti informali. Gli smalti su carta intelata selezionati da Marconi alternano monocromi e opere a due tinte: alcuni di questi risalgono alla celebre collettiva 5 pittori del 1960 alla quale partecipano Franco Angeli, Tano Festa, Francesco Lo Savio e Giuseppe Uncini, tenutasi presso la galleria La Salita di Gian Tomaso Liverani, all’epoca punto di riferimento della scena informale.
Lo stesso gruppo di artisti aveva già esposto alla galleria Il Cancello di Bologna con una presentazione curata da Emilio Villa, mentre la mostra a La Salita è accompagnata da un testo di Pierre Restany, teorico del Nouveau Réalisme vicino a Yves Klein e Jean Fautrier. Si tratta di un passaggio storicamente significativo perché la collettiva rappresenta un momento seminale nella produzione dei cinque artisti e li attesta come gli alfieri della nuova scuola romana. Restany, già critico verso un movimento informale che ritiene ormai stanco, restituisce un ritratto dei cinque artisti in divenire, sospesi tra il Neo Dada e, appunto, il Nouveau Réalisme, un ritratto di “nuovi pragmatisti”, liberi dal gravame sentimentale dell’informale e orientati verso una nuova concretezza. Ed è proprio Restany che propone a Liverani i lavori di Schifano, che nel 1960 ha ventisei anni e lavora in uno studiolo su una terrazza di Piazza Scanderberg: è lì che lo vanno a trovare la gallerista Ileana Sonnabend, Leo Castelli e Robert Rauschenberg, vicino a Piazza del Popolo e a quel Caffè Rosati che è il luogo di ritrovo dell’avanguardia intellettuale durante una breve, luminosa stagione di fioritura culturale che non avrà eguali nella storia della città. Roma è finalmente una piazza di respiro internazionale (con epicentro Burri, in pieno dialogo con la Milano di Lucio Fontana) grazie alle produzioni hollywoodiane che hanno colonizzato Cinecittà, e diventa meta del turismo colto statunitense: Roma e New York si scoprono all’improvviso allineate, accomunate da intuizioni simili e da ricerche che si muovono verso un deciso superamento dell’astrazione, alla spasmodica ricerca di nuovi modi di fare figurazione.
La mostra alla Salita è la prima mostra importante di un giovane Schifano, figlio di un archeologo, restauratore del Museo Etrusco di Valle Giulia e artista posseduto dalla pittura. A differenza di altri, è un artista che procede in maniera individualistica, seguendo una traiettoria autonoma, refrattario a qualsiasi vincolo. Schifano vede il lavoro di Jasper Jones e Rauschenberg sulle riviste dell’epoca che circolano tra gli artisti, è già consapevole del valore delle proprie ricerche. Nel biennio ‘60 – ‘62 la sua produzione è intensa e radicale: realizza degli “schermi” sui quali stende la pittura, una vernice sonora, grezzamente vitale, tutta di superficie. Sono opere che arrivano dopo i lavori con la terra e le pitture-cemento, ed emergono in una fase di rapida evoluzione, segnata dal richiamo del colore che lo guiderà verso la successiva figurazione. Schifano “l’irregolare” procede in maniera libera, apparentemente casuale, cerca qualcosa che è nella superficie del dipinto, incastrato nelle piccole irregolarità delle campiture di colore, nel dialogo gestaltico tra primo piano e lo sfondo, nei segni, nelle campiture e colature. Trova ciò che sta cercando guardando attraverso l’obiettivo di una Rolleiflex che chiede in prestito proprio a Uncini. La visione attraverso il filtro della macchina fotografica è una folgorazione che lo accompagnerà per tutto il resto della carriera ed è lì che si innesca, lì che trova una prima incarnazione nelle carte verniciate che anticipano alcune istanze ancora in nuce. I monocromi rappresentano il punto sorgivo di quella linea ascendente che porterà Schifano a brillare come una stella cometa, assunto nel cielo della sua mitologia, e poi lo condurrà lungo una traiettoria di caduta, giù nel delirio da tossico e delle opere buttate via, le copie, i falsi e tutta l’incredibile vicenda esistenziale che per anni ha messo in ombra il valore di una produzione che non ha equivalenti ma solo epigoni.

Mario Schifano, Qualcos’altro 22.01.2020 – 20.03.2020, Installation view Gió Marconi, Milan, photo: Filippo Armellin Courtesy: Gió Marconi, Milan.
Tornando al punto originario, Giuseppe Uncini racconta della comune idea di lavorare sul monocromo: «non importava più il disegno, non importava più niente. In un certo io c’ero già arrivato, già lavoravo con il cemento. Lui, più pittore di me, faticò parecchio ad abbandonare l’idea del colore, del disegno, del quadro, però lasciò tutto e ricominciò con una piccola tela. Sì, iniziò con un piccolo quadretto, stese dello smalto nero e nella stesura lasciò alcune parti leggermente scoperte. Era una pittura un po’ tirata via, molto disinvolta, quasi una strafottenza, un “me ne frego”.» (Luca Ronchi, Mario Schifano, Una biografia, Johan & Levi Editore, 2012, pag. 25-26)
Il monocromo è quindi il punto di azzeramento, il grembo da cui nasce il corpo pittorico di Schifano, ed è un tentativo di assumere una prospettiva che offra un’apertura a nuove germinazioni. Non si tratta però di una novità assoluta: è stato esplorato da Yves Klein, Piero Manzoni, Alighiero Boetti, Piero Dorazio, Tano Festa, Enrico Castellani, Lucio Fontana, Fabio Mauri e poi Ad Reinhardt, Barnett Newman e gli americani: Schifano cerca una propria strada, che si concretizza in una serie di opere già distanti dall’informale ma anche dalla pittura gestuale, che pure rimane una componente del suo lavoro. In queste opere il dinamismo, la velocità sono presenti ma allo stato solido, testimoniano l’istante prima che l’azione si compia. Mantengono ancora una relazione con la materia, una matrice culturale radicalmente europea e italiana che non si perderà mai del tutto e che segnerà una via tutta italiana alla pop art. Il colore coprente talvolta lascia spazio a delle aree nude, rimanda a un’idea dello schermo ma senza ricorrere alla tautologia: Schifano cerca un’evidenza, un’immediatezza propria dell’immagine fotografico-pubblicitaria ma per tradurla in un linguaggio personale, modellando pittoricamente una forma ancora in fieri. La sua è un’affermazione che non dice, è un paradosso. Da lì si irraggia una domanda che non si esaurisce con il passare del tempo e non riguarda l’assenza di figurazione. Non tutti i monocromi sono uguali, anzi ogni monocromo lo è a modo suo, per parafrasare Tolstoj, e i lavori di Schifano sembrano gravidi di tutto quello che verrà dopo: le palme, l’utilizzo delle scritte e dei loghi, le stelle, le foto dipinte, i paesaggi anemici, le tele emulsionate, i deserti, i televisori, i film impossibili. In fondo, in queste carte è già contenuta in potenza tutta l’iconografia che l’artista partorirà successivamente, quella urgenza espressiva che lo rende un artista bulimico, capace di bruciare tutto fino ad arrivare a negare la pittura stessa in favore di un’immagine meccanica, svuotata di sé, per poi giungere a una inaspettata rinascita negli anni ‘80, fino agli ultimi, misteriosi quadri scuri, che rappresentano una meditazione conclusiva sulla pittura e chiudono idealmente il percorso inaugurato proprio con i monocromi.
Tra gli Untitled e le opere dai titoli poetico-ironici come Vero amore incompleto, Qualcos’altro, Tempo moderno (tutte del 1962) scorre una palingenesi pittorica. Il rapporto con Marconi risale proprio agli anni ‘60, quando il gallerista vede i suoi lavori e lo mette sotto contratto in esclusiva, ma il menage si rivela subito complicato: Schifano non rispetta gli impegni, vende i quadri in autonomia, è imprevedibile; alle spalle ha già la brutta rottura con la Sonnabend, che gli chiede continuità produttiva proprio sui monocromi. Nel 1963 la mostra Tutto Schifano alla galleria Odyssia segna l’approdo alla pop art e dal 1965 realizza con Marconi una serie di mostre importanti, un ciclo che si interrompe nel 1970 dopo una fuga nel sud est asiatico dell’artista. Fa tutto parte della leggenda, di un’esistenza senza misura, nei fatti completamente votata al lavoro. Cosa rimane oggi di quella vicenda, di tutte le singole fasi della storia pittorica di un artista larger than life, e andando a osservare con la lente d’ingrandimento, cosa rimane di un solo biennio, il ‘60 – ‘62, quando l’artista è affacciato al successo, scattato come un corridore dai blocchi di partenza?
Forse una possibilità di risposta è nelle opere ostese nello spazio asettico della galleria. Silenziose, illuminate con una certa crudezza, ritmate dai blocchi di colore che avanzano verso lo spettatore, sembrano chiuse in sé stesse e invece sono germinative: in quello spazio-tempo che salda ciò che è prima e tutto quello che viene dopo, in quella condizione privilegiata di virtualità, risiede ancora un senso per chi guarda oggi. È il qualcos’altro che parla, come una memoria che agisce sul presente – una rammemorazione –, è quello che rimane fuori dall’opera e che non trova spiegazione. È come osservare una cellula da cui nasceranno altre cellule e poi una forma di vita complessa: nello spostamento dal sé a un sé potenziale, in un’evidenza che rimane permeata di mistero, è possibile rinvenire un’energia, una forza pristina, ancora intatta, che parla al dì là del tempo e dello spazio contingenti.
Oggi l’idea dell’immagine che vive attraverso uno schermo assume un valore completamente diverso da ciò che fu negli anni ‘60 ma l’intuizione originale risulta, se possibile, ancor più significativa. Se nella prima visione di Schifano il filtro dei media modellava le forme e intratteneva con esse un rapporto dinamico, oggi non vi è più distinzione tra le immagini e i dispositivi che le producono, così come si è dissolto il confine percepito tra immagine e realtà fattuale. Lo stesso artista ha indagato l’idea del flusso visivo per tutta la propria carriera, abbandonandosi volontariamente alla corrente delle immagini prodotte dai mass media, a tratti smarrendosi per poi riconquistare il controllo delle proprie visioni attraverso l’esercizio della pittura. Lo salva una forma di grazia che si manifesta come un balenare di luce nelle sue opere, e che fa sì che Schifano riesca a danzare con le immagini senza esserne mai fagocitato, senza annegare in un oceano di fantasmi. Tornando ai monocromi, a quelle composizioni dense ed elementari appartiene un modo di guardare che oltrepassa il corpo delle cose da parte a parte e riesce a restituircene il senso. In quell’apparente stallo che si traduce in un istante dilatato, che continua infinitamente ad accadere, si pongono le condizioni affinché le forme vengano separate dal flusso indistinto del visibile e tornino a vivere non come simulacri ma restituite al mondo con una nuova presenza, rinate. Uno spazio che avvolge l’accadimento della visione e che congiunge l’inizio e la conclusione dell’esperienza pittorica di Schifano. Lì ha ancora senso guardare, anche oggi.
«Là dove la luce che dà forma ai volti e alla vita e alle immagini fotografiche e mentali del mondo si presenta finalmente per quello che è. Dove c’è solo questo plasma di luce e tutti i volti e le persone e le cose e le forme e le loro immagini stanno dentro quel bagliore che cancella le forme e le identità delle forme. Non si vedrà più niente, ci sarà solo la catastrofe della luce.»
(Antonio Moresco, Lo sbrego, SEM, 2019).
Il regista Liev Schreiber racconta che quando morì il nonno, nel 1993, decise di cominciare a scrivere una storia della sua vita “nella speranza che potesse in qualche modo guidare la mia e creare una testimonianza più permanente della sua”. Però, ben presto, si accorse che i suoi scritti avevano “assunto la forma di un road movie in cui un giovane americano si reca in Ucraina in cerca del proprio patrimonio culturale”. Alcuni anni dopo, imbattutosi nel romanzo Ogni cosa è illuminata di Jonathan Safran Foer, è “rimasto stupito dalle analogie tra la mia storia e la sua”. Per queste similitudini concluse di realizzare la trasposizione cinematografica del romanzo. Così, romanzo e film, diventano un viaggio nella memoria, una metafora del ricordo, la necessità di non dimenticare la Storia e, soprattutto, le storie delle persone comuni segnate dagli accadimenti della vita. Sono gli stessi intenti e propositi rintracciabili nella scelta di organizzare la mostra I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970, al MADRE - Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, fino al 13 aprile 2020.

I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970 Veduta della mostra al Madre·museo d'arte contemporanea Donnaregina, Napoli Courtesy Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Napoli Foto ©Amedeo Benestante.
Sebbene l’obiettivo della retrospettiva non sia quello di celebrare il genius loci né, tanto meno, Marcello Rumma tout court, l’esposizione, per alcuni aspetti, è un prezioso, quanto dovuto, atto di riguardo nei confronti di un importante protagonista del panorama culturale degli anni Sessanta, sia locale che nazionale, promotore di inedite quanto rivoluzionarie attività i cui esiti sono tuttora individuabili. Il principale dichiarato intendimento è quello di attivare una riflessione critica coerente, per ri-sistemare e ri-ordinare la storia, ri-attivando il ricordo che costruisce il tessuto dell’identità.
Come in un percorso nella memoria, con pareti grigie e un’illuminazione che cambia di intensità allorquando si posa sugli elementi esposti, la mostra si articola su più livelli che corrono paralleli. Mediante un racconto rigorosamente scientifico, cronologicamente minuzioso, intimo e collettivo allo stesso tempo, è tracciata una storia locale e generale e, contemporaneamente, è disegnato il ritratto di un uomo, Marcello Rumma (Salerno, 1942-1970), figura centrale nel dibattito culturale alla fine degli anni Sessanta. Di sala in sala, gli aspetti personali e pubblici di Marcello Rumma si confondono e si sovrappongono di continuo, in un costante e ininterrotto intreccio tra privato e sociale, con i suoi progetti editoriali ed espositivi, accompagnati dalla sua costante e brillante attività di collezionista. Nello sviluppo narrativo, i curatori Gabriele Guercio con Andrea Viliani, hanno sapientemente distribuito opere, pubblicazioni, missive, fotografie (tra le quali, quelle di Mimmo Jodice, Ugo Mulas, Claudio Abate), articoli di giornali, pubblicazioni, libri, riviste, che delineano il ritratto privato di Marcello Rumma, mai disgiunto da quello pubblico.

I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970 Veduta della mostra al Madre·museo d'arte contemporanea Donnaregina, Napoli Courtesy Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Napoli Foto ©Amedeo Benestante.
Da subito, colpiscono i numeri: ben undici sezioni, più una – la zero, spalmate in ventinove sale, suddivise tra il terzo e il secondo piano del museo, con più di settanta opere d’arte provenienti anche dalla Collezione Rumma, intervallate, come detto, da una messe di materiali per delineare, con un ordine finemente cadenzato, un arco di tempo di appena sei anni. Sei anni intensi, pieni e produttivi, quasi vissuti per raccontarli, che vedono Marcello Rumma svolgere un ruolo di primo piano a soli ventitré anni fino alla sua prematura scomparsa a ventotto anni. Anni che, come detto, hanno segnato la vita culturale della città campana e della storia dell’arte in generale. Perché, tra le diverse attività che la brillante e fervida mente di Marcello Rumma portò avanti, fondamentali, e ormai veri capisaldi, sono le tre edizioni della Rassegna di Arte Internazionale organizzate in una città e in un luogo del tutto impensabili per quel periodo, completamente fuori da tutti quelli che allora erano i circuiti espositivi conclamati: gli Antichi Arsenali della Repubblica, ad Amalfi. Qui riunì artisti e critici che divennero, da lì a poco, il gotha dell’arte contemporanea. Risale al 1966, Aspetti del “ritorno alle cose stesse”, a cura di Renato Barilli (una riflessione sulla pittura che coinvolse, tra i vari artisti, Giosetta Fioroni, Tano Festa, Titina Maselli, Mario Schifano); al 1967, L’impatto percettivo, curata da Alberto Boatto e Filiberto Menna (incentrata sulla percezione delle più recenti produzioni artistiche, con Robert Indiana, Jasper Johns, Andy Warhol, Roy Liechtenstein, Piero Dorazio, Enrico Castellani); al 1968 Arte Povera più Azioni Povere, a cura di Germano Celant, una sorta di definitiva consacrazione dell’Arte Povera, soprattutto in uno spazio pubblico, dopo le sue apparizioni nelle gallerie La Bertesca di Genova e de’ Foscherari di Bologna, con Giovanni Anselmo, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Mario e Marisa Merz, Giulio Paolini, Pino Pascali e Gilberto Zorio, Richard Long, Paolo Icaro, Michelangelo Pistoletto, Alighiero Boetti (nel 2018 il Castello di Rivoli ha dedicato una mostra a questa edizione).
La distanza temporale, ha permesso di comprenderne appieno la portata di quelle iniziative. "Marcello Rumma l'ho incontrato direttamente ad Amalfi, in occasione della mostra Arte Povera più Azioni Povere, pur avendolo conosciuto pochi giorni prima a Torino– ha dichiarato Giovanni Anselmo, in occasione della mostra. Non c'erano quindi tra noi rapporti così stretti. Mi è dispiaciuto non aver approfondito la sua conoscenza, in virtù dell'evento da lui organizzato, che si è poi rivelato essere di notevole importanza per l'epoca. Ricordo una mostra piena di energia, ma direi anche "avventurosa", perché non c'era nulla di preorganizzato; gli artisti, quando arrivavano, occupavano lo spazio che c'era e che meglio si confaceva con le loro opere cercando di non interferire troppo con quelle dei colleghi". Per Renato Barilli, Marcello Rumma “si sentiva un po’ cinto d’assedio dai concittadini emersi o emergenti, in genere appoggiati all’ambiente di Roma. Volendo organizzare mostre, ragionò al modo dei Comuni medievali, per la cui direzione si ricorreva a un podestà residente in altro luogo, per non dover scegliere tra le varie fazioni locali. Per questo si rivolse a me per Ritorno alle cose stesse – titolo ripreso da Edmund Husserl – di Amalfi, per la quale adottai una visione inclusiva applicata alla Pop Art, coinvolgendo artisti di Pistoia, Milano, Torino, con una critica verso i colleghi romani animati da un eccesso di “purezza” nelle loro scelte. Linea seguita da Marcello Rumma che, infatti, acquistò un dipinto di Domenico Gnoli, nonostante molti gli suggerirono di liberarsene. Una collaborazione la mia che non si limitò solo all’edizione del ’67 ma si protrasse anche in quella del ’68, suggerendo come curatore Germano Celant, allora alle prime battute”.

I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970 Veduta della mostra al Madre·museo d'arte contemporanea Donnaregina, Napoli Courtesy Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Napoli Foto ©Amedeo Benestante.
Anni frenetici, intensi, ricchi, che trovarono, nel territorio campano, un terreno fertile. Non si deve dimenticare che a Napoli si estendeva il regno di Lucio Amelio (anch’egli celebrato al MADRE con una mostra nel 2015) con la sua Modern Art Agency aperta nel 1965. Con Amelio collaborò, come socio, dal 1970 al 1974, Pasquale Trisorio allorquando, con la moglie Lucia, fondò Studio Trisorio (è di questi giorni la pubblicazione del volume Studio Trisorio una storia d’arte che ne ripercorre i quarantacinque anni di attività). Nonché la presenza di autorevoli collezionisti quali Vittorio Baratti, Peppino Di Bennardo, Renato e Liliana Esposito, Graziella Lonardi Buontempo, Giuseppe Morra.
Una mente, quella di Marcello Rumma, che correva veloce, come la sua fluttuante scrittura delle lettere indirizzate ad artisti e curatori. Sempre impegnato in molteplici progetti. A Salerno, nei primi anni Sessanta, affianca il padre Antonio Rumma nella gestione del Collegio Parificato Arturo Colautti di proprietà della famiglia Rumma, fondato nel 1935. È da qui che prenderanno avvio le sue prime iniziative culturali, a partire dai cambiamenti che apportò al sistema educativo, attraverso un sistema di esperienze di vita comunitaria con una “didattica aperta”, una sorta di Bahaus italiana.
Nel 1965: dà alle stampe il numero unico di Il Ponte, Rapporti e Nuove Angolazioni, tre riviste scolastiche, osannate anche dalla stampa con titoli del tenore “Miracolo scolastico in provincia di Salerno”, nelle quali l’arte ha un ruolo dominante, come chiaramente esplicitato già dalle copertine: Arbre des lentes insomnies, 1964, di Guido Biasi, acquistata qualche mese prima dallo stesso Marcello Rumma, su Il Ponte; Da una storia di mio nonno, 1965, di Bruno Donzelli su Rapporti; Gran Cairo, 1962, di Frank Stella su Nuove Angolazioni; riviste che vedono raccolti interventi di intellettuali del calibro di Edoardo Sanguinetti o Eduardo De Filippo. Finanzia una squadra di calcio. Apre una sala cinematografica. Fonda il Colautti Club, poi trasformato in Centro Culturale Colautti.
Nel 1966: organizza la già citata prima Rassegna di Amalfi.

I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970 Veduta della mostra al Madre·museo d'arte contemporanea Donnaregina, Napoli Courtesy Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Napoli Foto ©Amedeo Benestante.
Nel 1967: nel suo appartamento a Parco Persichetti, insieme alla moglie Lia Incutti Rumma, dà avvio alla sua collezione d’arte, aperta alle più innovative proposte artistiche dell’Arte Povera e della Pop Art; organizza la seconda edizione della Rassegna di Amalfi, affiancata dal convegno della critica d’arte Lo spazio dell’arte d’oggi, con i preziosi contributi di Barilli, Calvesi e Menna; la Prima Rassegna Nazionale dell’Incisione Contemporanea, a cura di Maurizio Calvesi, Germano Celant e Filiberto Menna, nella Hall del Teatro Augusteo, e la Prima Rassegna di Scultura Italiana Contemporanea, a cura di Renato Barilli, Gillo Dorfles e Filiberto Menna, sotto i portici del Palazzo Comunale; assume la direzione artistica dello spazio espositivo dell’Agenzia Einaudi 691, ricavato appunto all’interno della libreria Einaudi.
Nel 1968: oltre alla terza edizione della Rassegna di Amalfi, organizza Ricognizione cinque, un ciclo di cinque mostre personali di artisti affiancati da cinque critici, in cinque mesi, a cura di Angelo Trimarco, il cui catalogo, stampato dal Centro Studi Colautti, vede i testi dei critici accostati a quelli degli artisti, in un costante dialogo tra arte e critica; rassegna abbinata al convegno L’Assemblea della Libera Repubblica dell’Arte, quasi in contrapposizione a quanto accadeva alla XXXIV Biennale di Venezia (in mostra è esposta la foto di Ugo Mulas con la celeberrima “decisione” di Pino Pascali di ritirare le sue opere dalla Biennale; una piccola nota di colore: nel firmare la sua attestazione, Pascali riporta come indirizzo i codici postali Venezia e EUROPA); fonda la Casa Editrice Rumma che, oltre alle collane Saggi e Saggidue, tra i numerosi progetti, annovera la traduzione italiana di scrittori e filosofi europei come Jean Paulhan, Eugen Fink, Marcel Duchamp (Marchand du Sel), la pubblicazione di L’uomo nero, il lato insopportabile di Michelangelo Pistoletto.

I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970 Veduta della mostra al Madre·museo d'arte contemporanea Donnaregina, Napoli Courtesy Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Napoli Foto ©Amedeo Benestante.
Tappe biografiche che si rincorrono, che freneticamente si sovrappongono, quasi in costante affanno, ricostruite nella mostra dove, però, si percepisce una serena e imparziale atmosfera che calorosamente accoglie e accompagna il visitatore nella scoperta e conoscenza “di un sognatore che ha dimostrato che con la tenacia e la perseveranza, i sogni si possono concretizzare”, come ama dire Lia Rumma. Sogni evidenti già nella prima sala, significativamente denominata Punti di origine, dove troviamo come una summa dell’intero arco della sua vita: una cartolina di Parigi dove a soli quattordici anni Marcello Rumma si recò, grazie ai suoi risparmi, per visitare e vedere dal vivo le opere d’arte del Louvre; l’olio su carta Periferia, di Renzo Vespigani, la prima opera acquistata da Marcello e donata all’allora fidanzata Lia (conosciuta proprio lungo i corridoi del Collegio, nel quale Lia, neo laureata, inizia a insegnare latino) che segna l’inizio di tutta l’avventura culturale e collezionistica; l’olio su tela Natura morta di Mario Carotenuto che lo stesso artista donò alla coppia come regalo di nozze nel 1967; una piccola foto della famiglia Rumma, con la mamma Renata Ricciardi e il papà Antonio Rumma; una cartolina del Collegio Colautti e la raccolta di poesie verrà questa sera … del fratello maggiore Gianni Rumma morto nel 1961 e pubblicate nel ’67 da Rumma Editore. Un allestimento equilibrato, dove le opere sono ben bilanciate dai materiali di archivio i quali, a loro volta, sono disposti in leggii e in teche agevolmente fruibili, con un buon apparato didascalico e pannelli esplicativi di introduzione a ciascuna sezione, affidati a storici-critici-curatori distinti. Di sala in sala aumenta la sensazione di conoscere sempre meglio Marcello Rumma, i suoi progetti e la sua sfera affettiva (attraverso le foto con Lia o durante alcune cerimonie o durante i convegni) e, allo stesso tempo, di ritrovarsi immersi in quell’atmosfera di grandi fermenti e cambiamenti, uscendo così con la sensazione non solo di aver approfondito in maniera dettagliata un periodo storico per molti versi ancora aperto, nonché il deus ex machina di tutto questo fermento, fulmineamente interrotto nel 1970.
E, dopo un anno di smarrimento, Lia Rumma, che sin dall’inizio ha seguito Marcello “incuriosita da quello che accadeva intorno a noi, dall’interesse di Marcello per l’arte contemporanea, avendo una formazione classica, ero intrigata dai nuovi linguaggi artistici che Marcello afferrava immediatamente: lui guardava, capiva e comprava. Per questo viaggiavamo molto, allacciando buone relazioni con artisti, galleristi. La nostra casa era sempre aperta a tutti: l’ultima stanza, la sala da pranzo, in fondo al corridoio, era sempre apparecchiata per accogliere chiunque venisse a farci visita. Perché per Marcello era fondamentale, sempre, il contatto umano, con gli artisti, col pubblico. E non si preoccupava del valore che quel lavoro poteva avere piuttosto di un altro, per lui quello che contava veramente era che il lavoro piacesse a lui”. Lia prende in mano le redini di quanto finora compiuto e, trasferitasi a Napoli, apre nel 1971 la sua galleria. Il resto è già storia. E l’emozione nella sua voce e nei suoi occhi nel parlare di Marcello e di questa mostra indica il senso che l’intera esposizione ha per lei: un viaggio durante il quale “mi sono ritrovata con Marcello e ci siamo salutati”.
I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970
Madre_Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, via Luigi Settembrini 79 - Napoli
fino al 13 aprile 2020
orari: chiuso martedì; lunedì e da mercoledì a sabato 10.00 – 19.30; domenica 10.00 – 20.00
biglietti: intero € 8.00, ridotto € 4.00 (gratuito prima domenica del mese)
Livorno ha ospitato la mostra “Modigliani e l'avventura di Montparnasse”, dedicata al “suo” artista più famoso. Nonostante il successo, non si è trattato però della fine di un lungo esilio (lo slogan sottinteso era quello del “ritorno del figliol prodigo”), perché certi esili non possono mai finire. Ed è bene sia così.
Un tempo, trent'anni fa, era possibile salire su un treno a Livorno (verso le sette, o le nove di sera, non ricordo bene) e si arrivava la mattina dopo alla Gare de Lyon. Oggi non si può più fare. Bisogna andare prima a Firenze, poi a Milano, e da Milano raggiungere Parigi attraversando la notte. Persino cento anni fa il collegamento tra Livorno e Parigi era più diretto, non solo in senso ferroviario. Chi conosce bene la piccola città toscana sa che un po' di Parigi aleggiava anche lì, magari cogliendo un riflesso dello stile liberty nella decorazione di un lampione, in una prospettiva di palazzi affacciati sul mare con un gesto che sa (sapeva) di belle époque.

Modigliani, ph Claudia Cei.
A Livorno neppure le bombe sono riuscite a spazzare via quel gesto, a cancellarlo completamente. Chi volesse trovare ancora un'aria di Parigi può per esempio visitare il cosiddetto “Scoglio della Regina”, dove nel 1846 sorgeva un bagno pubblico esattamente nel luogo in cui Maria Luisa di Borbone, ce lo racconta un sito dedicato, “aveva effettuato alcune balneazioni in una piccola piscina coperta solo da tendaggi”. Oggi lì c'è un polo di ricerca nel settore delle tecnologie per il mare. Ma a Parigi non c'è il mare, anche se, mediante la cipria turchese diffusa tra le strade e i tetti, potremmo quasi presentirlo. E allora poniamo Parigi sul mare, sul versante di un cenno disposto a farci veleggiare altrove. Modigliani, vedrete, ci aspetta già sul contorno di un'idea, quella dell'esilio, che ha bisogno di essere penetrata da dialoghi immaginari.

Ph Andrea Dani.
“Credo che pochi siano arrivati in una città sconosciuta, miseri e disarmati come me”. Queste parole non sono di Modigliani, ma di Gino Severini, altro artista toscano che in quel torno di anni (appena svoltato il XX secolo) si dirigevano verso la capitale francese per trovare una fonte d'ispirazione e una possibilità di realizzazione. Siamo nel 1906. Il livornese è arrivato lo stesso anno, dopo aver toccato Capri e Venezia, e l'incontro con Severini si materializza secondo la sceneggiatura più prevedibile: “Salivo per la rue Lepic per andare verso il Sacro Cuore – racconta Severini (La vita di un pittore, Feltrinelli, pag. 34) –, quando, di fronte al famoso ballo del Moulin de la Galette, m'incrociai con un altro giovanotto bruno, con un cappello che soltanto gli italiani sanno o possono...; ci guardammo bene in viso, e poi, alcuni passi dopo, ci rivoltammo ambedue e tornammo indietro. Le solite parole che si pronunciano in questi casi, e forse non ce ne sono altre, sono queste: «Lei è italiano, mi pare?» al che si risponde: «Certo, e anche lei, ne sono sicuro». Ci affrontammo dunque, presso a poco così; ma poi c'informammo a vicenda che eravamo pittori, che eravamo toscani, e che si abitava a Montmartre”. Due esiliati, Severini e Modigliani, o per meglio dire due espatriati verso la patria dell'arte, perché quella era la via, se non si voleva restare impigliati in una tradizione locale, in Toscana praticata dagli infiniti pittori post-macchiaioli, che cominciava già a mostrare la corda.

Ph Andrea Dani.
Anche un cantautore come Vinicio Capossela, che a Modigliani ha dedicato uno dei suoi brani migliori (“Modì”), non può fare a meno di evocare l'esilio, quando parla di lui: “... perché Livorno dà gloria / soltanto all'esilio / e ai morti la celebrità”. Ma di cosa è fatto un esilio, e soprattutto: quanto può durare? Un altro dialogo possibile è quello tra il pittore e l'assessore di Livorno. Quando, in seguito al cambio di giunta (finito l'esperimento pentastellato), lo scorso anno la nuova amministrazione cittadina ha dovuto affrontare il tema delle celebrazioni per il centenario della morte del “suo” artista più famoso, Simone Lenzi, nuovo assessore alla cultura, ha visto che c'era un grosso nodo da sciogliere. Già una volta, nel 1984, la città aveva tentato di riappropriarsi di quel figlio perduto, ma era finita con un disastro di risonanza mondiale. Sulla “beffa”, sulle false sculture gettate nei fossi, oggi sappiamo che in realtà si trattò di qualcosa di molto più fosco di un semplice scherzo. Dietro le facce burlone dei livornesi appaiono maschere grottesche, dai riflessi criminali. “Attenzione, chiunque si occupa di Modigliani viene colpito dalla maledizione”, ha ricordato Claudio Strinati, per anni consulente degli Archivi Legali Modigliani, a Dania Monfini e Claudio Loidice, che hanno cercato di ricostruire la vicenda complessiva di interessi e falsificazioni intessuta all'eredità del pittore (L'affare Modigliani. Trame, crimini, misteri all'ombra del pittore italiano più amato e pagato di sempre, Chiarelettere, pag. 67). Il rischio, lo sapeva bene l'assessore, sarebbe stato però quello di far mancare a Livorno l'occasione di una riappacificazione, di far cioè perdere a Modigliani ancora il treno, stavolta però non per Parigi, ma da Parigi, cioè quello del suo viaggio di ritorno.

Ph Andrea Dani.
In realtà lo stesso Simone Lenzi conosce il tema dell'esilio. Ne dà conto in un libro (In esilio. Se non ti ci mandano, vacci da solo, Rizzoli) che avrebbe meritato più fortuna. Autoconfinatosi in un “paesello” dell'entroterra pisano, scriveva l'assessore in quel volume uscito due anni fa: “Io non so ancora che fine faccio, e neanche so dire esattamente quando ho cominciato a fare la fine che faccio. Ma sono certo che sto facendo una fine” (pag. 11). La fine che hanno fatto più o meno tutti gli assessori al turismo e alla cultura di Livorno, prima di lui, era quella di languire nell'impotenza a causa di una maledizione che, evidentemente, non ha a che fare solo con quella di Modigliani. Lenzi aveva peraltro già affrontato l'argomento in un altro suo libro, centrato sull'immobilismo che sembra affliggere chiunque abbia voglia di realizzare qualcosa in una città sinora vista dunque come una vera e propria tomba di talenti sprecati (Sul Lungomai di Livorno, Laterza): “Ne ho conosciuti a decine di sprecati in questa città. Sprecarsi a Livorno è la cosa più facile del mondo. Tutto ti aiuta a farlo”.

Modigliani, ph Claudia Cei.
L'esilio di Lenzi, però, è durato pochissimo, per fortuna. E mettere su una mostra su Modigliani gli dovrà essere sembrata un'ottima occasione per tornare a casa. La buona sorte gli ha fornito alcuni quadri delle collezioni Netter e Alexandre, in pratica un pacchetto già pronto, curato da Marc Restellini, con dentro una manciata di Modigliani al di là di ogni possibile sospetto, vale a dire non ripescati dalla melma leggendaria dei fossi cittadini o composti sulle tavolozze dei falsari. Nonostante il costo, nonostante la paura di declinare in modo troppo provinciale il nome di “Modì” (maudit, maledetto) in quello familiare di “Dedo” (il diminutivo di Amedeo), si poteva fare. Oltre ottantamila visitatori registrati alla fine della mostra gli hanno dato ragione: l'assessore che sa di stare facendo una fine, adesso potrebbe farne una migliore di quella paventata nel suo libro (glielo auguriamo di cuore).

Ph Andrea Dani.
Ho visitato la mostra a dicembre, nei giorni dopo Natale. In effetti c'era molta gente, stipata nei corridoi angusti del percorso espositivo ricavato nel nuovo Museo della città. Magari ci sarebbe voluto più tempo per pensare a qualcosa di maggiormente attinente al richiamo del grande esule tornato in patria, ma bisogna prenderlo come un inizio. Piuttosto, che farne del tema stesso dell'esilio, posto che Modigliani, parigino d'elezione, sia tornato adesso ad essere “un livornese”? Come noto, quasi ancor prima di essere “un livornese”, Modigliani era un “ebreo livornese”. Qui si avverte un'increspatura nel significato più banale del “tornare a casa”, nella vieta immagine del “figliol prodigo”, un significato che dunque non si può certo stirare come nulla fosse, neppure grazie a una mostra in gran parte riuscita.

Modigliani, ph Claudia Cei.
Ebraismo ed erranza si fondono nella trama di un esilio per il quale non ci può essere possibile ritorno. “L'ebreo – ha scritto Giorgio Manganelli (Mammifero italiano, Adelphi) – è sempre stato l'uomo dell'altrove, e in questo senso è stato lo scandalo, giacché egli era ciò che all'occidentale si chiede di essere, e che l'occidentale rifiuta di essere”. Ma cosa rifiuta di essere l'occidentale? Egli, aveva appena detto Manganelli, “ha il terrore dell'altrove, odia l'altrove, e tuttavia sa nelle sue viscere geroglifiche che solo l'altrove custodisce il suo significato”. (Per inciso: anche una delle prime e più belle canzoni dei Virginiana Miller, dei quali Simone Lenzi è o fu il cantante, s'intitola “Altrove” e parla di stazioni tirreniche al sole in cui passano i treni...). L'ebreo, in altre parole, non permette di addomesticare le domande fondamentali che l'occidentale vorrebbe risolvere senza confrontarsi con una prospettiva di radicale alterità; per questo l'ebreo lo risveglia alla sua condizione di esule nel cuore stesso del suo sentirsi perfettamente “a casa”: “L'ebreo è esule: e noi crediamo di non esserlo”?

Ph Andrea Dani.
Nella letteratura del XX secolo uno degli autori che ha maggiormente illuminato, da ebreo, la condizione dell'esilio, nella consapevolezza assoluta di stare per fare una (bruttissima) fine, fu Franz Kafka. “Quel che affascina del Processo di Kafka è il fatto che vi si celi un enigma che non si presta mai a una soluzione definitiva. A differenza dei gialli canonici in cui la scoperta dell'assassino ripristina l'ordine del mondo permettendo al lettore di dormire sonni tranquilli, qui assistiamo piuttosto alla lenta e inesorabile designazione di una vittima da parte di quello stesso ordine di cui, fino a un attimo prima, la vittima era parte”. Sapete chi ha scritto queste parole? L'assessore Simone Lenzi in persona, nell'introduzione ad una edizione economica del Processo di Kafka (Demetra, pag. 11). L'enigma della Legge, viene spiegato, è il conundrum, vale a dire uno sviamento che ci coglie proprio sulla via di casa, condannandoci all'erranza. Non sarebbe facile ma è sicuramente affascinante sovrapporre il destino di Modigliani, questo esule che ha attinto dall'esilio una celebrità che dovrebbe essere preservata nella distanza da qualsiasi ipotesi di eccessivo “addomesticamento”, ai personaggi kafkiani che sembrano inghiottiti da una tempesta di neve o dalle scartoffie di un procedimento giudiziario che resta per loro incomprensibile (perché è l'incomprensibile).

Modigliani, ph Claudia Cei.
Qui, ancora, vengono in mente le parole di Nietzsche, nostro ultimo dialogante, e del suo aforisma 377 della Gaia Scienza, dedicato a “Noi senza patria”, il cui afflato di modernità era stato chiaramente recepito da Modigliani. Pierre Klossowski ne ha espresso il senso così: “Noi senza patria... troppo multiformi e ibridi […] insomma troppo ricchi e quindi troppo liberi per rinunciare a questa ricchezza e a questa libertà in favore di un'appartenenza concretamente determinata dal tempo e dallo spazio” (Nietzsche, il politeismo e la parodia, Adelphi, pag. 15). Se allora provassimo a scorgere nella “livornesità”, ma soprattutto nell'ebraismo e nella modernità di Modigliani il tratto di un grande irregolare che torna a casa additando l'impossibilità di averne realmente una, non avremmo forse colto l'elemento più autentico del suo mistero così sfuggente?
Franco Vaccari (Modena, 1936) nutre profondo interesse per la dimensione onirica, fin dall’infanzia. Dal 1975 il sogno entra anche nella sua ricerca artistica. Diventa una sorta di correlativo oggettivo di un dispositivo concettuale. Attraverso cinque Esposizioni in tempo reale– oltre a una vasta produzione di opere e annotazioni su quaderni, dove fotografia e pittura convivono per rappresentare sogni notturni, soggetti e forme suggeriti dai meccanismi dell’inconscio o da un’alterità misteriosa – Vaccari indaga e rende visibile il profondo legame tra il mondo dei sogni e il suo ruolo di artista, inteso come innescatore di processi: «il ruolo di "controllore a distanza" si dissolve a sua volta in quanto il sogno funziona da attivatore di realtà, cioè da pretesto per dirottare una situazione apparentemente definita verso esiti imprevisti, verso il reale inaspettato».
Nella mostra Migrazione del reale, allestita alla Galleria P420 di Bologna, il reale inaspettato è un asteroide interstellare, che giunge da una ineffabile lontananza e incombe in uno spazio siderale, avvicinandosi sempre più alla nostra coscienza. Questo asteroide è “realmente” il primo oggetto interstellare a incrociare i piani orbitali dei pianeti del sistema solare, per poi dirigersi nuovamente nello spazio profondo. Vaccari lo ha percepito come esistenza reale, come un sogno premonitore. E lo ha messo in relazione con appunti segnici e letterali, collegamenti e interpretazioni dei suoi sogni notturni, con le immagini che sono giunte da un’altra dimensione. Abbiamo posto alcune domande all’artista, come se fossimo giunti in un luogo arcaico, dedicato all’attività oracolare, come a Dodona o a Delfi, attendendo una visione o un ulteriore enigma da risolvere, come al cospetto di Pizia, di Cassandra o di una Sibilla, di fronte a una divinazione per ispirazione del nume o intuitiva, affidandoci all’oniromanzia.

Franco Vaccari, I sogni, spazio privato in spazio pubblico 1975.
Mauro Zanchi: Da dove provengono i sogni?
Franco Vaccari: Su che cosa siano i sogni e quale sia la loro funzione ci sono opinioni tra loro diversissime. Però hanno sempre colpito l’uomo dai tempi più antichi, per la forza delle immagini e per la superiore estraneità rispetto al nostro vissuto. Riescono a dare importanza a tanti aspetti del nostro vissuto, pur essendo apparentemente così estranei. Siccome ero un sognatore piuttosto accanito, ho pensato di non disperdere questo patrimonio onirico, che mi sembrava una sorta di ricchezza in potenza, non sapendo come avrei potuto utilizzarla. Scrivendo dei testi che si riferissero ai sogni, quando mi colpiva qualche immagine particolare, provavo anche a disegnarla. Non mi interessano gli aspetti dello straordinario e dell'eccezionale nel mondo onirico, nemmeno la dimensione surreale o straniante, e neppure quella psicanalitica. Mi affascina la dimensione reale del sogno. Mi sembra che il mondo reale si sia svuotato di realtà. Immagino che gli aspetti più misteriosi e rivelatori del reale siano migrati verso la dimensione del sogno.

Franco Vaccari, Messaggero che arriva per primo da lontano, 2020, Video installazione, courtesy of the artist, Bologna, credit Esom Kornmesser, USA.
Hai vissuto anche sogni preveggenti, o visioni simili a quelle che sono state descritte da antropologi venuti in contatto con sciamani di altre culture?
Sì, io ho fatto anche quei sogni che tu chiami “preveggenti”. Non sono stati esposti in questa mostra, per il semplice fatto che costituiscono un nucleo che non andrebbe disperso in mezzo ad altre immagini, ma potrebbero essere l’argomento di un’altra mostra, dove si potrebbe concentrare l’attenzione proprio su questo aspetto dei sogni.
Cosa evochi in Migrazione del reale e attraverso l’installazione video, che ha per soggetto un asteroide interstellare, proveniente da un luogo indefinito o indeterminato?
La notizia dell’apparizione di questo asteroide, nel campo di osservazione dei nostri mezzi di indagine dello spazio, è recente. L’asteroide ha suscitato molte curiosità, per la forma e per la provenienza, che pare essere extragalattica. È quindi un’apparizione momentanea, prima di sparire di nuovo nell’universo. Quello che mi ha colpito è il fatto che sia stato scoperto dall’osservatorio delle Hawaii e che le popolazioni di quell’arcipelago, dopo aver visto le immagini di questo asteroide, lo abbiano battezzato col nome “Oumuamua”, che nella lingua locale sembra che voglia dire “Messaggero che arriva per primo da lontano” o “Visitatore che giunge da un luogo indefinito”. Siccome stavo preparando la mostra alla Galleria P420 sul tema dei sogni, ho trovato che il nome dato a questo asteroide – che mi aveva colpito per la sua immagine e per la forma, assolutamente imprevista per un corpo che viene dallo spazio celeste – andasse perfettamente d’accordo con il tema delle mie opere, che era il tema del sogno. I sogni sono immagini, che sembrano provenire da chissà quale spazio, non soltanto interiore. Quindi ho unito – anche se i due soggetti sembrano apparentemente distanti – lo spazio dedicato alla mia opera con quello dedicato a questo asteroide.

Franco Vaccari, Migrazione del reale, 2020, Installation view, courtesy of the artist, P420 Bologna, ph Carlo Favero.
Alcuni sogni che hai vissuto ti hanno portato intuizioni, che sono poi entrate nelle opere della tua ricerca?
Beh, ci sono dei sogni che mi hanno comunicato intuizioni, quelle che possono essere verità particolari. Per esempio, c’è quello dove ci sono pugni, che tengono stretta l’asta di certe bandiere. Lo trovo uno dei miei sogni più significativi, dove si vedono mani che tentano di tenere in pugno la sabbia e oggetti raccolti. Ci sono anche dei tumuli di sepoltura, che tentano di resistere all’azione del vento e, invece, vengono dispersi dal vento. I pugni che tentano di tener stretta la sabbia o questi oggetti che sono stati raccolti in realtà vengono svuotati dall’azione del vento. Il vento chiaramente rappresenta, secondo me, il tempo. E la parte veramente interessante, anomala, rispetto ad altri sogni, è che c’è qualcosa che viene da lontano, come il corpo celeste, l’asteroide. Qui si ode una voce fuori campo. Dice qualcosa che mi ha molto colpito: “Non bisogna resistere all’azione del vento, perché è uno sforzo inutile destinato al fallimento. Invece bisogna fare come le bandiere, che si dispiegano e prendono vita nel vento”.
È inutile opporsi all’azione livellante del tempo, ma bisogna approfittare del tempo per dispiegare la propria natura. E trovo che sia un consiglio veramente meraviglioso.
In una delle opere esposte alla Galleria P420 c’è anche un riferimento all’opera d’arte che è entrata in un tuo sogno: un segno di Capogrossi. Ci puoi parlare del sottile rapporto fra sogno, opere d’arte di altri artisti, cose viste, segni, figure, idee, concetti, che entrano nell’immaginario?
Nel sogno subentrano tantissime cose. Quando ho dovuto rendere l’immagine che vedevo sulle superfici delle uova, mi è venuto in mente Capogrossi. Ma, in realtà, forse l’immagine più precisa erano i cromosomi, nel momento in cui si suddividono, dando luogo ai corpi, allo sviluppo. Nel mio sogno c’era qualcosa che mi ricordava l’inizio dello sviluppo dei corpi. Allora questa danza dei cromosomi mi è sembrata abbastanza simile alla danza dei segni misteriosi presenti nelle opere di Capogrossi, che non sono solo decorativi, ma vogliono probabilmente dire anche qualcos’altro e hanno radici più profonde.

Franco Vaccari, Migrazione del reale, 2020, Installation view, courtesy of the artist, P420 Bologna, ph Carlo Favero.
Ora ti pongo una domanda che si sposta verso il futuro. Come immagini ulteriori possibilità del medium della fotografia e della fotografia contemporanea ibridata con altri media o questioni?
La fotografia è in un momento il cui argomento è in eclisse, per quanto mi riguarda. Noi vediamo tante immagini e le immagini fotografiche sono un po’ sommerse da questa quantità. Qui, proprio poco fa, nella galleria è venuto in visita Erik Kessels, che è diventato famoso per aver fatto delle mostre dove vengono esposte caterve di immagini, milioni di fotografie, che lui non so in che modo riesca a stampare in brevissimo tempo. Allora la fotografia in questo senso perde buona parte dell’interesse. Tu immagina quella che era la magia dell’apparizione dell’immagine fotografica ai primordi della sua invenzione. Oggi è estremamente banalizzata. Però, secondo me, la fotografia subisce un po’ un processo di normalizzazione, dove lo stupore passa quasi totalmente, come per la luce nel telefono. Anche le telefonate nel loro apparire potevano essere oggetto di mostre. L’apparizione della voce di un corpo, di un essere, che per noi poteva significare tanto, ma a distanza enorme, doveva essere fonte di una meraviglia incredibile. Però adesso con la telefonata chi è che riesce a emozionarsi più sentendo una voce? Anche se ci sono situazioni in cui questo ancora si verifica, come per esempio è accaduto a Rigopiano qualche tempo fa, dove una valanga di neve ha sepolto un albergo. Ci sono state telefonate da parte di persone, che poi sono morte, che da sotto la neve si erano messe in contatto con i loro cari o con quelli che avrebbero forse potuto andare a salvarli.

Franco Vaccari, I sogni, spazio privato in spazio pubblico 1975.
Un altro aspetto molto importante della tua ricerca è stato l’inconscio tecnologico. Ha lasciato il segno negli anni ’70 e nei decenni successivi. Adesso, a distanza di anni, che cosa trovi di pulsante e vitale in questa tua intuizione?
Adesso siamo nel momento in cui si sta preparando una rivoluzione tecnologica incredibile, della quale non sappiamo lontanamente quali potranno essere gli sviluppi e gli approdi. È la comunicazione dovuta all’Intelligenza Artificiale. Quando i mezzi tecnologici avranno a disposizione gli strumenti dell’Intelligenza Artificiale, soprattutto quelli nati dalla meccanica quantistica, in cui gli scambi di informazione e di operazioni para-mentali subiranno un’accelerazione tale da ridicolizzare il funzionamento del nostro sistema nervoso. Quindi lì ne succederanno di tutti i colori.

Franco Vaccari, Migrazione del reale, 2020, Installation view, courtesy of the artist, P420 Bologna, ph Carlo Favero.
Quindi come immagini tu l’utilizzo di una macchina fotografica quantistica? Che immagini potrà realizzare?
Ah, non so. Dicono, per esempio – è una notizia apparsa in questo ultimo periodo – che l’immagine più importante del 2019 sia la fotografia del buco nero. Non è stata ottenuta attraverso un apparato, che con lo schiacciamento di un bottone restituisce un’immagine, ma è nata dalla sovrapposizione e dall’interferenza di una quantità di immagini ottenuta con dei mezzi incredibili, in cui l’intero apparato di recezione è stato il globo terrestre. Queste informazioni, che sono state raccolte con un apparato che era diffuso sul globo terrestre, hanno portato alla produzione di un’immagine che non poteva essere ottenuta attraverso l’uso di un mezzo classico. Quindi, non riesco proprio a figurarmi cosa ci mostrerà la macchina fotografica quantistica, nel momento in cui il passato, il presente e il futuro potranno essere colti nello stesso istante.

Franco Vaccari, Migrazione del reale, 2020, Installation view, courtesy of the artist, P420 Bologna, ph Carlo Favero.
Ammettiamo che sia ora possibile mettere in commercio la macchina quantistica, e che inneschi una nuova rivoluzione fotografica. Se porta con sé tutte le questioni dello spazio-tempo e le scoperte della fisica quantistica, sarà possibile secondo te fare fotografie anche di qualcosa che accadrà in futuro? La fotografia non sarà più un documento, uno scatto di qualcosa che viene colto in un determinato momento presente, ma potrà essere una previsione, un istante del futuro?
FV: Ah beh, sarà l’eclisse del mito di Cartier-Bresson.
Il 2 marzo ci ha lasciati, Frank Uwe Laysiepen, l’artista tedesco noto come Ulay, a pochi mesi dall’inaugurazione, a novembre 2020, di una grande retrospettiva del suo lavoro allo Stedelijk Museum di Amsterdam. Si conclude un percorso umano e artistico iniziato nel 1943 a Sollingen, mentre infuriava la seconda guerra mondiale, sviluppato nella Amsterdam anarchica dei Provo (la sua città d’adozione), per poi scorrere girovagando nomade, tra Parigi, Roma, Berlino, Londra, allargando l’orizzonte fino a New York, il Marocco, l’India, il Nepal, il Medio Oriente, la Cina, l’Australia, e la Patagonia terminando a Ljubljana dove aveva preso moglie e dimora negli ultimi anni.
Adesso tocca a noi riscoprirne l’opera: poliedrica, fuori dagli schemi, libera da ogni logica mercantile e intransigentemente radicale. Ulay è stato un pioniere della fotografia Polaroid e del concetto di fotografia performativa, esponente di spicco della Performance Art e Body Art europea degli anni ‘70, precursore della militanza ecologica attraverso l’arte e del ruolo dell’artista come scardinatore del concetto di identità (nazionale, sessuale, politica). Eppure, anche tra “addetti ai lavori” è noto quasi esclusivamente come il compagno d’arte e di vita di Marina Abramović durante i dodici anni di collaborazione, 1976–1988, che hanno segnato la carriera di entrambi.

Ho incontrato Ulay per la prima volta a Amsterdam in un piovoso pomeriggio autunnale nel 2010. Una passeggiata attraverso il quartiere turco, poi una conversazione libera, per ore attorno a un grande tavolo da lavoro. Alto e magrissimo, mi colpiscono le grandi mani con cui sembra scolpire l’aria, lo sguardo intensissimo. Occhi grigio-azzurro cangianti come il cielo, dall’acciaio alla carta da zucchero. Voce seducente, grande senso dell’humor e grande raconteur. Forte carisma, ma nessun autocompiacimento. Dice una cosa, e ci credi e basta. Ci troviamo subito.
Secondo incontro, qualche mese dopo a New York: arriva subito al sodo, sta cercando un complice, vuole scrivere un’autobiografia in forma di interviste, e pensa di aver individuato in me la persona giusta. “Sai ascoltare, fai domande insolite e non hai pregiudizi”. Fissiamo un appuntamento settimanale via Skype, ma non funziona: abbiamo entrambi bisogni di un contatto reale. Così su spinta della critica e curatrice Maria Rus Bojan decidiamo di incontrarci a intervalli regolari di persona. Dal 2010 al 2013 stabiliamo tempi di intervista: ogni qualche mese, un tour de force di una settimana con 6 ore al giorno di intervista a Amsterdam, Lago D’Orta, Ljubljana, e New York. Mi pongo l’obbiettivo di esplorare il tessuto connettivo tra la sua vita, il suo lavoro e la sua Weltanschauung anarchica. Procediamo per temi, luoghi, e idee, senza cronologia. Ore e ore di registrazione che diventeranno, assieme a un saggio della Rus Bojan un libro/intervista, Whispers Ulay On Ulay (536 pagine, Valiz, Amsterdam, 2014).
Nell’ultimo anno di preparazione del libro, Ulay ha una forma acuta di linfoma mantellare, si sottopone a ripetuti cicli di chemioterapia e ospedalizzazioni, affrontando la malattia con rara serenità e coraggio. Non ha mai voluto interrompere il lavoro, abbiamo continuato le interviste prima e dopo ogni ospedalizzazione: mostrando possente forza fisica e psicologica.

Ulay sosteneva che il suo “posto nel mondo”, la piattaforma da cui operava, aveva poco a che vedere con il mondo dell’arte contemporanea. Non ha mai avuto uno studio, né assistenti; aborriva l’idea di signature style così comodo per pubblico e critica. Per quasi tutta la vita non ha avuto una galleria, né sostegno istituzionale. Ha prodotto aforismi e poesie, fotografie, collage, performance, body art, oggetti scultorei e installazioni, video, disegni, ma mai un dipinto. Ha goduto del sostegno e dell’amicizia di altri artisti che sentiva compagni di viaggio, ma raramente ha avuto “mercato”. L’idea che ci fosse una cosa chiamata mercato dell’arte gli sembrava un nonsense, risibile. La risata era la sua prima difesa da tutto ciò a cui si opponeva.
Il momento dell’esposizione e il contatto con il pubblico erano sempre tentativi di dialogo, di costruzione di una comunità ideale, talvolta di scontro anche violento e di incomprensioni reciproche. Lo guidavano un’irrefrenabile curiosità, una forte tensione morale e il bisogno di libertà. Per evocare l’uomo e l’artista, scelgo quattro momenti/opere emblematici.
Ulay – Il costruttore di identità temporanee
Nel 1969, dopo aver lasciato l’accademia d’arte senza finirla, prende la sua automobile, due libri, una macchina da scrivere e una Polaroid e lascia la Germania, per trasferirsi a Amsterdam. Si lascia dietro un laboratorio fotografico commerciale, una moglie e un figlio di tre anni. Voleva “de-germanizzarsi” e costruirsi una nuova identità. Sarà una cesura definitiva.
“Ho lasciato la Germania a causa di un forte conflitto che sentivo. Ero in disaccordo con ciò che accadeva nel mio paese dal punto di vista sociale, politico e economico. In Germania non riuscivo a scoprire me stesso”. Nella Amsterdam degli hippies e dei Provos vedeva l’antidoto al “cocktail di interessi materiali e potere industriale che dominava in Germania”.
Appena arrivato assume un nuovo nome, e sintetizzando nome (Uwe) e cognome (Laysiepen), diventa semplicemente Ulay. (Anni dopo, scoprendo che ulay in ebraico vuol dire forse, sarà felice della coincidenza) Le prime serie di Polaroid, autoritratti e collage, in cui spesso si traveste metà uomo e metà donna, sono un tentativo di rispondere a domande che continuerà a porsi tutta la vita: chi sono? Chi posso essere? Chi voglio diventare?

Cambiarsi il nome (lo ha fatto più volte nella sua carriera) è sempre il segnale d’inizio di una fase artistica nuova. 40 anni dopo, quando l’emergenza ecologica diventa una componente primaria del suo lavoro, si concentra sull’accesso all’acqua potabile in varie parti del mondo. “Ultimamente, quando mi presento a qualcuno allungo la mano e dico ‘piacere, Water’. Non Waterman, semplicemente Water, acqua. I nostri cervelli sono composti per 90% da acqua, e il nostro corpo è acqua per il 68%. L’interlocutore si incuriosisce e chiede, prego? Io rispondo, Water, e questo dà immediatamente inizio al tipo di conversazione che voglio istigare”.
Ulay – il provocatore
Berlin Action - There is a criminal Touch to Art.
Nel 1976, Ulay incontra Marina Abramović. Amore a prima vista che presto si trasforma in un connubio simbiotico. Decidono di collaborare, ma prima di iniziare ognuno porta a termine un lavoro individuale. In dicembre Marina è invitata a Berlino per una serie di performances, intitolata Freeing the Body. Ulay la segue a Berlino per fotografarla. Una volta lì, pianifica una propria action. L’idea nasce visitando la Neue Nationalgalerie dove si imbatte nel celebre quadro di Carl Spitzweg, Der arme Poet (Il povero poeta). Artista figurativo romantico dell’epoca Biedermeier, Spitzweg era il pittore preferito di Hitler. Non solo, ma a chiunque abbia frequentato la scuola in Germania, Der arme poet, veniva propinato come “il quadro tedesco dell’800”, in modo non diverso da come nella scuola italiana si presenta I Promessi Sposi. In quel quadro Ulay individua quello che cercava per un’azione politico/artistica.
Lungo il muro di Berlino quegli anni stava crescendo Kreuzberg, un quartiere semiclandestino popolato da immigrati turchi, oggetto di discriminazione e violenze. Nei giorni precedenti Ulay aveva passato ore a fotografarlo. Ci torna, fraternizza con una famiglia turca a cui spiega di essere un artista contemporaneo che desidera portare all’attenzione nazionale la questione dell’immigrazione turca. Chiede di visitare la loro casa. Nel loro salotto-cucina nota un quadro su una parete. Chiede il permesso di tornare qualche giorno dopo, di sostituirlo con un altro quadro e fotografarlo con la famiglia intorno. Una cosa di mezz’ora al massimo a cui la famiglia acconsente. Ulay torna alla Neue Nationalgalerie, per mettere a fuoco il suo piano, come un rapinatore che visita una banca prima del colpo. Il quadro di Spitzweg si trova in un semi interrato, in una sala con due grandi porte di legno che ne garantiscono la climatizzazione. Per raggiungere l’uscita c’è una rampa di scale, poi una grande salone con la biglietteria e le porte girevoli d’accesso. Immaginando che le porte girevoli si bloccano in caso di allarme, l’attenzione va su una piccola uscita di sicurezza laterale. Quella porta, probabilmente anch’essa collegata all’allarme, ha un sigillo che auspicabilmente salta se spinto con forza. Si annota tutto il percorso, e il giorno dopo entra in azione.

Parcheggia il furgone Citroen HY nero (in cui viveva) davanti al museo, a una trentina di metri dall’uscita di sicurezza, lasciando il motore acceso. Entra nel museo raggiunge il quadro, e scegliendo un momento in cui la guardia è distante, lo stacca risolutamente dal muro recidendo con delle tronchesi il supporto in fil di ferro. E mentre partono la sirena e i lampeggiatori, si lancia a grandi falcate verso le scale con il quadro sottobraccio. Come aveva ipotizzato le porte girevoli sono bloccate, ma la porta di sicurezza si apre con una spallata.
Tra le urla delle guardie e del pubblico Ulay è fuori, inseguito da tre guardie che non esitano a sparargli alle gambe mancandolo di poco. Nella corsa, inciampa sulla ghiaia resa scivolosa dalla neve e cade, si rialza, corre ancora, arriva al furgone e scappa. (La fuga è documentata da Jorg Schmidt-Reiwein, un operatore, appostato in un altro furgone). Immediato, scatta l’inseguimento della polizia e dei corpi speciali antiterrorismo (ipotizzavano si trattasse di un attentato della banda Baader-Meinhof). Alla guida del furgone, Ulay, sente il ronzio degli elicotteri che lo seguono.
Arrivato a Kreuzberg, raggiunge l’appartamento della famiglia turca, sostituisce il quadro al muro e scatta delle foto di Der arme poet con la famiglia turca sorridente attorno. Poi, scende in strada e da una cabina telefonica chiama il museo, chiede del direttore e dice: Mi chiamo Ulay sono un artista, voglio che venga a riprendersi il quadro a Kreuzberg e dà l’indirizzo. In pochi minuti l’isolato è circondato da forze speciali in assetto antisommossa. Il direttore del museo assieme a poliziotti, ispezionano increduli il quadro (fortunatamente incolume) nel salotto della famiglia turca e arrestano Ulay. Il giorno dopo per la prima e unica volta, Ulay e la sua action fanno la prima pagina dei maggiori quotidiani tedeschi. Arrestato e condannato, dopo tutte le attenuanti, a 56 giorni di reclusione, Ulay esce di galera su cauzione e scappa in Olanda (non potrà più mettere piede in Germania per anni). Ciò che più colpisce di There is a Criminal Touch to Art, questo il titolo che darà alla action, e che rimarrà una costante nel lavoro di Ulay, è l’aver concepito e affrontato l’azione, basandosi e facendo leva esclusivamente sul proprio corpo – agilità, velocità, nervi saldi. Il solo corpo, nudo e vulnerabile, diventa strumento e linguaggio artistico nonché di lotta politica. “Non ho mai pensato che con l’arte si possa cambiare il mondo. Ma porre l’attenzione su questioni scomode, questo sì”.

Ulay – il movimento diventa immobilità
Del cosiddetto Relation Work con Marina Abramović è stato scritto molto. Voglio solo ricordare alcuni aspetti di Nightsea Crossing, a mio giudizio il punto di arrivo della loro collaborazione.
Ulay lo descrive così: “Un uomo e una donna, seduti a lati opposti di un tavolo, immobili, in silenzio. Ecco tutto”. La performance è il risultato di una serie di viaggi intorno al mondo, nuovi interessi, filosofie, e approcci alla vita. Dopo anni di esplorazione estrema di movimento, suono, e forza fisica, con Nightsea Crossing, si interrogano se la sola presenza fisica, il loro “essere con il pubblico” sia sufficiente perché si possa parlare di performance. Si tratta di un tentativo di ridurre tutto (il loro lavoro di performers, ma anche l’esperienza umana) ai minimi termini. E di mettere a confronto occidente e oriente. All’origine di questo lavoro, è un loro viaggio in Australia 1980. “Ci trovammo da soli nel Central Australian Desert con temperature che raggiungevano i 48 gradi. A quelle temperature l’immobilità è quasi obbligata. Guardare un rettile che respira è uno spettacolo e forse il massimo che puoi fare. Con quel caldo puoi solo vegetare, come una pianta. Prima di muoverti, ti chiedi dieci volte se ne vale la pena. Vivere in quelle circostanze ci ha fatto pensare in maniera del tutto nuova a cos’è il movimento, l’azione e direi la vita. Ti costringe a economizzare le energie ed eliminare qualunque cosa superflua. Dall’altra parte ti fa scoprire la bellezza e il mistero dell’essere. Cosa vuol dire semplicemente essere”.
Un’opera di enorme durata, ambizione e scopo, Nightsea Crossing ha richiesto una preparazione di 5 anni. “Volevamo metterci nella condizione fisica, psichica e spirituale ideale per poter intraprendere la nuova performance così andammo in India. Siamo stati vegetariani per 5 anni. Era un modo per aumentare la chiarezza mentale in vista dei lunghi digiuni che Nightsea Crossing avrebbe comportato”. Per prepararsi all’immobilità si avvicinarono alla meditazione. “Capimmo presto che la meditazione sarebbe stata una necessità, di più, la linfa del lavoro, per questo andammo a Bodhgaya a studiare Vipassana. Quella antica forma di meditazione ci era indispensabile per imparare a gestire le sensazioni interne e esterne durante la performance, così come il dolore fisico e la fame. Ma il regalo più grande che ho avuto dalla meditazione è stato l’imparare a non pensare, a non trattenere i pensieri. La meditazione Vipassana è un lusso e uno strumento utilissimo nella vita quotidiana così come nelle situazioni più estreme”.

Molti aspetti di questa performance si basano sulla tradizione Veda. “Eravamo affascinati dalla numerologia nei testi Veda secondo cui ogni individuo è identificato da valori numerici. I nostri numeri erano alla base della durata in ore e giorni in cui saremmo stati seduti in silenzio con il pubblico”. Nightsea Crossing fu presentato per la prima volta a Sidney per 7 ore in 16 giorni consecutivi. Durante quel periodo Ulay e Marina osservavano il digiuno completo “Io mangiavo una mandorla al giorno, adoro le mandorle” e il silenzio. La performance fu ripetuta 90 giorni non consecutivi in musei e gallerie in 5 continenti. Semplicità, purezza e rigore affascinavano il pubblico che inevitabilmente (anche nelle sue intemperanze) divenne una componente essenziale. Molto più di una mera prova estrema di resistenza, Nightsea Crossing, si presta a una moltitudine di letture, non ultima una spietata critica al matrimonio. C’è qualcosa di tristemente universale nell’immagine di un uomo e una donna a un tavolo che siedono in silenzio senza più niente da dirsi. Come in Beckett, umorismo e tragedia si tendono la mano.
Ulay – la fotografia ontologica in scala 1:1
Ulay aveva una conoscenza enciclopedica di tutti gli aspetti – ottici, chimici, matematici, industriali – della fotografia analogica. Edwin Lang, l’inventore della fotografia istantanea Polaroid, nei primi anni ’70, selezionò 10 artisti tra cui Ulay, a cui diede sempre accesso gratuito alle successive macchine Polaroid e a una quantità illimitata di pellicola, per esplorarne il potenziale creativo. Da allora fino a pochi mesi fa, Ulay ha continuato a esplorare a 360 gradi questa invenzione che condensa in un unico momento esposizione, sviluppo e stampa. Quando Ulay parlava della Polaroid, intesa come macchina fotografica era come se parlasse di un’amante che non finiva di stupirlo. Nella sua casa di Amsterdam custodiva un archivio vastissimo delle sue fotografie scattate con la Polaroid: catalogate e conservate come un tesoro. Era fiero di dire che in tutta la sua vita non aveva venduto più di cinque delle sue fotografie Polaroid!
Intorno al 1980 Lang costruì pochi esemplari da studio del modello 40X80 alloggiata in una struttura di legno di circa due metri quadrati che produce immagini a definizione superiore delle migliori camere digitali di oggi. L’aveva concepita per fare le migliori fotografie possibili al soffitto affrescato della Cappella Sistina. Da subito Ulay intuì che questa macchina fotografica poteva realizzare un suo sogno: fotografare il corpo umano, in scala 1:1. Assieme a Chuck Close, Lucas Samaras e Julian Schnabel, Ulay è l’artista che ha utilizzato maggiormente la Polaroid 40X80, talvolta entrando fisicamente nella macchina fotografica e manipolando con dei guanti di plastica la pellicola durante lo sviluppo istantaneo.

I risultati sono di grande interesse non solo artistico, ma anche concettuale. Un paio di esempi: “Le prime foto che ho realizzato con quell’enorme macchina fotografica sono state quattro immagini, per le quali ho usato una lamina diffusiva, un materiale bello, un po’ come la vetroresina. Ho messo un faretto dietro alla lamina, con un filtro giallo. Quindi avevamo uno sfondo giallo illuminato e poi abbiamo scattato quattro fotografie di Marina e di me stesso. Volevamo rappresentare le quattro fasi della vita secondo Delacroix. Nel 1987, Ulay affitta la gigantesca Polaroid e la istalla alla Gallerie ClaireFontaine a Lussemburgo. Poi per alcuni giorni, mette in posa, uno per volta, un largo campione della popolazione lussemburghese: un bambino, una suora, un barbone, un banchiere, una massaia, un poliziotto ecc. Alla fine con tutti i ritratti ha tappezzato ogni parete della galleria come una mappa umana, e The Luxembourg portaits fu tra le mostre più visitate quell’anno a Lussemburgo, “L’arte serve anche a vedere/mostrare se stessi individualmente o come gruppo”.
La sfida di creare immagini fotografiche che non rimpiccioliscano il soggetto ha accompagnato Ulay in diversi momenti, con o senza l’ausilio della grande Polaroid. Durante un suo soggiorno tra gli aborigeni Pitjantiatjara nel deserto nel sud dell’Australia, Ulay sviluppa l’idea che chiamerà afterimages. Di notte, alla luce tenue di un fuoco, fissa nel terreno, come delle porte, delle cornici di legno di 1.80cm X 70cm, e le ricopre di carta fotografica. Chiede agli aborigeni di danzare uno per volta davanti a queste “porte”. Durante la danza aziona un flash che imprime abbastanza luce per cogliere una traccia del corpo danzante sulla carta fotografica, poi trattata con un fissativo. Il risultato sono “presenze” fantasmagoriche, appunto afterimages.
L’opera di Ulay, nel suo insieme, non è stata ancora oggetto di un’analisi critica, salvo i contributi di Thomas McEvilley e di Maria Rus Bojan. Voglio concludere con un invito a riscoprire Ulay, proprio a partire dalle sue Polaroid in scala 1:1, dove la corrispondenza tra immagine e soggetto, solleva profonde questioni artistiche e ontologiche. “La fotografia per me conserva un elemento alchemico, una magia. Non c’è arte senza magia.”

Breve bibliografia su Ulay:
Ulay Life-Sized, a cura di Matthias Ulrich, Schirin Kunsthalle, Frankfurt. Spector Books, 2016
Whispers. Ulay on Ulay. Maria Rus Bojan e Alessandro Cassin. Valiz, Amsterdam 2014
Art, Love,Frienship Marina Abramovic and Ulay Togther & A Part, Thomas McEvilley, Documentext. McPherson and Co, New York, 2010.
Ulay The First Act, Uwe Laysiepen and Thomas McEvilley, Cantz Verlag, Ostfildern, 1994.
È come se dipingessi con la sinistra (essendo mancino), mentre la destra la trattiene, diceva in un’intervista televisiva del 1966, quando, moglie e tre figli, conduceva una vita molto borghese a New York City. «Disagio» era la sua parola-chiave, per esprimere quel senso di fastidio che prova chi, educato al culto puritano della repressione, vede nel piacere un pericolo da combattere: cinquant’anni dopo non molto è cambiato, perché nelle sue tele e istallazioni, quasi tutte di grandi dimensioni, si sente sempre la fatica del lavoro. Il suo studio è come il negozio di un ferramenta: una collezione di oggetti che prima o poi finiscono nelle sue tele e nelle sue istallazioni, dove l’arte è sempre ribellione alla vita, alle sue strutture, alle sue regole e alla sua disciplina. Perché, appunto, la vita di un puritano è rigore morale, senso di colpa e paura del godimento, mentre l’arte apre la strada (agonisticamente e angosciosamente) a ciò che il super-io ha soffocato.

È uno spazio interiore, necessariamente autobiografico dice lui, che ha la capacità di diventare il suo accappatoio, un’ascia conficcata in un tronco o un paio di stivali di pelle da motociclista: gli oggetti ti costringono, visti da vicino, a ripensare non loro, ma proprio te stesso, il tuo rapporto con le cose, la loro forma e la loro materialità. Perciò devono andare in scena, a rendere visibile quella relazione tra il mondo e l’io che è l’ossessione di chiunque, non potendo dire se stesso, non può far altro che reificarsi, trasformarsi in oggetto, specchiarsi nelle cose che ne disegnano, e designano, la quotidianità, fino a penetrarne l’anima. Li incollava alle tele, infatti, gli oggetti, a partire dalla metà degli anni Sessanta, facendo di vanghe e vasche strumenti di rottura dello spazio pittorico, ma anche della tela un luogo d’incorporazione di una dimensione che per natura non le può appartenere. Portando la tela fuori da sé e il mondo dentro la tela, costringeva lo spettatore a uno strabismo costituzionale, in cui si riconoscono la fatica a dirsi artista piuttosto che operaio e la necessità di trasformare il craftsman in player: un campo di forze in tensione, dove lo spazio non accoglie e dispiega, ma è esso stesso attore della lotta.

Lui è Jim Dine, in mostra ora al Palazzo delle Esposizioni a Roma (a cura di Daniela Lancioni, fino al 2 giugno 2020; catalogo pp. 303, Quodlibet): l’ultimo grande concentrato del mito americano, integrato e ribelle, educato e anarchico, regolare e controcorrente. Barbara Rose e Frank Stella saranno stati le sue guide (fino a valergli incasellamenti episodici nel Neo-Dada e nel minimalismo), ma alla fine essere Jim Dine – artista pop per lui ha significato soprattutto essere solo, alla ricerca di una libertà impossibile quando hai bisogno del riconoscimento del gruppo.

Oscillando tra appartenenza e distinzione, come ogni eterno enfant prodige che si rispetti, Dine è riuscito a esprimere la contraddizione del nostro tempo, nella lunga gittata generazionale che va dagli anni Sessanta ai nostri giorni: quel senso di poter dire solo a latere del già detto, l’ambizione a essere popolare da un punto di vista elitario, l’istanza spiritualista universale riconosciuta nel principio vitale della materia, l’anelito all’assoluto e i limiti del branco.
Si è dipinto come Mickey Mouse e Pinocchio, ha riempito le tele di bretelle, cravatte, pale e piccozze, non ha inventato nulla e ha sconvolto tutto. Avrebbe, a suo dire, puntato al brutto, ma esteticamente è perfetto, geometrico, coloristico e luministico – come tutti i suoi compagni d’avventura pop. L’etichetta di «pop» non gli è mai piaciuta, ma in fondo è sempre stato un’artista di grandi appartenenze, dal sodalizio di lunga durata con Claes Oldenburg alla sua stessa canonizzazione, scientemente e tenacemente perseguita a partire dagli anni Ottanta.

Uno stereotipo, insomma, come si addice a chi può raccontare di aver fondato gli happenings insieme con (fra gli altri) Allan Kaprow, Robert Rauschenberg e Robert Whitman (decisivi i 18 Happenings in 6 Parts dell’ottobre 1959), di aver lambito la genesi della pop art al fianco di Roy Lichtenstein, Andy Warhol e Robert Dowl (con cui condivise i New Paintings of Common Objects del 1962, la prima grande mostra della pop art in un museo, organizzata da Walter Hopps a Pasadena), di aver vissuto tra New York e Londra nella svolta decisiva tra gli anni Sessanta e Settanta, di essersi mosso tra figuralità e poesia nel decennio successivo e di aver riscoperto l’arte classica negli anni Ottanta. Daniela Lancioni nel catalogo ha richiamato l’esistenzialismo di Merleau-Ponty, per cui tutto ritorna al soggetto pensante, e la fondazione teorica dell’arte povera da parte di Germano Celant, per cui è lo sguardo del soggetto a dare senso all’oggetto, come i due poli di un’artista poco filosofo e molto chiacchierone, che in fondo è sempre rimasto fedele al culto del particolare, isolato dal contesto funzionale e riportato a un’identità essenziale, si tratti di una saponiera, una vanga, un cuore o una mano. Tutto troppo facile, insomma, fino a quella serie di cuori che sembra davvero un innesto di origami sullo spirito delle soap operas.
Eppure non c’è nulla che faccia sentire a casa, nel suo mondo, perché la casa è sempre, dicevamo, il luogo della struttura e della repressione. Se a definire l’arte contemporanea sono prima di tutto i rapporti di produzione, che hanno fatto dell’arte una funzione delle direzioni economiche dominanti, col gioco di doppiezza strutturale proposto da Dine, per cui l’oggetto non diventa opera, come alle origini del pop, ma la invade e la occupa, all’arte viene forse restituita la possibilità di sottrarsi alla mercificazione e rilanciare l’alternativa – facendosi progetto intellettuale anziché mera rifrazione del contemporaneo egemone. S’intravvede in controluce la tesi marcusiana che nell’arte si manifesti la memoria di un’unità originaria precedente alla separazione tra fantasia e ragione, natura e spirito, che costringe a fare i conti con l’ipotesi di una condizione primaria dell’essere umano.

Artista universale, interprete del mondo, immerso fino al collo nell’eredità romantica che si protrae oltre il tempo, Jim Dine è l’esempio di una vita per l’arte, che trasforma l’ossessione in ispirazione e la fatica in passione. Vederlo in mostra significa ritrovare le grandi domande sull’arte come sentimento e come forma, scavo dell’interiorità e rapporto col mondo: fino alla sala più sorprendente e affascinante della mostra, che raccoglie 12 Pinocchio (uno doppio), in pose e situazioni diverse, realizzati tra il 2004 e il 2013, a esplorare la relazione tra individuale e tipizzato, per cui siamo tutti uguali e tutti diversi, Geppetto può fare il turista a Pompei e Jim può entrare nel mondo ipercompetitivo dei pupazzi. I più belli dei suoi Pinocchio in mostra però non ci sono potuti entrare, perché sono uno, un bronzo enorme, alto nove metri, in una piazza di Borås, in Svezia, un altro, anch’esso in bronzo, oltre tre metri e mezzo, davanti al Museo d’Arte di Cincinnati e il terzo è un libro illustrato, pubblicato da Steidl nel 2006. Incombenti e ingombranti, i suoi Pinocchio vogliono esplorare il meccanismo della creazione artistica, nel processo di trasformazione della materia in forma, ma sono anche, soprattutto, un invito a fare i conti con le emozioni: mai rassicuranti, sempre imperfetti e magari persino un po’ sporchi. Li circonda, trionfo paroliberista, una serie di riflessioni aforismatiche in forma poetica sulla vita e l’opera, dove la memoria dell’infanzia e la ricerca del contatto si manifestano in un appuntamento più discreto e meno brillante con più colore sul ragazzo. La creazione perfetta, del resto, diceva, è quella che si usa e getta, come le ceramiche da tè giapponesi che si buttano a terra e distruggono dopo aver bevuto.
Prolifico, eclettico, anticonformista, estraneo e ostile a ogni classificazione, ma anche sempre al posto giusto al momento giusto, apprezzato tanto dalla critica quanto dal mercato, intriso di relazioni omozigote e altamente influente sull’arte successiva, Dine rappresenta quell’essere contro ed esserci sempre che sembra oggi la condizione indispensabile dell’artista e dell’intellettuale, soffocato dall’immarcescibile eredità romantica e obbligato alla consapevolezza dell’industria culturale. Eppure la sua mostra ha il profumo dolce dell’infanzia e l’odore acre del lavoro, perché il suo sguardo di fronte al mondo è rimasto incantato e la sua voglia di dire qualcosa è ancora un bisogno reale.
Contro le pestilenze il santo più invocato è sempre stato San Rocco, a cui sono dedicate numerosissime chiese, chiesette, cappelle e edicole nei borghi e nelle aperte campagne devastate nei secoli da ogni genere di epidemia. A volte vere e proprie meraviglie, come la Scuola Grande di Venezia, con i capolavori di Tintoretto.
Ma subito dopo San Rocco il protettore più invocato contro le pestilenze è sempre stato San Sebastiano, che in genere viene rappresentato come un bel giovane legato a una colonna, trafitto da uno o più strali, dal fisico perfetto (era il minimo, per un capo della guardia imperiale quale lui era) con solo il ventre coperto da un perizoma a volte succinto in modo sospetto, e lo sguardo variamente declinato dalla serenità alla forza interiore, allo stoicismo e in certi casi persino con una sfumatura di estasi. A essere rappresentata è quasi sempre la scena del supplizio, che tutti hanno presente per averla vista spesso riprodotta o direttamente in qualche chiesa o museo, che ha dato occasione a tanti capolavori, su cui non è il momento di insistere.
Meno nota invece è la scena successiva, quando il corpo del futuro santo crivellato di frecce, creduto senza vita, viene lasciato in pasto ai cani in un terreno incolto, dove la leggenda narra che sia stato ritrovato da una vedova, Irene, che lo porta a casa sua e lo cura fino alla guarigione, preludio a una seconda e definitiva esecuzione. È una scena che ha avuto meno successo del corpo glorioso trafitto, ma che nondimeno è stata rappresentata in opere di grande livello: in particolare, per quel che ci interessa qui, ad opera di Georges de La Tour, in una decina di versioni di sua mano e di bottega, spesso eccellenti.
La scena è notturna, come si conviene al maestro francese specialista del lume di candela (se fosse aperta, raccomanderei una visita alla magnifica esposizione di Palazzo Reale di Milano che la tragica epidemia che ci sta flagellando con le sue invisibili frecce ha interrotto) e mostra delle figure in primo piano circondate dal buio, con solo qualche bagliore sull’ambiente circostante. Ci sono, del soggetto, due varianti principali. La prima di taglio verticale, con alcune figure in piedi; la seconda orizzontale, con meno figure, rappresentate più in primo piano, per catturare lo spettatore facendolo entrare nel quadro, come in un altro dei quadri esposti a Palazzo Reale, di Trophime Bigot, che per de La Tour, della cui formazione poco si sa, è stato tra i più probabili riferimenti, assieme al principale autore di notturni, Gerrit van Honthorst (Gherardo delle notti) e a Hendrick ter Brugghen, pure presenti nella mostra.

In realtà le versioni verticali (al Louvre e a Berlino) mostrano più la scena del ritrovamento del corpo da parte di Irene che quella della cura a cui si riferiscono i titoli. Irene con una fiaccola osserva il corpo riverso a terra con una freccia nell’addome, appena sotto lo sterno; dietro di lei tre altre donne (due relativamente in luce che formano con la santa una diagonale, come una mezza piramide tagliata dal margine destro del quadro, con il corpo di Sebastiano a fare da base; e una più discosta, al buio, di cui sono illuminate solo le mani giunte e una parte del viso piegato a guardare verso il santo, oppresso da un dolore muto, composto, a cui invece dà libero sfogo, con un pianto dirotto la donna in piedi, più arretrata, ma anche più gigantesca all’apparenza, incombente su tutta la scena, quasi a sintetizzarne le emozioni.

Il corpo del santo, snello, levigato, dalla muscolatura appena accennata, è messo di traverso lungo il bordo del quadro, come in tante Deposizioni, con il braccio destro ad angolo retto, abbandonato, come spezzato, e la gamba destra sollevata, a coprire il sesso e insieme ad abbozzare una diagonale parallela a quella formata dalle tre donne. Dietro Irene c’è un’altra donna, con il corpo piegato in avanti e le braccia aperte in modo simile a quello del dolore di tanti compianti, ma in modo misurato, non spettacolarmente agitato, come se non ci fosse bisogno di niente di più di questo stupore pensoso, mentre Irene guarda, ancora incerta forse sulla condizione del giovane, certo pensando a cosa fare.

La versione orizzontale invece (forse una copia, ma non importa, è comunque bellissima), racconta il momento successivo. Irene ha capito che il giovane è ancora vivo e si è chinata su di lui per cominciare a prodigargli le prime cure. È il momento del soccorso vero e proprio. Il giovane è vivo e cosciente. Nel buio della notte, nelle tenebre del mondo, una luce si riflette nella sua sclera, il braccio è piegato, ma ora come gesto non di abbandono bensì di sostegno del torso semieretto, mentre è intento, sereno e distaccato, quasi la cosa non lo riguardasse, a osservare la donna che gli estrae la freccia confitta non più nell’addome, ma nella coscia sinistra. Tra Irene e Sebastiano, più in alto, a fare da vertice del classico triangolo formato dalle teste, una giovane è chinata a guardare, si immagina con trepidazione, l’intervento. Tiene in mano una lampada, più discreta della fiaccola fiammeggiante della scena della scoperta, al cui interno è accesa una candela che proietta una luce diretta sulla coscia dell’uomo e sulla mano, sul lato destro del viso e sui bordi del velo di Irene. Ma prima ancora il contrasto della luce sulla lampada dà luogo a una croce in ombra (accorgimento spesso usato da de La Tour, e non solo da lui), che allude al prototipo dei sacrifici e dei martirii, quello di Cristo.
Irene prende la freccia con due dita della destra, con un gesto delicato e insieme elegante (la delicatezza è sempre elegante), e si appresta a toglierla. Il busto è eretto, solo la testa leggermente chinata, lo sguardo attento a procurare il minor dolore possibile, consapevole che non potrà essere evitato, mentre la mano sinistra si appoggia con le dita al ginocchio, quanto basta per aiutarsi a eseguire al meglio l’operazione senza perdere l’equilibrio. Non un grammo di più. Le labbra sono chiuse, accostate senza tensione alcuna, senza tradire nessun accenno di espressione. Solo l’attenzione che pervade come un soffio tutto il viso. Non c‘è nient’altro da dire. Niente da comunicare. Come non deve comunicare niente tutto il corpo della donna, intenta solo a ciò che fa, e forse nemmeno allo scopo per cui lo fa e alla persona a cui lo fa. A fare bene quello che sta facendo. A prendersi cura di chi ha curato e guarito. A cercare di salvare chi ha salvato e continuerà a salvare.
Mai come in questi giorni ci stiamo rendendo conto di quanto le nostre vite siano legate a doppio filo al mondo dell’arte e della cultura: quanta musica in più stiamo ascoltando, quanti libri in più leggendo o quanti film in più vedendo? Giornali e riviste stanno registrando numeri sorprendenti: Doppiozero ha toccato gli 89.000 lettori il 9 marzo, proprio il giorno in cui Mariangela Gualtieri ci ha fatto dono di una meravigliosa poesia. Le iniziative di tour virtuali gratuiti nei musei sono molto diffuse e hanno risultati strepitosi; la Pinacoteca di Brera, uno dei primi musei a promuovere la sua attività digitale durante la crisi ha raggiunto picchi di un milione di visitatori; in questi giorni, i prestiti di libri digitali presso le biblioteche sono più che raddoppiati.
L’altra faccia della medaglia, però, ci rivela un quadro molto meno roseo: se alcuni consumi culturali sembrano aumentare, i settori culturali rischiano complessivamente di uscire stremati dal’attuale crisi sanitaria. La totalità degli eventi artistici e culturali live è stata annullata o, quando va bene, riprogrammata; le nuove produzioni cinematografiche e televisive sospese. Inoltre, gli stessi consumi culturali in aumento rischiano di beneficiare grandi piattaforme e catene di distribuzione, lasciando indietro chi effettivamente quel contenuto l’ha creato.
Non si tratta di cifre irrisorie: a livello europeo, ci sono in ballo 7,3 milioni di posti lavoro che afferiscono alla cd occupazione culturale, pari al 3,7% dell’occupazione totale nei 27 paesi dell’Unione europea. Si tratta inoltre di lavoratori spesso privi di un’adeguata rete di protezione. La percentuale di lavoratori autonomi nei 27 paesi UE è infatti notevolmente più elevata nell’occupazione culturale (32%) che nell’occupazione per l’economia totale (14%) e tale differenza è rimasta pressocché stabile nel tempo.

Lavoratori autonomi in cultura e nel totale dell’economia (UE-27, 2011-2018). Fonte: Eurostat, EU’s Labour Force Survey.
La fragilità dei lavori artistici e culturali è nota. Ma questa crisi ci pone davanti a due binari molto chiari: riconoscere questa fragilità e agire di conseguenza, o ignorarla e perdere quella vitalità culturale per cui paesi e città a lungo si sono battuti nella corsa globale all’attrazione di talenti, abitanti, visitatori, imprese e investimenti – se non per sempre, per un lungo periodo la cui fine è difficile da prevedere. Senza contare che in questi giorni è proprio sulla cultura che si sta facendo leva per rinsaldare il senso di comunità. Sarebbe un errore, oltre che una grande ingiustizia. E una perdita incalcolabile per tutti noi.
Se scegliamo il binario uno, è necessario partire da questa pandemia per agire sue due fronti: da un lato, quello dell’emergenza, adottando misure che tengano in vita questi settori e tutte le professionalità connesse – dall’artista al curatore ai tecnici, alle organizzazioni culturali impegnate sui territori per la diffusione capillare della cultura; dall’altro, quello del post-emergenza, al fine di disegnare sistemi di finanziamento più sostenibili, in virtù del valore che attribuiamo a contenuti artistici e culturali con i nostri comportamenti.
Sul primo fronte, l’Italia in primis si è mossa, istituendo fondi straordinari (tra cui Il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di 130 milioni di euro), dilazionando pagamenti di contributi pensionistici o premi di assicurazione, o ancora introducendo indennità per alcune tipologie di lavoratori, tra cui quelli culturali (vedasi decreto “Cura Italia”). A seguire, diversi paesi hanno adottato misure economiche di emergenza istituendo, alcuni, fondi specifici per i lavoratori del comparto culturale, come la Francia (22 milioni di euro da destinare ai vari sotto-settori culturali, dal libro alla musica allo spettacolo alle arti visive); altri, fondi che coprono i lavoratori e / o i settori la cui attività è messa particolarmente in pericolo dalle misure di confinamento, come il Belgio (fondo di 50 milioni di euro), la Svezia (90 milioni di euro in più per i settori della cultura e dello sport) e la Germania (50 miliardi di euro per le piccole imprese e i liberi professionisti, compresi quelli del settore culturale, creativo e dei media, più 10 miliardi di euro destinati all’estensione degli strumenti di protezione sociale, inclusi i sussidi di disoccupazione, ai liberi professionisti tra cui gli artisti, per un periodo di sei mesi). Inoltre, si è aperto un tavolo di lavoro MiBACT-enti locali su iniziativa degli assessori alla cultura di alcune città per coordinare iniziative a livello locale.
E sono parimenti molto rilevanti le iniziative messe in campo dalle collecting societies pe sostenere gli associati e i mandatari in difficoltà; SIAE e la consorella tedesca GEMA da questo punto di vista sono particolarmente attive con misure solidali, di prestito agevolato, di assorbimento dello choc. Per sostenere le librerie indipendenti si è creata una rete di consegna a domicilio finanziata dagli editori.
Ma è sul secondo fronte che occorre mettere pensieri di qualità. In Italia, le prime proposte sono già arrivate: da un fondo nazionale per i risparmiatori italiani a garanzia del patrimonio culturale (Pierluigi Battista) alla controproposta di un Bond per l’arte e la cultura, che preveda nell’arco temporale di 3-5 anni, la restituzione del capitale sotto forma di biglietti o abbonamenti offerti dall’istituzione stessa (Carlo Fuortes). All’interno di specifiche filiere, inoltre, si sono attivate iniziative di ripensamento di alcuni meccanismi di funzionamento.
Di necessità, virtù. Per la cultura, questo significa istituire una strategia di policy di ampio respiro che agisca non solo sul fronte dell’offerta ma anche, in maniera speculare e complementare, su quello della domanda – che c’è, come ci dimostra l’esperienza di questi giorni.
Proponiamo due macro aree di riflessione:
Occorre approfittare di questo “salto” sul digitale per declinare i profondi legami fra filiere fisiche, esperienze individuali e collettive digitali e live. Che sono tre temi diversi in una prospettiva guidata dall’offerta, ma profondamente interconnessi dal punto di vista della domanda. Se oggi possiamo godere della mostra su Raffaello solo online, come potremo domani integrare la visita virtuale all’esperienza di visita? Come potrà essere aiutato il visitatore ad imparare dallo sforzo di ricerca che c’è dietro alla mostra in tutti i modi possibili?
Occorre riflettere sulle relazioni fra cultura, educazione e turismo. Ci sono 7 milioni di studenti italiani a casa; chi era in difficoltà ha più probabilità ora di restare indietro, per barriere di contesto; l’alleanza strutturale fra mondo della cultura e mondo della scuola va indubbiamente rinforzata, come ha detto molto bene Alessandro Bollo. E poiché possiamo immaginare che i flussi turistici internazionali tarderanno a ripartire, è necessario pensare, da un lato, a modi sofisticati di promozione del nostro patrimonio all’estero e, dall’altro, a come valorizzare le competenze attualmente non utilizzabili per ripensare i significati possibili del termine prossimità e di arricchirli di servizi, ma anche di contenuti.
Le scelte di allocazione di risorse saranno critiche, i modi contano. Il lavoro culturale è in affanno non solo per il Coronavirus, ma anche per questioni strutturali, per pigrizia e per opportunismo. L’emergenza rende indifferibile la riflessione critica e ci costringe a prendere posizione rispetto ai modi e alle priorità.
Ricomponendo le disiecta membra dell’arte classica Raffaello Sanzio fa rivivere l’antico nel presente, inaugurando la Maniera moderna. Ogni sguardo che il presente getta sul passato inevitabilmente lo ristruttura, lo ricompone, mentre il passato stesso illumina il presente e lo irradia da lontano. Raccontando a ritroso la vita dell’artista, la mostra Raffaello. 1520–1483 inverte la direzione del tempo disorientando, come la superficie del nastro di Möbius, che non ha un sotto e un sopra, un interno e un esterno, un inizio e una fine. Ad accogliere il visitatore all’inizio della mostra allestita alla Scuderie del Quirinale è infatti una fine: la riproduzione in scala 1:1 del monumento funebre dell’artista morto a 37 anni. A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia la visita è solo virtuale: video-racconti, approfondimenti e incursioni nel backstage.

Fermo immagine tratto dal video Rematerialising the tomb of Raphael, in Raffaello oltre la mostra.

Fermo immagine tratto dal video Il backstage della mostra Raffaello 1520-1483, in Raffaello oltre la mostra.
Il backstage della mostra RAFFAELLO 1520-1483 mostra il lavoro degli operai impegnati nel trasporto e nella collocazione delle opere. Nei gesti con i quali posizionano a parete la tavola della Madonna dell’Impannata riconosco quello di Maddalena implorante ai piedi della Croce nella Crocifissione di Masaccio e, al tempo stesso, quelli prudenti e premurosi di Giuseppe d’Arimatea e di Nicodemo nella Deposizione di Rosso Fiorentino. Fissati in un fermo immagine dal confronto con le opere dei due pittori, questi gesti comunicano il religioso rispetto per l’arte, divenuta essa stessa una religione.
L’estetizzazione dell’immagine sacra si sviluppa in rapporto alla nozione di personalità (che prepara quella di proprietà) intellettuale ed artistica, nel contesto di una società manifatturiera, commerciale e finanziaria giunta a piena maturità negli anni di Agostino Chigi, imprenditore, banchiere del pontefice romano e mecenate di Raffaello. La capitalizzazione dei “prodotti dello spirito” modifica l’approccio all’opera d’arte sacra: davanti alla tavola della Madonna dell’Impannata esposta alle Gallerie degli Uffizi (ora alle Scuderie del Quirinale) non sostiamo in adorazione del santo gruppo ma dell’opera dell’artista (e aiuti) e dell’artista stesso, che già in un sonetto del 1533 l’Aretino definisce “Divino in venustà”.

Fermo immagine tratto dal video Il backstage della mostra Raffaello 1520-1483, in Raffaello oltre la mostra / Ombra di un pilastro fra le rovine (visione scaturita da uno scambio d’idee con Narciso Silvestrini).
“La sua prematura scomparsa ha reso Raffaello il modello divino della creazione artistica” sottolinea la voce narrante nel video Una passeggiata in mostra. Seguo la voce e il movimento di camera verso la riproduzione in scala dell’edicola del Pantheon, che Raffaello fece restaurate a sue spese, chiedendo a Lorenzetto, suo discepolo e collaboratore, di scolpire una Madonna con il Bambino (Madonna del Sasso). Quando l’inquadratura si sofferma sull’epitaffio inciso sopra la lastra funebre, l’ombra portata da un elemento architettonico fuori campo, forse un capitello o lo spigolo di una cornice, evoca nella mia mente l’immagine di un’architettura resa attraverso la proiezione delle ombre. Della Roma antica, tanto amata da Raffaello, sopravvive l’ombra, mi viene da pensare, considerando che del grandioso progetto di una sua descrizione in ichnographia,orthographia e scaenographia (pianta, prospetto e sezione), di cui Raffaello parla nella Lettera a Leone X, non è stata identificata con certezza alcuna testimonianza iconografica. Raffaello attribuisce al termine scaenographia usato da Vitruvio il significato di “sezione” (Francesco P. Di Teodoro, La Lettera a Leone X, saggio pubblicato nel catalogo della mostra – al momento disponibile solo in PDF – p. 74). Altri interpretano il termine vitruviano come skiagraphia (disegno delle ombre), altri ancora come prospettiva, che l’Urbinate bandisce dalla sua descrizione di Roma antica perché “apertinente al pittore, non allo architetto el quale dalla linea diminuita non può pigliare alchuna iusta misura” (Lettera a Leone X). Raffaello riteneva che il significato di “prospettiva”, attribuito al termine “scaenographia” (sulla scorta dell’illustrazione con la quale Fra Giocondo visualizza il termine nella sua edizione del De architectura pubblicato nel 1511), non avesse senso nel contesto semantico nel quale si trovava. Pensando alla difficoltà interpretativa del termine, in assenza di testimonianze iconografiche riferibili con certezza alla Pianta di Roma antica, l’immagine di Raffaello pittore si mescola nella mia mente a quella di un immaginario Raffaello architetto, che rigetta la prospettiva ma salva la skiagraphia per rappresentare le spoglie di un’architettura nata sotto la potenza della luce dei Greci e dei Latini.
Queste spoglie sono le ombre, come quella di Anticlea che Ulisse tenta inutilmente di afferrare. Il sogno di ricostruire l’Urbe attraverso il disegno architettonico s’interrompe con l’ingresso di Raffaello nel mondo delle ombre, che la mostra mette al centro di se stessa celebrando il quinto centenario della morte dell’artista, avvenuta nella notte del 6 aprile 1520. Fantasticando su una Roma antica rappresentata attraverso la geometria delle ombre anziché attraverso quella del disegno ortografico, proseguo la visita e passo nella sala 2 – La lettera a Leone X.

Raffaello, Ritratto di Baldassare Castiglione, 1513 circa, Parigi, Musée du Louvre.
Con la famosa lettera dedicatoria scritta insieme a Baldassarre Castiglione nel 1519, un anno prima della sua morte, Raffaello inaugura la moderna concezione di tutela e conservazione dei monumenti: “lo aver cura che quel poco che resta di questa antica madre della gloria e della grandezza italiana, per testimonio del valore e della virtù di quegli animi divini, che pur talor con la loro memoria eccitano alla virtù gli spiriti che oggidì sono tra noi, non sia estirpato, e guasto dalli maligni e ignoranti “ (Lettera a Leone X). Roma antica avrebbe continuato tranquillamente a ridursi in polvere se Raffaello non avesse posto dei limiti alla calcinazione dei monumenti antichi. Con l’autorità di “prefetto di tutti i marmi scavati a Roma”, l’artista impone che ogni iscrizione sia sottoposta al suo giudizio per tutelare la lingua latina insieme alle opere d’arte. Nell’età della Rinascenza le lettere vanno di pari passo con le arti figurative. Raffaello prese infatti parte alle diatribe sul paragone tra arte visive e letteratura portandole dentro la sua opera con intelligenza antiquaria. Come osserva Vincenzo Farinello nel saggio Raffaello (modernamente) antico: un viaggio nel tempo, nel catalogo della mostra, l’artista si rivolge a un pubblico “in grado di cogliere, in filigrana, il complesso gioco di rimandi alle principali fonti visive classiche”, così come i poeti e gli umanisti, quando scrivevano prose o versi riecheggiando l’eloquio latino con un effetto linguistico antiquario (p. 143).
Raffaello coglie anche aspetti più sottili e sensibili del rapporto fra arti visive e letteratura. Nello Studio di figura e sonetto conservato all’Ashmolean Museum di Oxford, l’impulso erotico è ingentilito dall’eleganza del segno grafico, che dalla scrittura del sonetto amoroso trapassa direttamente nel disegno di un nudo femminile (Lucia Bertolini e Francesco P. Di Teodoro, Al mio gran foco: Raffaello poeta tra passato prossimo, Petrarca e l’antico, catalogo della mostra).

Raffaello, Studio per drappeggio di figura maschile (recto); Studio di figura e sonetto (verso), 1509-1511, (particolare), Oxford, Ashmolean Museum.
Proseguo la visita virtuale entrando nella sala 5 – Gli arazzi vaticani. A 6’ del video le grandi dimensioni delle opere tradiscono le aberrazioni ottiche della videocamera e la sala si deforma insieme a loro, come Raffaello mai avrebbe voluto. Cosa stiamo guardando? Riprodotta attraverso un altro medium l’opera non è più la stessa: crediamo di vedere attraverso gli occhi di Raffaello e invece guardiamo attraverso l’ottica della camera, gli occhi del cameraman e del regista, che decide le inquadrature, i piani sequenza, i tagli, i raccordi e le dissolvenze. Meglio allora un discorso sull’arte senza inquadrature, piani sequenza e montaggio, come nel video “fai da te” Qualche ragione tra le tante per amare Raffaello, nel quale Marzia Faietti in primissimo piano spiega che la Scuola di Atene affrescata nella Stanza della Segnatura è un manifesto visivo della pace fra tutte le filosofie e le fedi auspicata da Giovanni Pico della Mirandola, preambolo a una pace generale, un proclama di indubbia attualità.

Raffaello, Scuola di Atene, 1509-1511, Stanza della Segnatura, Città del Vaticano, Musei Vaticani.
Le parole hanno una potenza visiva che la controriforma utilizza senza risparmio, come da lì a poco il cardinale Federico Paleotti dimostrerà con il celebre Discorso intorno alle immagini sacre e profane. In Verità a bassissima definizione. Critica e percezione del quotidiano (Einaudi, Torino 1998) Ruggero Pierantoni paragona le interdizioni del cardinale Paleotti alle posizioni teoriche dei proposizionalisti (vedi gli articoli di Zenon Pylyshyn) che, in contrasto con i pittorialisti, sostengono che le immagini mentali sono il prodotto di una sorta d’interlingua proposizionale valida per le informazioni sia di tipo verbale che figurativo.
Imponendo che ogni iscrizione fosse sottoposta al suo giudizio per tutelare la lingua latina, il “prefetto di tutti i marmi scavati a Roma” era un Pylyshyn antiletteram? No, certamente che no. Era un artista della Rinascenza impegnato nella ricerca di una bellezza la cui interpretazione presenta qualche difficoltà. Nella lettera che l’artista avrebbe indirizzato all’amico Castiglione (pare invece che la lettera sia stata scritta dallo stesso Castiglione nel 1522) si trova il riferimento al metodo basato sull’utilizzo di modelli diversi allo scopo di sintetizzare una bellezza ideale di stampo neoplatonico. In aggiunta, a parere di Aretino, Raffaello si attribuisce la qualifica di “leggiadro”, finendo per acquisire anche quella di “grazioso”. Questi due aggettivi concorrono a delineare una concezione della bellezza intesa come “quel non so che”, espressione che forse deriva da uno degli epigrammi di Marziale (Marzia Faietti, Con studio e fantasia, catalogo della mostra, p. 24).

Raffaello, Madonna della seggiola, 1513-1514 circa, Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria Palatina.
In Raffaello la “grazia” è anche il fare senza fatica: la “sprezzatura” che Castiglione teorizza nel Cortegiano riprendendo il concetto di “ars est celare artem” della retorica classica. Riferendosi a questa “naturale facilità” Giorgio Vasari elogia “il dono della grazia delle teste”, che consente a Raffaello di esprimere i differenti moti dell’animo articolandoli in complesse orchestrazioni narrative.

Raffaello, Trasfigurazione, 1518-1520, Città del Vaticano, Musei Vaticani.
Nelle sue opere si avverte una forza trattenuta, ingentilita, che conserva alcuni tratti di quella prorompente del mondo antico. Raffaello coglie la vitalità che pulsa nella forza plastica delle opere antiche addomesticandola con le buone maniere. Nel disegno preparatorio per il Parnaso, dove si vedono tre teste dei poeti antichi e moderni, quella di Omero tradisce una puntuale ripresa della testa del Laocoonte scoperto sul colle Oppio nel 1506, ma l’espressione di dolore muta in quella dell’ispirazione poetica. L’impulso vitale è tradotto in un moto gentile, che scaturisce dall’interno delle sue figure, come sottolinea Achim Gnann nel video Raffaello e Giulio Romano.

Raffaello, Tre teste di poeti per il Parnaso: Omero, Pindaro (?) e Dante, 1510-1511 circa, The Royal Collection / HM Queen Helizabeth / Gruppo del Laocoonte, probabile copia in marmo eseguita tra I secolo a.C. e I secolo d.C. tratta da un originale bronzeo del 150 a.C. circa, Città del Vaticano, Musei Vaticani.
In questi video però si vede e si ascolta anche altro, in maniera inattesa. I grafici potranno ammirare le incursioni visive, generate da errori di codifica digitale, in alcuni passaggi del video La morte di Raffaello di Matteo Lanfranconi, così come gli estimatori del “noise” potranno apprezzare a 4’ e 30’’ del video Raffaello e Giulio Romano l’ascolto di alcune sonorità. Se è vero quello che sostiene Régis Debray, la nostra è una cultura che fa dello sguardo una modalità dell’ascolto: le immagini non stanno più davanti a noi ma ci sommergono, siamo immersi in un flusso visivo che crea un’atmosfera, un paesaggio, quasi sonoro.
La visita virtuale a Raffaello. 1520–1483 pone quindi il problema di una visione (e di un ascolto) dell’opera d’arte visiva che porta lontano e perciò mi aggrappo al PDF che l’ufficio stampa mi ha inviato, in attesa del catalogo (al momento le spedizioni sono bloccate) e della riapertura della mostra. Mentre leggo il saggio di Angelamaria Aceto e Francesco P. Di Teodoro L’architettura disegnata. Nuove indagini e prospettive per “Raffaello architetto”, dedicato alle tracce di architettura presenti sui fogli dell’Urbinate, il progetto di ricomporre le disiecta membra dell’arte classica e di ricostruire in disegno ortografico Roma antica, sfuma nella mia mente in un’archeologia delle ombre, in una visione bizzarra e capricciosa come quella che Giorgio Vasari attribuisce a Giulio Romano, allievo e collaboratore di Raffaello.

Victor Stoichita.
Homo Europæus dalla cima dei capelli alla punta delle scarpe, anche fisicamente Victor Ieronim Stoichita pare provenire da un altro tempo. Impeccabilmente, invidiabilmente parlante tutte le lingue del Continente (il suo italiano è stupefacente), è oggi fra i maestri assoluti di una disciplina, la storia dell’arte, che per sua natura abbraccia uno spazio al di là di tutte le lingue e tutte le frontiere. L’Europa in cui è nato (nel 1949 a Bucarest), quella in cui ha scritto (principalmente in francese) e insegnato (dal 1991 all’Università di Friburgo, in Svizzera) sono state, nel tempo della sua formazione e della sua maturità, per antonomasia il luogo dell’apertura e del dialogo. Lo ricorda lui stesso, in abbrivo alla bellissima conferenza (colla quale ha inaugurato nel 2018 il corso di Cultura Europea che è stato invitato a tenere al Collège de France) su Les Fileuses de Velázquez. Textes, textures, images (Fayard, pp. 52, € 12): l’etimologia di «Europa» viene da due parole greche, eurýs («largo, esteso in lontananza») e óps («sguardo, occhio»), sicché rinvia a uno sguardo esteso. L’Europa ha occhi vasti e profondi: proprio come quelli – abbaglianti di celeste – con cui Stoichita mi guarda, lievemente divertito ma dai modi sempre squisiti, mentre squaderno i suoi libri (una piccola parte dei suoi libri) sul tavolo dell’albergo romano in cui ci siamo dati appuntamento, e che ha un nome inevitabile: Hotel Cosmopolita.
L’occasione della sua visita è stata la ricca mostra su Ovidio alle Scuderie del Quirinale, ed è stato anche festeggiato dall’Accademia di Romania: cioè il luogo in cui risiedeva quarant’anni fa, quando studiava con Cesare Brandi. Di quella residenza a Roma, risultata poi davvero decisiva, si favoleggia a lungo nel primo volume della sua autobiografia, uscito nel 2014 da Actes Sud e ancora non tradotto da noi: il titolo, Oublier Bucarest, suona duro colla propria terra d’origine (ma forse solo per un lettore italiano). Il volume successivo, proprio sugli anni passati in Italia, Stoichita lo sta scrivendo nelle pause dei suoi vagabondaggi, delle sue mille conferenze e seminari. Una vita da clericus vagans, invidiabile quanto inattuale: in lungo e in largo per un continente che all’improvviso rialza muri e dazi, frontiere che ci eravamo illusi di esserci lasciati alle spalle e che, solo qualche decennio fa, hanno sparso il sangue di milioni di europei. L’albergo in cui chiacchieriamo si trova a due passi da Piazza Venezia: qui fu dichiarata una guerra che il paese in cui ci troviamo lo uccise, quasi. La prima cosa che gli chiedo è quanto l’Europa di oggi sia ancora quella della sua giovinezza, e cosa abbia ancora da insegnare al «mondo grande e terribile» di cui parlava Gramsci.

Diego Velazquez, La fabula de arance o las hilanderas, Museo del Prado, 1657-58.
S.: È un sentimento ambivalente, il mio. Perché è vero che mi sono sempre sentito un cittadino europeo, ma è vero pure che sono nato e cresciuto in un paese chiuso e diffidente come la Romania, anche se per fortuna in un ambiente famigliare intellettualmente molto aperto. Quella di allora era un’Europa fatta di centri e periferie; per gli intellettuali rumeni di allora il centro restava Parigi, ma anche Roma e il suo mito avevano lo stesso significato. Questa nostalgia del centro, una volta partito dalla Romania, mi è passata. L’Europa è riuscita a rifondarsi proprio lasciando da parte questa scissione, fra centro e periferie, che non ha più motivo di esistere.
C.: Fra l’altro dove vivi è quasi esattamente il centro, in senso geografico, dell’Europa.
S.: Questo si deve a un caso… L’Europa di oggi mi dà un senso d’inquietudine, come a tutti. Cerco di restare ottimista, di pensare all’Europa come a un’unità culturale che, sulle basi greco-romane e giudeo-cristiane, tanto ha dato al mondo intero. Per evitare la disgregazione che rischia, forse l’Europa deve recuperare proprio la sua funzione di centro ideale, non vergognarsi di averla svolta, smettere di sentirsi sempre così in colpa. Credo che il mondo abbia ancora bisogno dei nostri valori.
C.: Il tuo ultimo libro uscito in italiano, L’immagine dell’Altro (vedi la recensione di Valentina Manchia) recensito è dedicato proprio al costituirsi dell’identità europea attraverso lo sguardo rivolto, spesso in termini piuttosto discutibili diciamo, sull’altro da sé.
S.: Sono partito da una domanda: come si forma l’immagine dell’alterità in un’epoca chiave, fra Rinascimento e Barocco, in cui si cristallizza un canone estetico europeo basato su una certa nozione di bellezza e armonia, prospettiva, spazialità e composizione? Qual è il posto dell’Altro, in questo cosmo perfettamente ordinato?
C.: Lo studioso che ha più riflettuto sulla categoria dell’esilio, Edward Said, invitava a distinguere tra l’esiliato vero e proprio, l’espatriato e l’emigrato: tre figure contigue ma che si muovono per motivi diversi (anche se queste distinzioni non vanno troppo irrigidite, in un tempo in cui le destre insistono a distinguere fra il «rifugiato» e il «migrante economico», come se la fame non fosse un motivo serio per espatriare…). In uno dei suoi saggi Said cita Auerbach, che a sua volta cita un passo del teologo del XII secolo, Ugo di San Vittore…
S.: … «l’anima acerba concentra il suo amore su un posto nel mondo; l’uomo forte ha esteso il suo amore a ogni posto nel mondo; l’uomo perfetto l’ha saputo estinguere». Ho trovato il passo di Said in un saggio di Tzvetan Todorov e mi colpiva questa coincidenza, di un bulgaro che scrive a Parigi citando un palestinese che scrive a New York, che cita un tedesco che scrive in Turchia, che cita un mistico tedesco che scrive anche lui a Parigi; si parva licet mi dicevo che anche un rumeno in Svizzera, in fondo, poteva rientrare in questa genealogia. Certo le parole di Ugo di San Vittore oggi suonano un po’ forti. Questa circolarità mistica non mi può appartenere, ma la vedo all’orizzonte come una meta irraggiungibile: essere di nessuna parte e quindi di tutte le parti.
C.: A un temperamento come quello di Said invece si attaglia meglio. Faccio fatica in effetti a immaginare espatriati – «extraterritoriali», per usare la nozione più neutra di George Steiner – più diversi di te e Said. Non c’è pagina di Oublier Bucarest in cui si avverta l’agonismo drammatico, il risentimento antagonista, l’afflato quasi eroico dell’esiliato; c’è invece un aplomb, una serenità, una «leggerezza apparente» – per dirla col nostro Leopardi – che ne fa un testo abbastanza unico nella “letteratura extraterritoriale”.
S.: Sono contento se si percepisce questo. Ho cominciato a scrivere Oublier Bucarest per i miei figli, per trasmettergli quel mondo sparito che era la Romania d’oltrecortina, poi mi sono accorto che mi faceva bene prendere questa distanza nella scrittura. Scriverlo ha avuto una funzione anche terapeutica. Certo conosco bene la letteratura della memoria scritta dopo la caduta del Muro, e si tratta quasi sempre di testi di denuncia. A volte scritti drammaticamente bene, più spesso solo querimoniosi. A questo genere avevo ben chiaro che volessi sfuggire. Anche se poi certi drammi, nel testo, non sono rimossi: persone incarcerate, come mio nonno e mio zio, anche morte in carcere, il controllo soffocante dello Stato su ogni ambiente intellettuale. Mi premeva però rendere soprattutto l’assurdo, il grottesco di certe situazioni.
C.: Conta anche che al centro della narrazione ci sia quella che potremmo chiamare una breve “primavera di Bucarest”, che fu anche l’occasione in cui riuscisti ad andare a studiare in Occidente.
S.: Sì, fra il ’65 e il ’72 circa. Per mera strumentalità politica Ceaușescu voleva creare l’immagine di una Romania enfant terrible del blocco dell’Est, fra la Cina e l’Unione Sovietica... La mia generazione ne ha approfittato, come nel mio caso, ma l’aspetto tragico è che credemmo fosse vero, che davvero il Paese si aprisse e si stesse creando una “terza via”. Non fu così. Nel ’72 Ceaușescu con la moglie fece un viaggio in Cina e in Corea del Nord, e al loro ritorno ci fu una riunione del Partito dalla quale uscirono le famigerate «tesi di luglio» che segnarono la fine di quella stagione. Poi negli anni Ottanta andò sempre peggio, subentrò una paranoia del potere, furono tempi davvero tragici. Anche chi coltivava ideali socialisti dovette prendere atto che Ceaușescu non aveva niente di sinistra. Nazionalista all’estremo contro russi e ungheresi, antisemita; dal punto di vista antropologico, semplicemente un fascista.
C.: Non so se è una bestialità ricondurlo alla destra rumena pre-1945…
S.: … come no?… certi reduci della Guardia di Ferro riuscirono a far parte della Securitate!
C.: All’Accademia di Romania, qui a Roma, hai fatto una bellissima conferenza sulla “diaspora intellettuale rumena” del Novecento, impiegando come case studies le figure di Paul Celan, Emil Cioran e Robert Klein (il grande storico dell’arte che si suicidò – come Celan a Parigi nel ’70 – alla Villa «I Tatti» di Firenze nel ’67). Ma c’è un’altra koinè di rumeni in esilio che furono grandi maestri dell’Assurdo: Tzara, Ionesco. E leggendo certi episodi di Oublier Bucarestè a questa tradizione che viene da pensare… Forse anche la fine corrusca di questa storia, il processo a Ceaușescu ripreso dalla televisione, può essere letto in questa chiave.

Victor Stoichita, Oublier Bucarest actes sud, 2014.

Victor Stoichita, Effetto Sherlock, Il Saggiatore, 2017.
S.: Fu una vergogna. Gli avrebbero dovuto fare un vero processo, ma fu impossibile per ragioni pratiche…
C.: … un po’ come a Mussolini nel ’45…
S.: … mi sento di dire che sarebbe stata meglio una morte brutale come quella di Mussolini. Quello suo non fu in alcun modo un processo, mentre fu atroce quella finzione, la parodia di processo che si fece a Ceaușescu. Una farsa davvero da teatro dell’assurdo, nonché una nemesi: perché fu resa possibile da come lui stesso aveva pervertito, negli anni precedenti, il sistema giuridico rumeno.
C.: Veniamo ora alla tua biografia prettamente intellettuale. Un contributo alla critica di te stesso. Mi colpisce il romanzo di una doppia formazione: nella giovinezza i tuoi studi sono improntati a un forte appello alla tradizione, all’archeologia e alla filologia classica, e anche il periodo di formazione a Roma – sebbene Brandi non fosse certo uno storicista tradizionale – ti conferisce un’impostazione molto strutturata. I tuoi primi libri, in rumeno, sono monografie (suppongo appunto assai tradizionali) su figure come Duccio di Buoninsegna, Simone Martini e Pontormo. Poi negli anni Ottanta c’è una specie di latenza. Per un bel pezzo non pubblichi quasi nulla, e il saggista che scrive dopo è un altro. Capovolgi quell’impostazione iniziale, metti al centro il problema della meta-rappresentazione cui dedichi il libro che all’inizio degli anni Novanta ti dà la fama internazionale, L’invenzione del quadro.

Invenzione del quadro, Il Saggiatore, 1998.
S.: Sì, c’è stata una svolta. Quando ho deciso di lasciare per sempre il mio Paese mi sono trasferito in Germania, a Monaco all’inizio degli anni Ottanta, e lì mi sono confrontato con la nuova storia dell’arte, nuove domande e una nuova generazione di studiosi. La figura-chiave è stata Hans Belting.

El Greco, View of Toledo, Google art project.
C.: Però quella robusta formazione tradizionale forse è rimasta, a rinsaldare le basi dei tuoi lavori. Quando leggo il caposcuola della semiotica della pittura, Louis Marin, o certi suoi colleghi e discepoli geniali come Daniel Arasse o Hubert Damisch, mi rendo contro della differenza che li divide da te: i tuoi studi hanno un fondo di erudizione, di spessore storico e competenza anche sul contesto culturale dei fenomeni osservati, che irrobustisce un’audacia di pensiero e speculazione che in altri casi, invece, dà talvolta l’impressione di voli inebrianti spiccati senza uno slancio sufficiente.
S.: Sono un ibrido. Rumeno di prima formazione italiana e di seconda formazione tedesca e anglosassone, con contatti col mondo dello strutturalismo francese. I compagni della scuola francese che hai citato, e che io apprezzo molto, certo sono diversi. In realtà Belting discende da Warburg e dalla tradizione germanica. Spero che questa ibridazione frutti qualcosa di buono!
C.: Leggendo uno dopo l’altro, come è capitato a me, due libri che si pongono agli estremi del tuo percorso, L’invenzione del quadro (il Saggiatore 1998) ed Effetto Sherlock (ivi 2017), si riconosce un tema comune, quello dell’ostacolo posto alla percezione. Lo sguardo intralciato dagli schermi che si frappongono tra l’occhio e l’oggetto, nel libro più recente, in qualche misura trova la sua risposta nel libro precedente, dedicato allo sfondamento dello spazio nella meta-rappresentazione.
S.: Il titolo che avevo pensato all’inizio per Oublier Bucarest era Le frontiere invisibili. È un concetto che ho preso da uno storico tedesco degli anni Trenta, Ernst Kornemann, secondo il quale le vere frontiere dell’Impero romano non erano quelle naturali, territoriali, bensì quelle mentali, culturali. È un concetto che ha un significato diverso per un rumeno, proveniente da una provincia dell’Impero come la Dacia o la Tracia, uno nato nella terra che in Occidente incarna, con Ovidio, l’idea stessa dell’Esilio. Quando tornavo a Roma dalle estati passate a Costanza, cioè all’antica Tomi, Brandi esclamava sempre: «Ah, ecco il nostro Ovidio!». Ma quella che era per lui la terra dell’Esilio era per me, invece, quella dell’Origine. Un capovolgimento che mi colpiva moltissimo. E ricordo quanto mi infastidisse da ragazzo leggere le descrizioni del Ponto ghiacciato, delle montagne, delle nevi… mi chiedevo se ci fosse stato davvero, da quelle parti, Ovidio (un interrogativo che oggi qualcuno si pone sul serio). Poi ho capito che quella geografia immaginaria era un perfetto esempio di «frontiera invisibile». E oggi uno degli ultimi capitoli di Oublier Bucarest si conclude con una citazione dalle Epistulæ ex Ponto: «esiliato all’estremità del mondo, su una spiaggia abbandonata, in una contrada selvaggia sotto nevi perpetue».
C.: Ecco, ma ha un significato che la tua avventura di cittadino europeo, che rivendica con orgoglio l’apertura di uno spazio senza frontiere, cominci in effetti con un saggio geniale, L’invenzione del quadro appunto, che ricostruisce la tradizione dell’apertura, dentro l’immagine, di una finestra aperta su un altro ambiente (che magari riflette quello dal quale stiamo guardando, come nell’esempio canonico delle Meninas di Velázquez)?
S.: Non ci ho mai pensato, ma è possibile ci sia una qualche proiezione personale, sì. È vero che soffro di una forma moderata di claustrofobia. Insomma, in effetti mi piacciono gli spazi aperti. Non potrei quasi vivere senza passare qualche settimana al mare: il mare aperto, l’orizzonte. Lì veramente mi ricostruisco.
C.: Hai mai scritto sul paesaggio? Non il paesaggio inquadrato, rappresentato, meta-rappresentato, ma proprio l’en plein air…
S.: Poco, ma m’interesserebbe. Ho molti appunti sull’orizzonte, mi piacerebbe lavorare su questo. L’orizzonte è un confine a sua volta, ma dinamico. Invece ho scritto diverse volte del cielo. Cieli in cornice (Meltemi 2002) è un libro sulla rappresentazione della visione nella pittura di El Greco, Zurbarán e Velázquez in relazione alla mistica spagnola.
C.: In questi casi però il cielo è sempre un’illusione ottica; c’è sempre un soffitto, a porre un limite allo sfondamento della visione. Ricordo un pezzo fantastico di Giorgio Manganelli su Tiepolo, Il soffitto come palcoscenico, sul quale Roberto Calasso ha impostato un intero libro (Il rosa Tiepolo, Adelphi 2006).
S.: Certo, il soffitto è una superficie-chiave: rappresenta l’illusione di aprirsi verso il cielo, un cielo che scende sulla chiesa o una chiesa che si apre verso il cielo. Ci sono esempi strepitosi, nel Barocco italiano e non solo. Anche la nuvola è un oggetto importante in questo tipo di figurazione, perché è di un’assoluta ambiguità. Ti pare di riconoscere qualcosa, e subito dopo no. Come il Cristo, la Vergine o gli Angeli: ci sono e non ci sono.
C.: Nella sua Teoria della nuvola (Costa & Nolan 1984) Damisch ha pagine molto belle su un quadro di Correggio…
S.: … Giove e Io, fantastico. La nuvola come metamorfosi possibile, che prende figura umana o divina restando nella sua ambiguità fra visivo e tattile.

Correggio Giove e io, Vienna, Kunsthistorisches museum, 1532.
C.: Un altro tuo tema prediletto è quello dell’illusione. Ben al di là delle teorie della Gestalt, o della trattazione del tema per esempio in Gombrich. In effetti nei tuoi libri poni sempre in questione con forza le categorie di realtà e di realismo. In Effetto Sherlock una citazione chiave è da un testo giovanile di Émile Zola che non conoscevo, Lo schermo, del 1866: «ogni opera d’arte è come una finestra aperta sulla creazione; inserito nel vano della finestra, c’è come una sorta di Schermo trasparente, attraverso il quale si percepiscono gli oggetti più o meno deformati […] e questa riproduzione, che non può essere fedele, cambierà ogni volta che un nuovo schermo verrà a frapporsi tra il nostro occhio e la creazione. […] Lo schermo realista è una semplice lastra di vetro, molto sottile, molto chiara […]. Lo schermo realista nega la sua stessa esistenza». Qui Zola, riprendendo il classico argomento di Leon Battista Alberti, pare anticipare il concetto di realismo come lo porrà Roland Barthes: in chiave appunto di illusione, di dispositivo retorico che inganna o comunque simula una realtà, in effetti, inaccessibile. Questo tema mi pare decisivo oggi che, dopo il postmodernismo, tanto in ambito propriamente filosofico che artistico e letterario si fa un gran parlare di «ritorno alla realtà», «nuovo realismo» eccetera. Al di là della pertinenza dell’istanza in termini etici, forse prima che politico-sociali, occorrerebbe restare sempre consapevoli di questa riserva gnoseologica.
S.: Il realismo non è che un sistema di rappresentazione. Anche autori che sono stati letti in questa chiave, per esempio Caravaggio, realizzano in effetti sempre sistemi di sdoppiamento. Nell’Immagine dell’Altro parlo di due quadri quasi contemporanei, il Narciso (la cui autografia viene oggi contestata, ma a me qui non importa perché, se pure non l’ha dipinto lui, funziona in effetti come epitome del suo stile) e La buona ventura. Lo sdoppiamento della personalità e l’incontro effettivo con l’Altro (la zingara che legge la mano al giovane gentiluomo) compongono un chiasmo: l’identità narcisistica e il faccia a faccia sono due aspetti dello stesso problema di rappresentazione.

Caravaggio attribuito a Narciso alla fonte, Roma, Palazzo Barberini.
C.: Nella tua opera c’è quello che magari è solo un dettaglio, che però m’incuriosisce. In quasi ogni tuo libro a un certo punto viene citato un film di Hitchcock. A volte coinvolgendolo nell’analisi, altre restando come una spraghìs, alla stregua dei cammei che recitava lui stesso nei suoi film. A parte l’effettiva cultura artistica di Hitchcock, da ultimo sempre più riconosciuta come decisiva nella sua opera, mi colpisce questa tua relazione col cinema. A colpirmi nei tuoi libri, specie nei più recenti, è come la loro straordinaria cultura storica e sottigliezza interpretativa si coniughi con una godibilità di lettura evidente anche a un lettore non specialista. Forse il cinema in questo ti ha aiutato.
S.: Da ragazzo ero un vero aficionado, il cinema mi dava un piacere davvero epidermico, irresistibile. Poi, diventato uno studioso, certo è subentrata un’attenzione diversa, ma quel fondo di immediato «piacere del testo» è rimasto. E chi meglio di Hitchcock – che la nouvelle vague canonizza proprio perché autore popolare presso il grande pubblico, ma in effetti molto colto e straordinariamente raffinato – può incarnare questo doppio livello? Questa doppiezza cerco di perseguirla in ogni cosa che scrivo: che è sempre rivolta a un pubblico certo intelligente ma non necessariamente specialistico. È una grande ambizione questa, che deriva dalla mia passione per la letteratura. Il mio nonno materno era uno scrittore, ma la mia ambizione letteraria deve fare i conti con le difficoltà linguistiche che, al di là delle apparenze, limitano il mio modo di esprimermi. Per scrivere veramente letteratura devi possedere una lingua, ma io di lingue ne ho molte e quindi non ne ho nessuna, forse. Mi devo difendere con quello che ho.
C.: Nella conferenza all’Accademia di Romania hai parlato a lungo di questa questione della lingua, e del problema del nome proprio (cruciale, per esempio, in Celan-Antschel). All’inizio della sua autobiografia, Sempre nel posto sbagliato (Feltrinelli 2000), Said inizia proprio col suo nome, che tutti pronunciano sempre in modo appunto sbagliato. Che è un modo per rendersi conto di come nessuna parola che pronunciamo coincide mai davvero con la cosa cui si riferisce. Ma è un problema che riguarda anche te: io stesso pronuncio il tuo cognome – che bisognerebbe scrivere «Stoichiţă» – ogni volta in modo diverso (è stato utile il tuo suggerimento, di provare a pronunciarlo come in dialetto calabrese, con l’ultima «a» aspirata…). Al di là dell’aneddoto, questa tua vita fra le patrie e fra le lingue quanto condiziona il tuo vissuto, o insomma quella che un riflesso condizionato ideologico non ci consente più di chiamare a cuor leggero la tua «identità»?
S.: Cerco di risponderti in modo indiretto. Mia moglie Anna Maria Coderch è spagnola, abbiamo anche scritto insieme un libro su Goya (L’ultimo carnevale, il Saggiatore 2002). E i nostri figli sono nati a Monaco negli anni Ottanta. Dunque hanno, diciamo, tre lingue madri. Quando chiedevano a nostra figlia Maria cosa sentisse di essere lei a sei o sette anni rispondeva decisa: «ich bin bayerisch», «sono bavarese». Ora Maria è psichiatra a Berlino, si sta specializzando in psicoanalisi transculturale, chissà cosa risponderebbe! Invece nostro figlio Pedro, artista e autore di fumetti filosofici sposato con una toscana e padre di un figlio italo-spagnolo-rumeno, la prendeva anche lui alla lontana, spiegava tutta la situazione, e alla fine concludeva: «non lo so, forse sono europeo». A me è successo questo: quando a un certo punto mi si è presentata la possibilità di trasferirmi negli Stati Uniti mi piaceva il tempo che passavo lì, quello dei campus è un ambiente appunto cosmopolita. Ma a trecento metri di distanza ti rendi conto che se vai lì devi diventare americano. E non ce l’ho fatta. Allora mi sono detto che volevo restare… cosa? Quello che sono riuscito a rispondermi è che resto irriducibilmente europeo.
***
L’ultimo libro di Victor Stoichita, Des corps. Anatomies, défenses, fantasmes (appena uscito da Droz, pp. 391 ill. a colori, € 24), come le sue precedenti “raccolte di saggi”, può vantare un’invidiabile compattezza: dal momento che s’impernia – anziché su contributi più o meno d’occasione – su cicli di conferenze a tema, trovando nella fattispecie un baricentro nelle “Bernard Berenson Lectures” tenute ai Tatti di Firenze (dove lo studioso passerà un’ulteriore residenza la prossima primavera) nel 2017. Il sottotitolo articola con esattezza il cluster tematico messo a fuoco: naturalmente gli elmi e le armature (come nel prodigioso Carlo V di Tiziano) e più in generale gli indumenti (dal Giotto degli Scrovegni, ancora, alla panoplia di corsetti e farsetti della ritrattistica Escuriale) ma anche e più sottilmente i tatuaggi e gli stessi contegni dei volti, rivestiti da queste apparecchiature epidermiche e muscolari, sono tutti “seconde pelli”: ossia «dispositivi di protezione» che danno corpo, è il caso di dire, a un’«umanità aumentata» che mediante questi paraphernalia rappresenta sé stessa e i propri ruoli e mansioni. Se ogni ritratto è una rappresentazione del potere, spirituale o terreno, della persona raffigurata, i suoi attributi esteriori sono una prima sfera, spesso ingombrante ma talvolta intollerabilmente intima, di quest’aura. E, anche laddove il corpo si sottragga, esso potrà risultare non meno incombente, o infestante, nella forma spettrale del “corpo mancante” (detto come si dice, per metonimia, dell’“arto mancante”).
Una versione più breve di questa conversazione è stata pubblicata su “Alias” di “Il manifesto” il 1/03/2020.

Andreas Gursky, Amazon, 2016, Courtesy dell’artista e di Sprüth Magers © Andreas Gursky / ADAGP, 2019.
In alcuni scritti degli anni novanta, l’artista e teorico italiano Franco Vaccari s’interessava al valore iconico ed economico del codice a barre, “segno dei tempi” e scrittura codificata della “natura profonda dell’oggetto” che, inequivocabilmente identificato in ogni minima variazione, era così pronto a immettersi in un “circuito in cui […] muoversi, il più rapidamente possibile, opponendo la minima resistenza, fino ad arrivare al consumatore” (Scritti sul codice a barre, 1991). L’opacità del codice, l’accessibilità mediata delle informazioni celate in questo segno, ottico ed elettronico, “discreto” ma “inesorabile”, si opponeva e accompagnava lo “sfavillio delle superfici”, “l’enfasi spettacolare delle confezioni”. Opacizzando l’oggetto, il codice a barre rendeva visibile la sua appartenenza a un flusso, a una rete di scambi e di valori le cui regole, scriveva ancora Vaccari, sono rette da un principio di superconduttività: “in sostanza una circolazione senza attriti, senza ostacoli, senza dissipazione di energia; con essa si realizzerebbe una possibilità di movimento illimitato. Ma questo non rappresenta forse l’ideale della merce e dei capitali, non è il segno del potere?”. Tale superconduttività, una circolazione continua e senza attrito, caratterizza allora la vita delle immagini in un regime capitalista: quest’ultimo fornisce al dominio del visibile un modello di funzionamento, quello della “celebrazione di un culto sans [t]rêve et sans merci [senza tregua e senza pietà]”, scriveva Benjamin nell’oscuro e breve testo Il capitalismo come religione (1921). Il culto dell’immagine e quello del denaro convivono in un unico movimento, lo spirito del capitalismo è quello “che parla dall’ornamento delle banconote”, scrive ancora Benjamin in questo testo, prima di aggiungere il seguente promemoria: “Paragone tra, da un lato, le immagini sacre delle diverse religioni e, dall’altro, le banconote dei diversi Stati”.
Nel suo testo Le supermarché du visible. Essai d’iconomie (2017), il filosofo e musicologo francese Peter Szendy ha parlato, a tal proposito, di iconomia (eikon, immagine + oikonomia, il buon governo, la buona gestione degli scambi): un'economia del visibile, cioè una riflessione sul valore economico e di scambio delle immagini, sulla loro circolazione in una dimensione mediale e estetica che si plasma su quella del mercato, che ne assume istanze e regole. Le supermarché des images, la mostra ora in corso al Museo del Jeu de Paume di Parigi, riprende gli assunti teorici del testo di Szendy, che di questo insolito supermercato è curatore insieme a Emmanuel Alloa e Marta Ponsa, e li articola in cinque sezioni: Stock, Materie prime, Lavoro, Valori e Scambi. Si potrebbe dire che le tantissime opere presentate, sessantasette per quarantotto artisti rappresentati, saturano la mostra, performando così il presupposto stesso dell’esposizione: “Ci sono così tante immagini. Tante e tante immagini. Il loro numero è immenso. La loro folla, il loro flusso è letteralmente incommensurabile”. Il principio alla base di Le supermarché des images appare quindi quanto mai semplice, tanto da sembrare un’ovvietà: viviamo in un mondo saturo d’immagini e ciascuno di noi contribuisce a quest’accumulazione, potenzialmente senza fine. Scambiando e consumando immagini, noi tutti produciamo e stocchiamo dati, percorriamo a grande velocità le “infrastrutture”, l’espressione è di Szendy, della visibilità: l’opera monumentale di Evan Roth, Since You Were Born (2019-2020), mette in scena questa saturazione, esponendo senza nessuna selezione o gerarchia tutte le immagini cache generate dalle ricerche che l’artista ha fatto on-line nei quattro mesi successivi alla nascita della sua seconda figlia. Su una parete colma di riferimenti visivi, volti e loghi condividono lo stesso spazio e lo stesso destino: sono memorie involontarie, residui del visibile che formano un ritratto “insieme personale e universale del XXI secolo”.

Evan Roth, Since You Were Born, 2019 © Photo by Bob Self/The Florida Times-Union / Courtesy of MOCA, Jacksonville, Florida.
L’intero ambito del visibile quindi, sembrano suggerire ancora le opere di Geraldine Suarez – Gerry Images, 2014 e Storage, 2019–, non sarebbe altro che un’inesauribile banca dati; o ancora, lo si potrebbe immaginare come l’immenso deposito di Amazon fotografato da Andreas Gursky (Amazon, 2016), dove la merce in attesa di essere spedita evoca la massa di pixel di cui si compone l’immagine, di grande formato e in alta definizione, ordinati in griglie e catene, in attesa di essere disaggregati e inoltrati, pronti a essere scambiati sul mercato delle immagini.

Geraldine Juárez, Gerry Images, 2014, Courtesy dell'artista © Documentation images Philipp Ottendörfer.
Szendy pensa questa luminosa e fantasmagorica sovrabbondanza nei termini, quindi, di un’infrastruttura, di una rete commerciale o stradale, capillare nella sua diffusione, capace di connettere tra loro territori remoti, di generare movimento perpetuo ma anche di nascondere sotto lo sfavillio importanti zone d’ombra, di occultare proprio attraverso l’eccesso di visibilità, poiché esistono più luoghi che strade, come dice Rodari in una bella fiaba e non tutti sono raggiungibili seguendo le vie più battute. Ecco allora che si profilano inediti, invisibili paesaggi, nuovi milieu non abitabili e non visibili dall’uomo, immagini non prodotte dai nostri occhi in carne ed ossa, né a loro destinate: la visione non è più solo affare di luce e retina, ma anche di ombra e algoritmi (Trevor Paglen, Shoshone Falls, Hough Transform; Haar, 2017), di cavi che percorrono gli abissi del visibile e, molto concretamente, dei nostri mari (Paglen, NSA-Tapped Undersea Cables, North Pacific Ocean, 2016), trasportando, osserva Paglen, il 99% delle nostre informazioni e comunicazioni.
Parafrasando Michel Foucault si potrebbe qui dire che anche la non-visibilità è una trappola, nella misura in cui in questi interstizi, angoli apparentemente morti, si producono operazioni massicce di sorveglianza e di controllo. Se i dati sembrano smaterializzarsi, non si può dire lo stesso delle infrastrutture che li fanno circolare: più che rarefarsi in una nuvola, Internet percorre i nostri mari, innerva la superficie del globo. L’idea d’innervazione, che Szendy riprende da Benjamin, è centrale e può rappresentare, per il visitatore della mostra, il filo da seguire per non lasciarsi sopraffare dalla fantasmagoria qui messa in scena. Questa innervazione traduce in fondo la voracità e la velocità del “traffico iconico”, l’idea che il visibile sia un flusso costante e costantemente generato dalla circolazione delle immagini, un traffico che genera contatto e che conferisce allo spazio e al tempo nuove coordinate. La nozione di innervazione è, infatti, reinterpretata da Szendy come “apertura delle vie dello sguardo” all'interno della stessa visibilità, un circuito in cui gli sguardi circolano tanto quanto le immagini (Julien Prévieux, Patterns of Life, 2015). Gli algoritmi di trading “dissidenti”, “eretici e irrazionali” di ADM XI, 2015, opera del collettivo RYBN.ORG, raccolgono in pieno l’idea benjaminiana di un’innervazione che opera secondo una contaminazione di tecnico e organico. L’andamento dei grafici non corrisponde, infatti, a quello dei profitti, ma è determinato e animato da variazioni dettate da organismi viventi – vegetali, batteri – o regolato da leggi astronomiche, ambientali o ancora da formule matematiche esoteriche.

RYBN.ORG, ADM XI, 2015. Vue de l''installation, Festival Gamerz, Fondation Vasarely, Aix-en-Provence, 2016 © RYBN.ORG, Photo Luce Moreau.
La “circolazione iconica universale”, sia essa visibile o sottotraccia, innerva e disegna una nuova geografia dello sguardo poiché, scrive Szendy, “l'iconomia a venire sarà una geopolitica delle immagini”, che introduce temporalità eterogenee e velocità disparate. Alla dimensione dello choc, l’istantaneo apparire dell’immagine fotografica alla fine del XIX secolo descritto da Benjamin, si aggiungono infatti – come modi dell’apparizione, della fruizione e della circolazione delle immagini – quella del flusso, come osserva Maurizio Lazzarato nel testo Après le cinéma, pubblicato nel ricco catalogo della mostra, e quella del clic, come mostra l’installazione video di Martin Le Chevallier, Clickworkers, (2017), presentata nella sezione dedicata al Lavoro. Qui, il tema dell’invisibilità diventa centrale; la performance e il gesto che producono valore e scambio (Harun Farocki & Antje Ehmann, Eine Einstellung zur Arbeit, 2011) oscillano tra materialità e immaterialità, prossimità o distanza, manipolazione o sguardo operante che ricompone i puzzle CAPTCHA (Aram Bartholl, Are You Human?, 2017).

Aram Bartholl, Are You Human ?, 2017, Courtesy dell’artista. Vue d'exposition au Kallmann Museum, Ismaning. © Aram Bartholl.
L’ipervisibilità del denaro gli fa poi eco nella sezione Valori, dove gli sguardi concupiscenti registrati da Sophie Calle (Cash Machine, 1991-2003 e Unfinished, 2003) si accompagnano alle mani che toccano e intascano banconote del trailer del film Argent (1983) di Robert Bresson; o ancora alle banconote che si moltiplicano nel dispositivo ottico realizzato da Wilfredo Prieto, One Million Dollars, 2002, in cui un biglietto da un dollaro inserito tra due specchi si riflette un milione di volte. In questa sezione, fa irruzione quindi il secondo importante riferimento teorico di Szendy. Dopo Benjamin, è a Gilles Deleuze e alla sua immagine-tempo (Cinéma 2. L’image-temps, 1985) che il filosofo curatore si rivolge per pensare il denaro come il rovescio delle immagini: il cinema è tempo e il tempo è denaro; il visibile, l’icona, il film, è lato trasparente, scrive Deleuze, la moneta, il suo valore di scambio, è l’elemento opacizzante.
Le immagini quindi, dice Szendy immettendo Benjamin e Deleuze in un unico movimento di pensiero, non sono la rappresentazione del mondo, ma ne sono la trama, la materia prima, il movimento. Il visibile che esse producono e occultano è quindi materia, stoffa del reale: codificato, opacizzato, manipolato, archiviato o scomposto in porzioni, moduli, dati e numeri, pixel (Victor Vasarely, Arlequin, 1935; Taysir Batniji, Disruptions, 2015-2017) ingrandito ed espanso (Thomas Ruff, Substrat 8 II, 2002). Nel video Adressability, 2011 di Jeff Guess vediamo proprio dei pixel – unità minima dell'immagine digitale e elemento che fornisce la misura della sua risoluzione, del suo valore referenziale rispetto alla realtà, dello scambio tra immagine e mondo – che si aggregano nel cosmo, fino al cruciale momento in cui, per costituire un’immagine, si combinano per renderla visibile.

Jeff Guess, Addressability, 2011, Courtesy dell’artista © Jeff Guess.
Distrutte le brume dell’aura, rifiutata la posizione contemplativa dello spettatore – sempre più prossimo alle immagini di cui diviene produttore, consumatore, aptico fruitore – l’occhio macchinico conduceva un tempo l’occhio umano verso dimensioni del visibile ancora inesplorate; anzi le creava, strappando a colpi di flash il velo auratico e potenziando le possibilità percettive dell’uomo, sottoponendo “il sensorio […] a un training di ordine complesso” (Benjamin, Su alcuni motivi in Baudelaire). Oggi siamo già oltre la soglia di un altro cambiamento epocale. Il sensorio umano si prolunga, innervandosi nelle tecniche di produzione e riproduzione del visibile, si sviluppa e si avviluppa nella valanga d’immagini che produce e subisce, incontra altre e non umane percezioni, nuove forme di visione. “Non guardiamo più le immagini – le immagini guardano noi. Esse non rappresentano più semplicemente le cose, ma intervengono attivamente nella vita quotidiana. Dobbiamo cominciare a capire questi cambiamenti se vogliamo sfidare le eccezionali forme di potere che fluiscono attraverso la cultura visiva invisibile in cui ci troviamo immersi.” (Trevor Paglen, Invisible Images (Your Pictures Are Looking at You).
In questo testo, scritto prima dell’esplosione della crisi sanitaria in Europa e nel mondo, e nella mostra che esso vuole commentare, è questione di vita delle immagini, intesa come circolazione senza freni e inibizioni, del loro destino come accumulazione, della loro capacità di comporre il visibile per infrastrutture, secondo un regime scopico che ricalcava il regime economico capitalista. Molte delle questioni che la mostra sollevava appartengono a un mondo pre-pandemia. Il modello economico, sociale, ambientale che ha concorso in larga parte alla propagazione del virus e che ora è congelato nei lockdown che hanno coinvolto in sequenza quasi tutti i paesi del mondo, forse si è esaurito e quel peculiare modo di esistenza delle immagini è stato probabilmente messo fuori gioco. Le immagini però continuano a circolare, più che mai: adesso affidiamo loro larga parte delle nostre interazioni con l’esterno, giudiziosamente messo alla «giusta distanza». Siamo di volta in volta audience, spettatori attenti e angosciati, interlocutori in webcam, interfacce fatte di pixel e interferenze, riempiamo i vasti spazi lasciati vuoti dalla vita di una volta con fotografie di luoghi privati, li invadiamo con meme e gif per alleviare la solitudine e allentare la tensione. Alla rarefazione della vita non corrisponde una rarefazione della produzione iconica. Tutto questo costituirà presto un nuovo atlante della memoria del tempo che stiamo vivendo. Quali nuovi tracciati le immagini dovranno seguire, quale nuovo commercio col mondo potranno praticare?
Le supermarché des images. Stocks, Matières Premières, Travail, Valeurs, Echanges. Curata da Peter Szendy, Emmanuel Alloa, Marta Ponsa. Jeu de Paume, Paris, 11/02-07/06/2020.
Condannato da tre funzionari dell’NKDV (Commissariato del popolo per gli Affari interni dell’Unione Sovietica) con la falsa accusa di propaganda trockista controrivoluzionaria, il teologo, presbitero russo della Chiesa ortodossa, fisico, matematico, filosofo, elettrotecnico e poeta Pavel Aleksandrovič Florenskij venne ucciso l’8 dicembre 1937 con un colpo di arma da fuoco alla nuca.

Ritratto di Pavel Aleksandrovič Florenskij in abito talare / Foto segnaletiche di Florenskij scattate dall’OGPU (Direzione politica di Stato generale) dopo il suo primo arresto avvenuto il 27 febbraio 1933.
A questo singolare e geniale personaggio, Avril Pyman ha dedicato una biografia (Pavel Florenskij.La prima biografia di un grande genio cristiano del XX secolo, Lindau, Torino 2019). Lo studio delle funzioni discontinue, ma ancor prima la conoscenza del sistema periodico di Mendeleev e le osservazioni dello spettro di Rowland, portarono l’attenzione del giovane matematico sul concetto di discontinuità, venuto a integrare “un modo interamente nuovo di osservare il mondo, un modo che solo allora si stava formando”. Il desiderio di spiegare l’esistenza di fenomeni che violano il principio deterministico e di verificare il principio di discontinuità in altre discipline, lo spinsero verso la filosofia, la linguistica, l’arte e la teologia. Nel 1904, dopo essersi laureato a pieni voti, rinunciò a un dottorato di ricerca in scienze matematiche e s’iscrisse a un corso di studi presso l’Accademia teologica di Mosca.
Nel 1908 divenne docente di Storia della Filosofia e Storia delle Idee presso la stessa Accademia. Nel corso delle sue lezioni utilizzava metafore e analogie inusuali associando le forze sprigionate da un magnete alla logica del sillogismo, la struttura della tragedia greca alla liturgia della Chiesa ortodossa. Uno dei suoi studenti ricorda l’aula piena fino all’inverosimile con gente in piedi tra i banchi, lungo i muri, seduta sulle finestre, accalcata attorno alle porte.
La prospettiva rovesciata (la nuova traduzione a cura di Adriano Dell’Asta è appena stata pubblicata da Adelphi) è uno dei suoi saggi più discussi sulla rappresentazione dello spazio nelle arti figurative. Scritto nel 1919 per il comitato che si occupava della conservazione dei beni storico-artistici del monastero della Santissima Trinità di San Sergio, il saggio costituirà un punto di riferimento per i corsi di Analisi dello Spazio nelle opere d’arte figurativa e di Analisi della prospettiva che Florenskij terrà fra il 1921 e il 1924 presso la Facoltà Poligrafica del VChUTEMAS di Mosca (un istituto superiore per la progettazione industriale analogo al Bauhaus in Germania). Florenskij applicò le teorie dello spazio non euclideo all’analisi della pittura di icone, dove gli oggetti e gli edifici, in alcuni casi anche i volti e i corpi umani, sono visti da più lati simultaneamente, sostenendo che “in quelle fasi storiche della creatività artistica in cui non si osserva l’utilizzo della prospettiva, i creatori delle arti figurative non è che non sapevano, ma non volevano utilizzarla o, più precisamente, volevano utilizzare un principio figurativo diverso da quello della prospettiva” (p. 42). Egli riferisce l’origine della prospettiva lineare alla skenographia sulla base di un’interpretazione erronea di alcuni passi del De architettura di Vitruvio.
Il trattato ci è pervenuto attraverso numerose versioni a stampa di una copia manoscritta rinvenuta nel 1414 da Poggio Bracciolini. L’aver creduto che il circini centrum di Vitruvio fosse il punto di vista della prospettiva moderna, scoperta da Filippo Brunelleschi e codificata da Leon Battista Alberti, ha tratto in inganno alcuni traduttori e commentatori del De architectura. Il circini centrumè il centro di un cerchio tracciato con il compasso, nel contesto di un disegno icnografico e ortografico (non prospettico). Inoltre dobbiamo tenere conto che la skiagraphia (nell’edizione Gangemi de La prospettiva rovesciata curata da Nicoletta Misler nel 1990, la traduzione non riporta skenographia ma σκιαγραφία - skiagraphia, p. 81) è propriamente il disegno delle ombre, anche se in alcuni contesti assume il significato di pittura in prospettiva. L'omofonia dei termini skiagraphia e skenographia rivela una problematicità interpretativa, tanto che, secondo alcuni studiosi, la scaenographia di Vitruvio altro non sarebbe che la skiagraphia, la rappresentazione delle ombre proprie, portate e autoportate, non la “resa illusionistica delle forme attraverso la prospettiva” (Agostino De Rosa, In obscurum coni... acumen. Sui termini skenographia e skiagraphia nel mondo classico. Engramma, 150, Ottobre 2017). Per quanto riguarda il passo nel quale Vitruvio richiama le teorie di Democrito e Anassagora è accertato che queste si riferiscono alla geometria ottica e non alla rappresentazione pittorica dello spazio. In definitiva, nulla nel testo vitruviano autorizza a cogliere un riferimento alla prospettiva moderna, tanto più che “tra i dipinti antichi conservati nessuno rivela l’esistenza di un punto di fuga unico” (Erwin Panofsky, La prospettiva come forma simbolica, Feltrinelli, Milano 1993, p. 47).

L’Apostolo Pietro, XII-XIV secolo, Galleria Tretiakov, Mosca / L’Apostolo Paolo, 1502 circa, Galleria Tretiakov, Mosca.
Florenskij s’impiglia nell’interpretazione dei passi di Vitruvio giungendo all’errata supposizione che la prospettiva “focalizzata” fosse nota nella Grecia del V secolo a.C., ma non sbaglia quando afferma che questa prospettiva è solo “uno dei possibili schemi di raffigurazione, che corrisponde non alla percezione del mondo nel suo insieme, ma semplicemente a una delle possibili interpretazioni del mondo” (p. 20). Non sbaglia neppure quando attribuisce alla prospettiva, sia essa “monocentrica” o “policentrica”, una funzione simbolica.
Egli nota che nella pittura di icone spesso sono rappresentati dei piani che, secondo le regole della prospettiva dotata di un unico punto di vista non possono essere visti simultaneamente: “pur guardando perpendicolarmente la facciata degli edifici rappresentati, di questi edifici ci vengono mostrati insieme entrambi i muri laterali; del Vangelo si vedono, simultaneamente tre o addirittura tutte e quattro le coste” (pp. 11-12), e che in queste rappresentazioni è assente un punto di fuga verso il quale far convergere le linee. La divergenza delle linee è interpretata da Florenskij come una trasgressione delle regole della prospettiva rinascimentale, come una prospettiva rovesciata o inversa nella quale le linee divergono anziché convergere verso il fondo.
Régis Debray ha scritto delle belle pagine sullo sguardo che s’irradia dall’immagine sacra verso il cittadino greco o romano, così come verso il fedele bizantino o medievale. Secondo l’autore, l’icona bizantina rigetta la profondità perché è corpo, volume, ombra, ma una terza dimensione è tuttavia risparmiata: “la distanza che attraversano i raggi portatori di energia divina per raggiungere il fedele. Le linee di fuga vanno verso l’occhio dello spettatore [convergono nel suo occhio anziché nel punto di fuga]” (Vita e morte dell’immagine. Una storia dello sguardo in Occidente, Editrice Il Castoro, Milano 2001, pp.190-191). Attraverso la prospettiva rovesciata Dio guarda l’uomo illuminandolo con i suoi raggi visivi e luminosi e l’uomo contempla abbassando lo sguardo per riceverli. La contemplazione di Dio attraverso le icone, secondo Debray, non sarebbe dunque la produzione ma la ricezione di uno sguardo che illumina il fedele.
Florenskij non fa riferimento all’inversione del punto d’irradiazione delle rette ma al moltiplicarsi dei punti di vista, che trasgredisce le regole della prospettiva rinascimentale: fissità e unicità del punto di vista, unicità dell’orizzonte e unicità della scala di grandezze.

Donatello, Miracolo del cuore dell’avaro (particolare), 1446-1449, Basilica del Santo, Padova / Donatello, Madonna con Bambino, detta “Madonna Pazzi”, 1425-1430, Staatliche Museen, Berlino.
Delle trasgressioni a queste regole si possono tuttavia rilevare nelle stesse opere considerate autorevoli esempi di prospettiva rinascimentale. Nel Miracolo del cuore dell’avaro di Donatello il secondo pilastro è portato avanti dalla mano del personaggio che vi si appoggia e nella Madonna con Bambino (Madonna Pazzi), scolpita dallo stesso Donatello, la prospettiva si rovescia portando fuori dalla stanza le figure che poco prima si trovavano dentro. Nell’opera del grande scultore la prospettiva rinascimentale convive con altre rappresentazioni dello spazio, prospettiva rovesciata o inversa compresa. Florenskij va a caccia di queste incoerenze nella pittura del Cinquecento rilevando, per esempio, che nella Scuola di Atene Raffaello vìola sia il principio di unicità dell’orizzonte, sia quello della scala di grandezze (p. 60). In effetti dal Cinquecento si assiste a un abbandono delle regole rinascimentali per soluzioni prospettiche complesse ed eccentriche, che nel Seicento raggiungono effetti decisamente vertiginosi.
Già la pittura antica utilizzava prospettive diverse per dar luogo a una rappresentazione “policentrica” dello spazio. È infatti ampiamente documentato l’uso della prospettiva dissociata, nella quale le linee sono orientate verso indipendenti centri di focalizzazione; della prospettiva inversa, nella quale le linee divergono verso il fondo anziché convergere; della prospettiva a lisca di pesce, dove le linee convergono verso punti situati a diverse altezze; della prospettiva parallela contrassegnata dall’obliquità delle linee parallele e anche di quella centrale, già dotata in età ellenistico-romana di una convergenza delle linee, ma non intesa come sistema unitario di rappresentazione dello spazio.
La “policentricità” di una rappresentazione dello spazio nella quale l’occhio sembra guardare le varie parti dell’oggetto cambiando posizione di volta in volta è posta da Florenskij in relazione alla varietà di vedute che compongono l’immagine visiva. A collegare tutte queste parti separate nel tempo in cui l’occhio esplora l’oggetto sarebbe un particolare atto della psiche. Questo avrebbe luogo anche quando l’occhio, guidato dalle linee del panneggio (intese da Florenskij come linee di forza di un campo percettivo gestaltico, isometrico a quello elettromagnetico), riproduce nello spirito “l’immagine già prolungata nel tempo” composta da quel “mosaico immobile” dei suoi singoli momenti più significativi che è l’icona (p.113). In queste rappresentazioni dello spazio a dominare è un’esperienza del tempo.
“Un singolo momento strappato non ci mostra l'immagine intera di una cosa, come non ce la mostrano molti di questi momenti quando si prende ciascuno di essi singolarmente e non si coglie la forma del fenomeno secondo la quarta coordinata [il tempo]”, scrive in Lo spazio e il tempo nell’arte (Adelphi, Milano 1995, p. 146), un saggio composto fra il 1924 e il 1925, mentre la teoria di uno spazio-tempo quadridimensionale, che può essere deformato e incurvato in risposta alla presenza della massa, infiamma il dibattito scientifico. Ad affascinarlo è l’aspetto quadridimensionale della realtà costituita dalla successione temporale di tutti i suoi momenti in una sintesi che avviene quando la coscienza si “solleva al di sopra del tempo”. Florenskij trova nelle nuove teorie scientifiche un riscontro di quella particolare esperienza del tempo, che già da piccolo lo affascinava. “La quarta coordinata - il tempo - era per me […] viva […] Ero abituato a vedere le radici delle cose. Tale abitudine visiva fecondò poi l’intero mio pensiero e ne determinò il tratto fondamentale: la tendenza a muoversi in verticale e lo scarso interesse per l’orizzontale” (Ai miei figli. Memorie di giorni passati, Mondadori, Milano 2009, p. 140). In un altro testo precisa che questa sintesi “non è nel tempo o, per lo meno, non è nel tempo come l'intendiamo noi, ma in quella dimensione temporale che, paragonata con la nostra, si chiama eternità, sebbene questa non sia l'eternità in senso assoluto” (Il significato dell’idealismo, SE, Milano 2012, p. 112). Qui si avverte chiaramente come la sua formazione scientifica si sia saldata agli studi filosofici e teologici nello sforzo di associare l’utopia positiva e razionale della rivoluzione socialista a una rifondazione spirituale dell’uomo, uno sforzo che si rivela fallimentare: il marxismo-leninismo s’irrigidisce in un dogmatismo ideologico e il misticismo rivoluzionario viene confinato nei campi di lavoro. L’8 agosto 1933 Florenskij viene recluso nel gulag di Svobodnyj in Siberia e, dopo varie peripezie, condannato a morte l’8 dicembre 1937.

Immagini del gulag delle isole Solovki dove Florenskij fu trasferito l’1 settembre 1934, dopo 18 mesi di reclusione nel campo di Svobodnyj. Alle isole Solovki rimase fino al giorno della sentenza di morte.
A seguito dell’ordinanza 00447 emessa da Stalin il 30 luglio 1937 inizia una vera e propria carneficina, nel corso della quale muoiono centinaia di migliaia di persone ingiustamente accusate di propaganda trockista controrivoluzionaria. Lo sterminio dura quindici mesi con una media di 1.600 esecuzioni al giorno. A capo di questa macelleria è posto Nikolaj Ivanovič Ežov detto “il nano sanguinario”, direttore dello stesso Commissariato del popolo per gli Affari interni (NKDV) che condannerà a morte Florenskij per le sue idee, certamente non trockiste, né controrivoluzionarie. Il pensare in verticale anziché in orizzontale e l’idea di una rivoluzione spirituale oltre che sociale dell’uomo costeranno la vita al nostro teologo, fisico, matematico, filosofo, poeta ed elettrotecnico (durante la sua prigionia nei campi di lavoro gli vengono riconosciuti ben 12 brevetti e 47 loro applicazioni). Innestando nel linguaggio dei simboli matematici una visione filosofica e artistica del mondo, Florenskij dà forma a un particolare modo di pensare, discontinuo quanto la discontinuità alla quale dedicò la sua tesi di laurea in scienze matematiche.
Florenskij unisce il ragionamento per conseguenza al salto analogico, spesso associato a balzi da una disciplina all’altra. Nelle premesse teoriche al saggio sulla prospettiva, per esempio, collega la topologia degli insiemi di punti di Georg Cantor a riflessioni filosofiche sulla “realtà” e al problema posto dalla sua rappresentazione pittorica (p. 81).
Il testo che Adelphi ha ristampato è un’interessante testimonianza del suo modo di pensare. Naturalmente è anche un importante studio sulla prospettiva, che ebbe un peso rilevante nel dibattito in corso al VChUTEMAS fra i sostenitori dell’arte produttivista (costruttivista) e i sostenitori dell’arte pura (Nicoletta Misler, Il rovesciamento della prospettiva – GAChN, INChUK e VChUTEMAS; il dibattito su costruzione e composizione, in La prospettiva rovesciata e altri scritti). Analizzando la pittura murale della Casa dei Vettii rinvenuta a Pompei, Florenskij nota che la trasgressione delle regole imposte dalla (supposta) prospettiva focalizzata usata dalle maestranze introduce in un’arte decorativa e illusionistica i principi dell’arte pura. Il pittore “da scenografo [nella traduzione Gangemi “decoratore”], si trasforma almeno parzialmente in un vero e proprio artista […] non perché in parte, o perfino in larga parte, si attiene alle leggi della prospettiva, ma solo perché e nella misura in cui se ne discosta” (p. 32).

Balcone con soffitto e lacunari, Triclinium della Casa dei Vettii, Pompei / Evidenziazione grafica di alcuni particolari resi in prospettiva parallela.
Le considerazioni di Florenskij sul rapporto fra composizione e costruzione, fra arte pura e produttivista stimolano una riflessione – qui posta a margine – sul rapporto che la pittura intrattiene con la decorazione. Negli affreschi della Casa dei Vettii, come in altri affreschi ellenistici e romani, si può notare che la prospettiva parallela usata dalle maestranze è dominata dalla geometria del parallelogramma, inteso sia nella versione con i lati e gli angoli opposti congruenti, sia nella versione con i lati, gli angoli e le diagonali congruenti (rombo o losanga).

Lewis Foreman Day, illustrazione tratta da The Anatomy of Pattern, 1890, tavola 25 / Maurits Cornelis Escher, Cielo e acqua I(particolare), 1938.
Il disegnatore vittoriano Lewis Foreman Day consiglia di fondare sullo schema a losanga la ripetizione del motivo decorativo (Ernst Hans Josef Gombrich, Il senso dell’ordine, Leonardo Arte, Milano 1894, p. 108). Lo schema impedisce al motivo ornamentale di scomporsi nei punti di giunzione, favorendo al contempo soluzioni compositive basate sulla reversibilità della forma, come dimostrano le sconcertanti litografie di Maurits Cornelis Escher. Le prospettive reversibili o “inversioni” di Escher devono molto ai pattern nella decorazione tessile, nella quale si sviluppa l’espediente dell’inversione, o controscambio, vale a dire la corrispondenza fra forme positive e negative, che ha attirato l’attenzione dell’artista olandese (Gombrich, p. 109). La suddivisione periodica della superficie usata da Escher per ordinare le sue composizioni, spesso si basa sullo schema a losanga.

Duccio di Buoninsegna, Maestà, verso, elemento principale: Cristo davanti a Erode, 1308-1311, Museo dell’Opera del Duomo, Siena / Schemi geometrici tratti da decorazioni musive.
Questo schema mostra delle analogie di forma e anche di funzione con la prospettiva parallela usata nella pittura antica e in quella tardo medievale, quando questa attiva il meccanismo dell’inversione. Nelle opere di Duccio di Buoninsegna possiamo infatti vedere sotto e sopra, dentro e fuori, in alcuni casi anche davanti e dietro. Nel Cristo davanti a Erode vediamo la parte sinistra del corpo di fabbrica dall’alto e la sua parte destra dal basso. La porta ad arco raccorda le due parti con un suggestivo gioco di reversibilità fra esterno e interno.
Dentro o fuori? Sopra o sotto?

Duccio di Buoninsegna, Maestà, recto, porzione centrale della predella: Natività, 1308-1311, National Gallery of Art, Washington.
L’angelo che si sporge per guardare la Natività con le braccia conserte e il gomito destro dietro la trave della capanna nella predella della Maestà conservata alla National Gallery of Art di Washington, sta vedendo il dentro o il fuori della capanna? E noi la vediamo dall’alto o dal basso? Dobbiamo questa singolare visione alle pareti e alle falde del soffitto della capanna.
Non capiscono, gli angeli proprio non capiscono come, nel buio della capanna, le corna del bue possano risplendere al pari di una falce di luna, doppia peraltro. Non sono forse loro gli abitanti del cielo e il bue della terra? Soprattutto la capanna li confonde. Talvolta hanno l’impressione di vederla da sotto, talvolta da sopra. Il più sconcertato è quello con il gomito dietro la trave: quando la capanna gira verso l’alto può condividere con tutti gli altri la visione del Santo Bambino, ma quando la capanna gira verso il basso, per qualche diabolica magia, ne resta completamente escluso. Ah! Diaboliche losanghe.
La loro origine infatti è pagana.

Domus di Dioniso, II sec. d.C., Museo di Santa Giulia, Brescia.
Nella decorazione musiva dei pavimenti ellenistici e romani si può notare che il parallelogramma articola forme e volumi nello spazio con suggestivi effetti d’inversione. Nel mosaico della Domus di Dioniso conservato presso il Museo di Santa Giulia a Brescia, la suddivisione geometrica della superficie dirige lo sguardo ora verso il riquadro centrale, ora verso gli ottagonali laterali, ora lo attira su di sé sconcertando l’osservatore: la faccia superiore di un cubo visto dall’alto è anche quella inferiore di un cubo visto dal basso e le facce laterali di entrambi sono anche quelle di altri due cubi uniti lungo uno spigolo. Il parallelogramma orienta i volumi nello spazio e al contempo li mette sottosopra, come nell’edificio dipinto da Duccio in Cristo davanti ad Erode.
Duccio tramanda un sistema di rappresentazione dello spazio nel quale interagiscono logiche visive diverse. Nell’Annuncio della morte alla Vergine (recato da un angelo che sposta in avanti e indietro un pilastro con un gioco di piedi e di braccia) la prospettiva a lisca di pesce si combina a quella parallela facendo levitare la Vergine e lo scranno sul quale è assisa, mentre in Cristo davanti ad Erode la prospettiva parallela opera come la geometria della decorazione musiva generando effetti di reversibilità, grazie ai quali possiamo vedere la scena dal basso e dall’alto.
L’opporsi di un punto di vista rispetto all’altro è proprio anche dell’antilogia usata dagli scettici greci. Erwin Panofsky sostiene che “il valore della prospettiva romano-ellenistica [si potrebbe paragonare] a quello dello scetticismo” (La prospettiva come forma simbolica, p. 71). La pittura ellenistica, che attraverso Bisanzio migra in quella di Duccio, esprime questo valore? Sicuramente lo esprimono le incisioni di Escher. Sono paradossali quanto le antilogie, che l’età moderna ha mutato in antinomie. Quella del mentitore (io sto mentendo) è famosa. Se si suppone che l’enunciato sia falso, allora è vero, viceversa, se si suppone che sia vero, allora è falso. Vero o falso? Sopra o sotto? Dentro o fuori?
L’”abitudine visiva” che fecondò il pensiero di Florenskij potrebbe avere a che fare con uno sguardo nel quale le forme del discorso e i concetti s’intrecciano con i meccanismi della percezione e con le tecniche di produzione visiva?
Sfoglio il volumetto Adelphi per cercare delle risposte alla domanda. Con la coda dell’occhio vedo a pagina 110 una semicirconferenza formata da addensamenti del nero tipografico, dovuti alla configurazione e alla disposizione dei caratteri. Dalla lettura delle lettere in sequenza passo quindi alla visione di una configurazione percettiva. Questo transito dalla lettura alla visione, avvenuto tramite uno spostamento dalla percezione foveale a quella periferica, mi porta nel vivo delle riflessioni di Florenskij sul processo psichico “estremamente complesso” che forma la visione artistica, di cui scrive appunto a pagina 110. Dalla visione torno quindi alla lettura del testo, pensando che lungo la sequenza di caratteri tipografici dei suoi testi si distende una visione artistica oltre che filosofica e scientifica, come peraltro suggerisce la sua analisi delle forme grafiche e tipografiche che compongono la xilografia realizzata da Vladimir Andreevič Favorskij per la copertina del libro Gli immaginari della geometria (Spiegazione della copertina, in La prospettiva rovesciata e altri scritti).
Questo “grande genio cristiano del XX secolo”, come lo definisce Pyman nella biografia, ha avuto folgoranti intuizioni, derivate dall’”abitudine visiva” che determinò il tratto fondamentale del suo modo di pensare in verticale, divenuto sospetto nella società sovietica postrivoluzionaria, nella quale naufragarono le speranze di una rifondazione spirituale oltre che sociale dell’uomo.
La lettura di Florenskij ha l’indiscutibile merito di metterci a parte del suo singolare modo di pensare collegando la prospettiva aerea prodotta dalla sottile cortina azzurra dell’incenso alla musica di Skrjabin (Il rito ortodosso come sintesi delle arti, in La prospettiva rovesciata e altri scritti, p. 66), la forma grafica delle lettere alfabetiche allo spazio sonoro dell’intonazione nel contesto di una riflessione matematica che apre ad alcune considerazioni filosofiche (Spiegazione della copertina, p. 138). Ha cioè il merito di portare l’attenzione sulle forme diverse che il pensiero può assumere, valorizzando anche quello infantile: “il pensiero infantile non è un pensiero ridotto, ma un tipo particolare di pensiero, che oltre tutto può raggiungere qualsiasi grado di perfezione sino alla genialità” (p. 44). Florenskij si lascia trasportare dal fumo dell’incenso e dal tremolio delle fiammelle che illuminano le icone nelle astratte regioni del pensiero matematico e in quelle della ricerca filosofica, per raggiungere una sintesi che avviene quando la coscienza si “solleva al di sopra del tempo”.
La foto l’ha scattata Ugo Mulas nel 1964. Ritrae Christo e Jeanne-Claude in una stanza dell’hotel Chelsea a New York. Lui è in primo piano, occhialuto, seduto sul bordo del letto, somiglia a uno dei Beatles, la mano destra sotto il mento nella caratteristica posa meditativa e melanconica dell’artista: orologio, cravatta e un paio di lucide scarpe a punta. Lei è invece arretrata, sdraiata sul letto: le gambe in primo piano inguainate in calze pop a motivo floreale, il viso bellissimo da adolescente morbosa. Sono arrivati da poco a New York e sembrano già parte dell’arredo della metropoli, perfettamente integrati nell’atmosfera dell’epoca, contro ogni infausta previsione di lei che durante la corsa nel taxi s’era accorta di non riuscire a capire una sola parola del guidatore nonostante i soggiorni a Londra e le lezioni private, come si usa nella buona borghesia parigina da cui Jeanne-Claude proviene. Hanno ventinove anni, sono nati nel medesimo giorno, mese e anno, hanno un figlio di quattro anni, nato quasi in clandestinità dopo il matrimonio e la repentina separazione dal marito di lei; sono amanti da almeno sei anni, da quando il profugo bulgaro, fuggito al di qua della cortina di ferro è arrivato a Parigi e ha iniziato la sua attività di ritrattista, e subito dopo l’attività d’artista d’avanguardia, dipingendo barattoli, avvolgendoli nella tele, coprendoli di vernice, e chiudendo con un muro di bidoni di petrolio una stretta via della capitale francese.
Quarantun anni dopo ecco un’altra foto, opera del fotografo ufficiale della coppia, Wolfgang Volz: a destra, Christo, occhiali da intellettuale, capelli bianchi vestito con una giacca a vento verde militare sorride e guarda verso l’obiettivo; a sinistra lei, Jeanne-Claude, chioma rossa, occhi verdi, labbra rosse, sorride e indossa la medesima giacca; e dietro di entrambi la macchia arancione di uno degli stendardi stesi nel 2005 a Central Park, progetto che si è realizzato dopo ventisei anni d’attesa nella città che è diventata da trent’anni loro residenza ufficiale. Sono una coppia che ora firma, priva del cognome di entrambi (Javacheff, lui; Denat de Guillebon, lei), le loro opere come se si trattasse di una ditta commerciale: XTO e J-C. Sino all’inizio degli anni Novanta Christo era l’artista e lei, la bellissima e pugnace J-C, la moglie, oltre che la manager e l’organizzatrice delle mostre e delle gigantesche installazioni: da musa dei primi anni a reggitrice del lavoro, a partire dall’installazione di Spoleto del 1968 realizzata su indicazioni di XTO, in sua assenza, dato che nel frattempo lui era andato avanti, a Kassel, per cercare di portare a termine l’opera che ha trasformato il giovane artista bulgaro, semi incluso nel movimento del Nouveau Réalisme di Pierre Restany, da artista quasi sconosciuto a star dell’arte internazionale, uno dei pochi artisti universalmente noti del secondo Novecento, se non proprio per nome, almeno in modo metonimico per l’opera – impacchettare edifici e luoghi – dall’uomo comune, dall’uomo della strada. Dai primi impacchettamenti e dalle pitture degli inizi sino all’opera in fieri, Over the River, sul fiume Arkansas in Colorado, ancora da realizzate in uno degli anni a venire.
Christo ha prodotto, oltre alle opere pubblicate su tutti i giornali del mondo nel giorno in cui è stata annunciata la sua morte a quasi 85 anni, i disegni dei progetti, le grandi tavole illustrate, a metà tra il disegno tecnico e il collage avanguardista, opere grafiche e insieme pittoriche, strumenti di lavoro, ma anche affascinanti illustrazioni dei luoghi dove inserire teloni penzolanti, plastiche galleggianti, cordami e cavi sospesi, un tipo di scrittura e di pittura che mostra la sua appartenenza di esecutore di tavole alla tradizione classicista, e persino al realismo socialista, da cui proviene, avendo frequentato con ottimi risultati l’Accademia di Belle Arti a Sofia prima della sua fuga dentro un carro merci diretto all’Ovest nel ’56. Burt Cherstow ha raccontato con dovizia di dettagli gli inizi dell’artista e la vita parallela della futura moglie in un libro biografico, XTO+J-C (Skira), pubblicato molti anni fa con lo scopo non troppo recondito di dimostrare il nesso inscindibile della coppia, sancito dalla doppia firma delle ultime imponenti opere, comprese quelle allestite dopo la morte di lei nel 2009, come la spettacolare The Floating Piers del 2016 sul Lago d’Iseo, dove il pubblico non doveva solo guardare ciò che era nascosto sotto i teli, ma calpestare il telo-piattaforma partecipando all’evento come protagonista.

Christo and Jeanne-Claude at the Chelsea Hotel, 1964, Ugo Mulas.
In una delle prefazioni al catalogo di una mostra dei disegni e delle tavole realizzata a Lugano alcuni anni fa, uno dei presentatori spiegava come l’incontro tra XTO e J-C fosse un perfetto esempio di matrimonio tra comunismo e capitalismo, unione di un’arte che fa della critica del consumo e del packaging una delle sue chiavi di lettura (l’arte come confezione in un mondo dominato da confezioni e scatole) e insieme del marketing, uno degli strumenti per realizzare opere d’arte, farle vivere in modo effimero, ma sostanzioso, creando una catena virtuosa di autofinanziamento. Christo non è, come è stato a lungo sostenuto, un artista dell’utopia, bensì il primo artista che è ricorso al prestito bancario e al fido come strumento di lavoro. La notizia della realizzazione a Miami delle Surrounded Islands, il polipropilene fucsia che circonda le undici isolette, spettacolare ed emozionante installazione galleggiante, fu data dal New York Times nel 1983, in ragione non tanto dell’evento estetico ma per il prestito concesso dalla Citibank di 3 milioni di dollari, evento che poneva allora la ditta XTO e J-C al terzo posto nel mondo dopo la Exxon e la Philip Morris come istituzioni private promotrici di cultura.
È questa fusione di economia e arte a colpire, oltre alla indubbia bellezza dei progetti: l’estetica e il denaro, la fruizione democratica e la macchina organizzativa che le produce. Christo appare simile più a un artista rinascimentale, che realizza grandi opere pubbliche per il beneficio estetico del popolo, che non un artista dell’avanguardia che sfida l’arte con la trasgressione, per quanto più di un critico e studioso lo abbia incluso in una galleria di “vite d’avanguardia”. Al posto dei principi e dei mecenati ci sono ora le banche e i grandi collezionisti, l’avamposto anonimo dell’economia capitalista nell’epoca della “moltitudine”. In fondo, Christo, allevato nel comunismo reale – la sua prima pratica di land art è stata l’allestimento dei covoni e degli attrezzi contadini lungo la strada ferrata percorsa dall’Orient Express – è un artista sociale, sociologo e politico ad un tempo, che realizza il sogno di un’arte di massa senza con questo rinunciare ai metodi elitari e antidemocratici dell’arte stessa. Avanguardista a metà, con l’inclinazione al classico, visto che la ditta Christo e Jeanne-Claude realizza le proprie opere – da 5,600 Cubicmeter Package di Documenta 4 di Kassel nel 1968, che trasforma il povero apolide in un nome noto del jet set artistico, a The Gates in Central Park, evento mediatico del 2005 – mediante l’autofinanziamento vendendo progetti, tavole, disegni, serigrafie, pitture a gallerie e collezionisti di tutto il mondo, che amano le seducenti e ammiccanti tavole poveriste, eleganti collage d’avanguardia resi quasi inoffensivi e trasformati in opere per l’esposizione in salotto.
Tutto questo non è affatto negativo, anzi. Come aveva intuito Harald Szeemann, il geniale curatore, loro sostenitore nel primo impacchettamento di un grande edificio, la Kunsthalle di Berna nel 1968, le opere della coppia attivano discorsi intorno all’arte contemporanea in persone assolutamente estranee alla medesima; fanno discutere, litigare, assentire e dissentire, e non lasciano indifferenti. Per convincere l’allora capo dei vigili del fuoco di Berna a dare una mano per impacchettare il museo usando i pezzi del primo lavoro fallito a Kassel (trasportati in treno da Christo), Szeemann gli chiede se conosce il museo. Alla sua risposta affermativa, gli propone di descriverlo. Mentre sta ancora pensandoci, interviene: “Vede è questa la ragione per cui l’impacchettiamo. Può star certo che, quando si sarà tolto l’imballaggio, la Kunsthalle si farà un regalo: tutti guarderanno l’edificio con maggiore attenzione”. Così lo convince. Al Museo di Lugano in una piccola ma emblematica mostra di anni fa c’era un ottimo video in cui veniva ricostruita l’attività artistica della Ditta. Le parti più emozionanti, oltre quelle dedicate alla realizzazione delle opere più famose, cui partecipano centinaia di persone, sono proprio le discussioni con la gente, le assemblee, gli incontri, le dichiarazioni di oppositori e sostenitori.
L’arte scende in strada, realizzando un sogno delle avanguardie. Non è un’arte rivoluzionaria, sovvertitrice, immaginata da Dada e Surrealismo; è solo un’arte democratica. È l’unica arte, salvo qualche solitaria utopia, oggi possibile? Nel mondo dominato da marketing e pubblicità, in cui i Business plan e gli Startup appaiono essenziali anche per la definizione dei progetti artistici, XTO e J-C sono stati senza dubbio dei precursori. Nel 1970 nasce per iniziativa di J-C la loro prima Corporation, la Valley Curtain Corporation, al fine di realizzare il progetto nel Colorado, il grande telo arancione che chiude la valle, uno dei loro più belli, opera che riprende le intuizioni degli Store Front, le vetrine oscurate dei negozi (1965), non a caso sue prime opere americane: dal negozio all’ipermercato e dall’ipermercato al parco a tema. Un’arte ancora da realizzare, ma già realizzata come ogni grande idea del marketing. Warhol ha aperto la strada, ma lui era solo, almeno in partenza, un vetrinista, e alla vetrina è rimasto legato anche dopo, quando i suoi disegni e i suoi quadri sono diventati enormi per essere esposti nei musei di tutto il mondo. Christo ha pensato più in grande, ha trasformato i musei in opere. Le ha circoscritte e al tempo stesso rivelate. L’arte diventa sempre più grande per tenere testa a un mondo sempre più globale, immenso e smisurato? Sarà così anche ora dopo il Covid-19? Intanto la poesia e l’economia alla fine si sono sposate. XTO + J-C = ?
La scultura, da sempre, sollecita il tatto: ci invita a sfiorare, toccare, se non addirittura accarezzare statue o bassorilievi. Alcuni autori antichi, e tra questi Plinio il Vecchio, raccontano di giovani uomini che si innamorarono dell’Afrodite scolpita da Prassitele e arrivarono a congiungersi ad essa, rivestendola dei loro “abbracci amorosi”. È quasi ciò che fece Ugo Foscolo con la Venere italica di Antonio Canova: “l’ho visitata, e rivisitata, e amoreggiata, e baciata, e – ma che nessuno il risappia – ho anche una volta accarezzata questa Venere nuova”. Entusiasta di Canova, lo stesso Foscolo scrisse poi un carme Alle Grazie ispirato dalle Tre Grazie che lo scultore aveva iniziato per l’imperatrice Giuseppina Beauharnais.
Nella grande mostra milanese di cui ha parlato su queste pagine Aurelio Andrighetto (Canova, Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna, a cura di Stefano Grandesso e Fernando Mazzocca, Gallerie d’Italia, Piazza Scala, che riapre dal 2 giugno dopo i mesi di sosta forzata imposta dal covid-19) c’è una versione della Venere Italica, e sono proprio le Grazie di Canova ad accoglierci nella prima grande sala; il gruppo oggi a San Pietroburgo (ne esiste un altro a Londra) è affiancato da quello di Thorvaldsen, ed entrambi sono circondati da figure di danzatrici.
Ecco dunque il marmo; il marmo bianco che è il materiale eletto, la sostanza del lavoro di entrambi gli scultori: prima ancora di cogliere forme e soggetti delle opere esposte, si è presi da questo duro candore della materia e dall'ostinata fedeltà che Canova e Thorvaldsen le dimostrarono in statue, bassorilievi, ritratti. Scegliere il marmo bianco significava infatti saldare la propria arte a quella degli antichi: oggi sappiamo bene che le statue marmoree scoperte a Roma, soprattutto dal Rinascimento in poi, non erano altro che copie o rielaborazioni di opere bronzee della Grecia classica ed ellenistica, e sappiamo per di più che tutta la scultura antica era rivestita di colore; ma si arriverà a questa certezza lentamente e solo in pieno Ottocento, tanto che il bianco del marmo, per secoli, fu una sola cosa con l’idea di arte antica.

Così, immediatamente, in questa grande sala iniziale, viene esposto il tema portante della mostra, il paragone e il parallelo tra la carriera dell'uno e dell'altro e si presenta il centro indiscusso della loro ricerca artistica: l'Antico. Si ha un bel da fare a rivendicare la modernità dei due scultori; per quanto possa sembrare paradossale, la loro modernità – come quella dei loro contemporanei – consisteva nel tentativo di abitare il più possibile la classicità. Erano anni in cui l’antichità, senza fare troppe distinzioni tra Grecia e Roma, impregnava di sé qualunque area della cultura europea: ci si vestiva “à la grecque”, e uomini e donne si acconciavano “à la Titus” o “à la Brutus”, secondo i modelli forniti da statue e rilievi classici; un vero e proprio best-seller era il Voyage du jeune Anacharsis en Grèce di Jean-Jacques Barthélemy (lo cita anche Flaubert nelle prime pagine della Madame Bovary): pubblicato in Francia alla vigilia della Rivoluzione, e presto tradotto in tutta Europa, raccontava un viaggio immaginario nella Grecia del IV secolo avanti Cristo.
E di che cosa si parlava nei salotti italiani (in particolare romani) del primo Ottocento? Ce lo racconta lo Stendhal delle Passeggiate romane (1829): si conversava delle “usanze dell’antichità”, delle loro epigrafi su pietra, e persino delle “diciotto maniere in cui gli scultori antichi acconciavano i capelli di Minerva”; non so quale archeologo avesse contato con esattezza le “diciotto maniere”, sta di fatto che questi erano gli argomenti all’ordine del giorno. E che dire del proposito dello stesso Stendhal di leggersi qualche passo delle Vite dei Cesari di Svetonio “nella poltrona di legno che un Inglese ha fatto collocare proprio in cima alle rovine del Colosseo”? Alcuni esempi, tra i mille, dell’infatuazione per il mondo antico che caratterizza le classi colte europee tra Settecento e Ottocento.

Percorrete tutte le sale della mostra milanese e non troverete un’opera che non si richiami all’arte, al mito, ai protagonisti della storia del mondo classico. Nel caso delle Tre Grazie questi aspetti sono di fatto inseparabili: il soggetto è tratto dalla mitologia (le Charites greche, le Gratiae romane), le divinità che rappresentavano l’armonia, il garbo, l’apertura verso gli altri; per quanto sapientemente variato, lo schema è quello derivato da un prototipo di età ellenistica (e già frequentato da Botticelli, Raffaello, Correggio, e tanti altri); la tecnica è quella della rifinitura accuratissima della pietra: la si levigava, appunto, sul modello delle copie di età romana visibili nelle collezioni aristocratiche italiane ed europee del tempo. E poi i corpi sapientemente proporzionati, con piccoli seni, ventri delicati, piedini flessuosi, drappi che cadono a coprire le parti intime; ma non è più quella grazia affettata di certo Rococò: dietro a queste posture c’è la nuova idea di grazia che Johann Joachim Winckelmann aveva elaborato sin dal 1759, quando al tema aveva dedicato un intero saggio. “La grazia – scriveva – è il piacevole secondo ragione”; quindi, “si sviluppa mediante l’educazione e il ragionamento, e può diventare natura”; questa idea di grazia, dal sapore così illuminista, si ritrovava – secondo Winckelmann – in tutte le opera antiche, persino in quelle mediocri. Era solo uno dei capitoli del grandioso tentativo di Winckelmann di rimodellare il “buon gusto” europeo secondo la lezione dell’Antico (poco importa poi che questa visione dell’antichità fosse a sua volta frutto di una costruzione a posteriori).

Eppure, i testimoni ci descrivono un Canova poco interessato alla dimensione teorica (e con un sorprendente understatement riguardo alla propria cultura): “se scrivo male in latino e anche in italiano, ricordatevi che fo statue”. In un salotto romano, Stendhal (pseudonimo ispirato al nome della cittadina in cui era nato Winckelmann!) aveva intavolato discussioni sul rapporto tra gestualità teatrale e scultura, ma Canova “non ascoltava”, perché “non s’interessava molto alle discussioni filosofiche sulle arti”. Questo non significa affatto che non avesse tratto una lezione decisiva da Winckelmann, specie là dove spingeva gli artisti ad abolire le pose enfatiche del Barocco e, in generale, a evitare qualunque sussulto emotivo; la grazia, sosteneva, “agisce nella semplicità e nella quiete dell’anima ed è offuscata dal troppo fuoco e dalle violente passioni”.
Insomma, Canova (come poi lo stesso Thorvaldsen) aveva scelto la strada maestra del classicismo, come aveva consigliato Winckelmann nei Pensieri sull’imitazione dell’arte greca nella pittura e nella scultura (1755). In una lettera del 1806 scrisse che “conviene studiare dì e notte” i modelli greci, “investirsi del loro stile, mandarselo in mente, farsene uno proprio coll’aver sempre sott’occhio la bella natura con leggervi le stesse massime”. Canova, dunque, aveva capito che imitare non significa affatto copiare, replicare, ricalcare.
Come si vede magnificamente nella mostra milanese, il risultato non è un’Arcadia leziosa e snervata, ma un Olimpo di Veneri e Apolli, Ganimedi, Amore e Psiche, Ebe; alcune danzatrici (ben lontane dalle contorsioni delle baccanti) si muovono composte; anche i pastori hanno un contegno misurato e quasi serioso. In questa sorta di inseguimento dei Greci Canova (come Thorvaldsen) non era solo, ma affiancato da una serie di lavoranti e allievi, tutti obbligati a una cura minuziosissima della forma, in un itinerario che dal primo abbozzo in argilla conduceva allo stadio intermedio in gesso, fino all’esecuzione della statua in marmo, la sua accuratissima levigatura e, talora, lucidatura.
Perché è la liscia pelle del marmo che domina ovunque, nelle statue come nei ritratti, nei corpi nudi come nei volti. Qui il candore non è solo quello della materia, in una visione del mondo senza ruvidezze, asperità, senza impurità: il polito è anche pulito.

La mostra delle Gallerie d’Italia offre un’altra opportunità, oltre a quella di poter assistere al dialogo tra i due grandi protagonisti del Neoclassicismo europeo: scoprire quanto sia falso il luogo comune dell’artista che non viene mai capito in vita, come se la sua opera fosse sempre troppo in anticipo sui tempi. Un’impressionante sequenza di sculture, dipinti, incisioni, bronzetti, cammei dimostra che lo scultore italiano e il suo collega danese non solo sono stati ben compresi, ma sono apparsi geni inarrivabili ai loro contemporanei; il loro volto, in pittura e scultura, domina letteralmente alcune sale: omaggi di allievi e di altri artisti, ma anche autoritratti. Spicca la statua colossale di Canova seduto, dalla corporatura atletica e in nudità eroica, mentre abbraccia un’erma di Giove: l’ha eseguita un allievo, Giovanni Ceccarini, che incide il proprio nome nella parte posteriore, precisando che il lavoro è stato fatto Canova dirigente, cioè sotto la direzione del maestro.
Celebrato come nuovo Fidia o nuovo Prassitele (ancora gli antichi!), gli vengono dedicati saggi come quello voluminoso di Isabella Teotochi Albrizzi; Pietro Giordani progetta un suo Panegirico e Leopoldo Cicognara fa arrivare la sua Storia della scultura “fino al secolo di Canova”. La gloria di Canova assume una diffusione quasi popolare; come ricorda Fernando Mazzocca nel bel catalogo Skira, Chateaubriand, soggiornando a Venezia nel 1833 (una decina d’anni dopo la morte di Canova), annota che c’era “un busto di Canova in ogni albergo e perfino nelle capanne del regno Lombardo Veneto”.
E anche dopo la morte, il corpo di Canova viene trattato come quello di un santo, e se ne traggono reliquie. E proprio a questa vicenda si rifà l’impietoso giudizio di Roberto Longhi sullo scultore (1945); alla “prodigiosa retorica” di Tiepolo, lo storico dell’arte contrapponeva gli “svarioni cimiteriali di Antonio Canova, lo scultore nato morto, il cui cuore è ai Frari, la cui mano è all’Accademia e il resto non so dove”. Un’ostilità, tutto sommato, ben comprensibile all’interno delle poetiche del pieno Novecento, come del resto l’antipatia di Carlo Emilio Gadda per Foscolo, diversi anni dopo. E per questo sarebbe interessante capire come mai la cultura contemporanea, che continua a mantenere una certa freddezza nei confronti del Neoclassicismo letterario di un Monti o di un Foscolo, sembri ora molto più coinvolta dal linguaggio di scultori come Canova o Thorvaldsen.
Il primo di giugno è morto a Cesena Tinin Mantegazza, il cui nome è legato in questi giorni da cronaca e media, soprattutto alla storica trasmissione Rai L’albero azzurro, dedicata ai bambini e ai ragazzi, andata in onda per la prima volta il 21 maggio 1990, e che nel 2020 ha festeggiato i trent’anni.
Mantegazza, insieme alla moglie Velia, perché i loro nomi formano un inscindibile binomio che trattandosi di cultura per l’infanzia vien bene chiamare fantastico, creò uno dei pupazzi simbolo che ha animato la trasmissione: l’uccello Dodò. Ma fu ideatore e progettista, nel corso della sua lunga vita creativa, di oltre duemila creature di scena per la tv e per il teatro, come ricorda una mostra inaugurata ad aprile dello scorso anno a Bagnacavallo, al Museo delle Cappuccine: Tinin Mantegazza. Le sette vite di un creativo irriverente.
E infatti una delle caratteristiche della sua figura è l’inesauribile vena creatrice con cui frequentò campi disparati: quello del teatro e dello spettacolo – oltre a lavorare alla Rai, fondò uno dei locali mito del cabaret milanese il Cab64, dove debuttarono Jannacci e Gaber, e passarono musicisti e attori come Paolo Poli, Cochi e Renato, Bruno Lauzi, e sempre a Milano fondò nel 1978 il Teatro del Buratto e diresse il Teatro Verdi –; il campo delle arti visive – fu scenografo, illustratore, pittore, fondò la galleria d’arte La Muffola, dove esposero artisti come Luzzati, Pericoli, Rossello, Ceretti –; quello del giornalismo e della scrittura – collaborò con La Notte e il Corriere dei Piccoli e per oltre 18 anni con Enzo Biagi, realizzando i disegni delle schede dei programmi condotti dal giornalista; e quello dell’animazione culturale e dell’organizzazione teatrale, anche a livello istituzionale – e qui l’elenco delle sue attività è lungo, a cominciare dalla fondazione di Astra, Associazione teatro ragazzi, nel 1977.
Mentre sono al telefono con Claudio Madia, altro nome noto legato a L’albero azzurro di cui Madia fu primo conduttore insieme a Francesca Paganini, mi accorgo che il discorso su Tinin, che fu amato amico e amatissimo maestro, scivola altrove. E precisamente su tutto il lavoro meno visibile svolto in tanti anni di lavoro in campi che si nutrirono l’uno l’altro e che comunicarono l’uno con l’altro dando luogo a una ricchezza di esperienze, di studi, di sperimentazioni e di relazioni in grado di dar luogo a una cultura professionale solidissima, elargita con naturalezza, spontaneità e grande generosità.

Insomma, un eclettismo capace di dare una misura di ricerca umana e professionale indefessa che spaziava ovunque la curiosità portasse, e con una forte vocazione pedagogica. Perché Tinin e Velia Mantegazza, come capita ad alcune personalità molto creative e la cui creatività ha a che fare con una dimensione collettiva – come il teatro, lo spettacolo, il giornalismo – dove l’opera è il risultato di una macchina che funziona solo se si è capaci di lavorare con gli altri, sono stati e continuano a essere anche due grandi maestri, capaci di far crescere accanto a sé il talento e i percorsi professionali degli altri.
E infatti una delle parole che torna di più nella conversazione con Claudio Maida è squadra. Torna la capacità di Tinin e Velia di creare squadre di lavoro, di fare squadra, una dimensione collettiva di esperienza in cui ognuno è spinto a dare il meglio di sé e delle proprie competenze, non per una idea di successo o di performance fine a se stessa, ma per un profondo rispetto dello spettacolo, del teatro, della musica, del pubblico, in particolare di quello dei bambini.
Claudio mi spiega che una delle grandi virtù dei Mantegazza è stata la capacità di fare rete, di far comunicare ambiti, come portare nel teatro per i bambini i migliori artisti, attori e musicisti sulla piazza, per esempio quelli conosciuti all’epoca del Cab64, come la Vanoni, Paoli, Ricki Gianco. Ma nello stesso tempo anche dare credito a persone giovani e poco conosciute, all’inizio del loro percorso di lavoro e di vita, magari in ambiti aut off. Per esempio, l’interesse di Tinin per i circhi, la giocoleria, il teatro di strada (in Italia poco frequentato, fino a non molti anni fa), i burattini, le forme di spettacolo più popolare – interesse che si concretizzò in una serie di azioni per sostenerlo e promuoverlo –, andò ad alimentare da una parte la qualità e la vivacità di programma televisivi come L’albero azzurro, dall’altra fece sì che ambiti considerati marginali o desueti acquistassero visibilità o riacquistassero impulso e freschezza, si rinnovassero, contaminandosi con forme ed esperienze di discipline d’arte contemporanee.
In questo senso, il carattere più autentico dei Mantegazza è stato quello di essere fondatori, ispiratori, studiosi e sperimentatori, sempre attenti al sociale, capaci di pensare al plurale, di tramandare esperienze e conoscenze, tecniche, tradizioni, saperi.
Dei bambini i Mantegazza, nel tempo, si innamorarono, senza alcuna di quelle posture manierate e sentimentali che possono contrassegnare il comportamento di chi si dedica loro. Ironici, spesso sarcastici, ma anche sornioni e affettuosi, quello che apprezzavano incondizionatamente era la ricchezza del mondo e dell’immaginario infantile. Per esempio una disposizione giocosa all’errore, all’imperfezione come terreno di divertimento e apprendimento senza le pastoie del misurarsi a tutti i costi con la performance autoriale. Ricordando l’audizione che sostenne alla Rai per essere preso alla trasmissione L’albero azzurro, a cui Mantegazza assistette, Madia mi dice: «Non avevo la preoccupazione di mostrarmi bravo a tutti i costi. Mi concedevo il diritto di sbagliare come sbagliano i bambini, con la leggerezza di farlo, considerando l’errore un’opportunità in più. Forse per questo gli piacqui. Questa era anche la sua filosofia che nel tempo ho sempre più fatta mia.»
Mentre lo ascolto ricordare Tinin Mantegazza con parole di autentica gratitudine, mi accorgo di avere la tentazione, fatale in queste situazioni, di pensare che i tempi di cui si sta parlando non sono i nostri. Che nella Milano e nell’Italia degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, quando Tinin e Velia Mantegazza cominciarono il loro straordinario percorso artistico e intellettuale, forse era tutto diverso e tutto possibile, perché erano epoche contrassegnate da una spinta ideale, sociale, umana diversa, e da una forza e una vivacità oggi impensabili. La tentazione di pensare che temperamenti creativi così poliedrici, oggi, in cui il lavoro è sempre più parcellizzato e specialistico, sono impossibili da esprimere, coltivare, e che raramente figure così carismatiche e non convenzionali possano trovare ascolto, spazio, riconoscimento.
Non lascio, però, che il pensiero prenda corpo, perché una cosa mi pare di intuire nelle parole di chi Tinin e Velia li ha conosciuti bene. E cioè che la loro storia insegna che ognuno di noi il proprio tempo è chiamato a conoscerlo e costruirlo, che ognuno di noi il proprio spazio deve imparare ad abitarlo, farlo proprio e cambiarlo insieme agli altri, esattamente come hanno fatto loro, con costanza, impegno, dedizione, studio e passione inesauribili. E questo è quello che di più importante probabilmente può fare un artista per le generazioni di oggi e del futuro.
Franco Vaccari (Modena, 1936) nutre profondo interesse per la dimensione onirica, fin dall’infanzia. Dal 1975 il sogno entra anche nella sua ricerca artistica. Diventa una sorta di correlativo oggettivo di un dispositivo concettuale. Attraverso cinque Esposizioni in tempo reale– oltre a una vasta produzione di opere e annotazioni su quaderni, dove fotografia e pittura convivono per rappresentare sogni notturni, soggetti e forme suggeriti dai meccanismi dell’inconscio o da un’alterità misteriosa – Vaccari indaga e rende visibile il profondo legame tra il mondo dei sogni e il suo ruolo di artista, inteso come innescatore di processi: «il ruolo di "controllore a distanza" si dissolve a sua volta in quanto il sogno funziona da attivatore di realtà, cioè da pretesto per dirottare una situazione apparentemente definita verso esiti imprevisti, verso il reale inaspettato».
Nella mostra Migrazione del reale, allestita alla Galleria P420 di Bologna, il reale inaspettato è un asteroide interstellare, che giunge da una ineffabile lontananza e incombe in uno spazio siderale, avvicinandosi sempre più alla nostra coscienza. Questo asteroide è “realmente” il primo oggetto interstellare a incrociare i piani orbitali dei pianeti del sistema solare, per poi dirigersi nuovamente nello spazio profondo. Vaccari lo ha percepito come esistenza reale, come un sogno premonitore. E lo ha messo in relazione con appunti segnici e letterali, collegamenti e interpretazioni dei suoi sogni notturni, con le immagini che sono giunte da un’altra dimensione. Abbiamo posto alcune domande all’artista, come se fossimo giunti in un luogo arcaico, dedicato all’attività oracolare, come a Dodona o a Delfi, attendendo una visione o un ulteriore enigma da risolvere, come al cospetto di Pizia, di Cassandra o di una Sibilla, di fronte a una divinazione per ispirazione del nume o intuitiva, affidandoci all’oniromanzia.

Franco Vaccari, I sogni, spazio privato in spazio pubblico 1975.
Mauro Zanchi: Da dove provengono i sogni?
Franco Vaccari: Su che cosa siano i sogni e quale sia la loro funzione ci sono opinioni tra loro diversissime. Però hanno sempre colpito l’uomo dai tempi più antichi, per la forza delle immagini e per la superiore estraneità rispetto al nostro vissuto. Riescono a dare importanza a tanti aspetti del nostro vissuto, pur essendo apparentemente così estranei. Siccome ero un sognatore piuttosto accanito, ho pensato di non disperdere questo patrimonio onirico, che mi sembrava una sorta di ricchezza in potenza, non sapendo come avrei potuto utilizzarla. Scrivendo dei testi che si riferissero ai sogni, quando mi colpiva qualche immagine particolare, provavo anche a disegnarla. Non mi interessano gli aspetti dello straordinario e dell'eccezionale nel mondo onirico, nemmeno la dimensione surreale o straniante, e neppure quella psicanalitica. Mi affascina la dimensione reale del sogno. Mi sembra che il mondo reale si sia svuotato di realtà. Immagino che gli aspetti più misteriosi e rivelatori del reale siano migrati verso la dimensione del sogno.

Franco Vaccari, Messaggero che arriva per primo da lontano, 2020, Video installazione, courtesy of the artist, Bologna, credit Esom Kornmesser, USA.
Hai vissuto anche sogni preveggenti, o visioni simili a quelle che sono state descritte da antropologi venuti in contatto con sciamani di altre culture?
Sì, io ho fatto anche quei sogni che tu chiami “preveggenti”. Non sono stati esposti in questa mostra, per il semplice fatto che costituiscono un nucleo che non andrebbe disperso in mezzo ad altre immagini, ma potrebbero essere l’argomento di un’altra mostra, dove si potrebbe concentrare l’attenzione proprio su questo aspetto dei sogni.
Cosa evochi in Migrazione del reale e attraverso l’installazione video, che ha per soggetto un asteroide interstellare, proveniente da un luogo indefinito o indeterminato?
La notizia dell’apparizione di questo asteroide, nel campo di osservazione dei nostri mezzi di indagine dello spazio, è recente. L’asteroide ha suscitato molte curiosità, per la forma e per la provenienza, che pare essere extragalattica. È quindi un’apparizione momentanea, prima di sparire di nuovo nell’universo. Quello che mi ha colpito è il fatto che sia stato scoperto dall’osservatorio delle Hawaii e che le popolazioni di quell’arcipelago, dopo aver visto le immagini di questo asteroide, lo abbiano battezzato col nome “Oumuamua”, che nella lingua locale sembra che voglia dire “Messaggero che arriva per primo da lontano” o “Visitatore che giunge da un luogo indefinito”. Siccome stavo preparando la mostra alla Galleria P420 sul tema dei sogni, ho trovato che il nome dato a questo asteroide – che mi aveva colpito per la sua immagine e per la forma, assolutamente imprevista per un corpo che viene dallo spazio celeste – andasse perfettamente d’accordo con il tema delle mie opere, che era il tema del sogno. I sogni sono immagini, che sembrano provenire da chissà quale spazio, non soltanto interiore. Quindi ho unito – anche se i due soggetti sembrano apparentemente distanti – lo spazio dedicato alla mia opera con quello dedicato a questo asteroide.

Franco Vaccari, Migrazione del reale, 2020, Installation view, courtesy of the artist, P420 Bologna, ph Carlo Favero.
Alcuni sogni che hai vissuto ti hanno portato intuizioni, che sono poi entrate nelle opere della tua ricerca?
Beh, ci sono dei sogni che mi hanno comunicato intuizioni, quelle che possono essere verità particolari. Per esempio, c’è quello dove ci sono pugni, che tengono stretta l’asta di certe bandiere. Lo trovo uno dei miei sogni più significativi, dove si vedono mani che tentano di tenere in pugno la sabbia e oggetti raccolti. Ci sono anche dei tumuli di sepoltura, che tentano di resistere all’azione del vento e, invece, vengono dispersi dal vento. I pugni che tentano di tener stretta la sabbia o questi oggetti che sono stati raccolti in realtà vengono svuotati dall’azione del vento. Il vento chiaramente rappresenta, secondo me, il tempo. E la parte veramente interessante, anomala, rispetto ad altri sogni, è che c’è qualcosa che viene da lontano, come il corpo celeste, l’asteroide. Qui si ode una voce fuori campo. Dice qualcosa che mi ha molto colpito: “Non bisogna resistere all’azione del vento, perché è uno sforzo inutile destinato al fallimento. Invece bisogna fare come le bandiere, che si dispiegano e prendono vita nel vento”.
È inutile opporsi all’azione livellante del tempo, ma bisogna approfittare del tempo per dispiegare la propria natura. E trovo che sia un consiglio veramente meraviglioso.
In una delle opere esposte alla Galleria P420 c’è anche un riferimento all’opera d’arte che è entrata in un tuo sogno: un segno di Capogrossi. Ci puoi parlare del sottile rapporto fra sogno, opere d’arte di altri artisti, cose viste, segni, figure, idee, concetti, che entrano nell’immaginario?
Nel sogno subentrano tantissime cose. Quando ho dovuto rendere l’immagine che vedevo sulle superfici delle uova, mi è venuto in mente Capogrossi. Ma, in realtà, forse l’immagine più precisa erano i cromosomi, nel momento in cui si suddividono, dando luogo ai corpi, allo sviluppo. Nel mio sogno c’era qualcosa che mi ricordava l’inizio dello sviluppo dei corpi. Allora questa danza dei cromosomi mi è sembrata abbastanza simile alla danza dei segni misteriosi presenti nelle opere di Capogrossi, che non sono solo decorativi, ma vogliono probabilmente dire anche qualcos’altro e hanno radici più profonde.

Franco Vaccari, Migrazione del reale, 2020, Installation view, courtesy of the artist, P420 Bologna, ph Carlo Favero.
Ora ti pongo una domanda che si sposta verso il futuro. Come immagini ulteriori possibilità del medium della fotografia e della fotografia contemporanea ibridata con altri media o questioni?
La fotografia è in un momento il cui argomento è in eclisse, per quanto mi riguarda. Noi vediamo tante immagini e le immagini fotografiche sono un po’ sommerse da questa quantità. Qui, proprio poco fa, nella galleria è venuto in visita Erik Kessels, che è diventato famoso per aver fatto delle mostre dove vengono esposte caterve di immagini, milioni di fotografie, che lui non so in che modo riesca a stampare in brevissimo tempo. Allora la fotografia in questo senso perde buona parte dell’interesse. Tu immagina quella che era la magia dell’apparizione dell’immagine fotografica ai primordi della sua invenzione. Oggi è estremamente banalizzata. Però, secondo me, la fotografia subisce un po’ un processo di normalizzazione, dove lo stupore passa quasi totalmente, come per la luce nel telefono. Anche le telefonate nel loro apparire potevano essere oggetto di mostre. L’apparizione della voce di un corpo, di un essere, che per noi poteva significare tanto, ma a distanza enorme, doveva essere fonte di una meraviglia incredibile. Però adesso con la telefonata chi è che riesce a emozionarsi più sentendo una voce? Anche se ci sono situazioni in cui questo ancora si verifica, come per esempio è accaduto a Rigopiano qualche tempo fa, dove una valanga di neve ha sepolto un albergo. Ci sono state telefonate da parte di persone, che poi sono morte, che da sotto la neve si erano messe in contatto con i loro cari o con quelli che avrebbero forse potuto andare a salvarli.

Franco Vaccari, I sogni, spazio privato in spazio pubblico 1975.
Un altro aspetto molto importante della tua ricerca è stato l’inconscio tecnologico. Ha lasciato il segno negli anni ’70 e nei decenni successivi. Adesso, a distanza di anni, che cosa trovi di pulsante e vitale in questa tua intuizione?
Adesso siamo nel momento in cui si sta preparando una rivoluzione tecnologica incredibile, della quale non sappiamo lontanamente quali potranno essere gli sviluppi e gli approdi. È la comunicazione dovuta all’Intelligenza Artificiale. Quando i mezzi tecnologici avranno a disposizione gli strumenti dell’Intelligenza Artificiale, soprattutto quelli nati dalla meccanica quantistica, in cui gli scambi di informazione e di operazioni para-mentali subiranno un’accelerazione tale da ridicolizzare il funzionamento del nostro sistema nervoso. Quindi lì ne succederanno di tutti i colori.

Franco Vaccari, Migrazione del reale, 2020, Installation view, courtesy of the artist, P420 Bologna, ph Carlo Favero.
Quindi come immagini tu l’utilizzo di una macchina fotografica quantistica? Che immagini potrà realizzare?
Ah, non so. Dicono, per esempio – è una notizia apparsa in questo ultimo periodo – che l’immagine più importante del 2019 sia la fotografia del buco nero. Non è stata ottenuta attraverso un apparato, che con lo schiacciamento di un bottone restituisce un’immagine, ma è nata dalla sovrapposizione e dall’interferenza di una quantità di immagini ottenuta con dei mezzi incredibili, in cui l’intero apparato di recezione è stato il globo terrestre. Queste informazioni, che sono state raccolte con un apparato che era diffuso sul globo terrestre, hanno portato alla produzione di un’immagine che non poteva essere ottenuta attraverso l’uso di un mezzo classico. Quindi, non riesco proprio a figurarmi cosa ci mostrerà la macchina fotografica quantistica, nel momento in cui il passato, il presente e il futuro potranno essere colti nello stesso istante.

Franco Vaccari, Migrazione del reale, 2020, Installation view, courtesy of the artist, P420 Bologna, ph Carlo Favero.
Ammettiamo che sia ora possibile mettere in commercio la macchina quantistica, e che inneschi una nuova rivoluzione fotografica. Se porta con sé tutte le questioni dello spazio-tempo e le scoperte della fisica quantistica, sarà possibile secondo te fare fotografie anche di qualcosa che accadrà in futuro? La fotografia non sarà più un documento, uno scatto di qualcosa che viene colto in un determinato momento presente, ma potrà essere una previsione, un istante del futuro?
FV: Ah beh, sarà l’eclisse del mito di Cartier-Bresson.
Il primo di giugno è morto a Cesena Tinin Mantegazza, il cui nome è legato in questi giorni da cronaca e media, soprattutto alla storica trasmissione Rai L’albero azzurro, dedicata ai bambini e ai ragazzi, andata in onda per la prima volta il 21 maggio 1990, e che nel 2020 ha festeggiato i trent’anni.
Mantegazza, insieme alla moglie Velia, perché i loro nomi formano un inscindibile binomio che trattandosi di cultura per l’infanzia vien bene chiamare fantastico, creò uno dei pupazzi simbolo che ha animato la trasmissione: l’uccello Dodò. Ma fu ideatore e progettista, nel corso della sua lunga vita creativa, di oltre duemila creature di scena per la tv e per il teatro, come ricorda una mostra inaugurata ad aprile dello scorso anno a Bagnacavallo, al Museo delle Cappuccine: Tinin Mantegazza. Le sette vite di un creativo irriverente.
E infatti una delle caratteristiche della sua figura è l’inesauribile vena creatrice con cui frequentò campi disparati: quello del teatro e dello spettacolo – oltre a lavorare alla Rai, fondò uno dei locali mito del cabaret milanese il Cab64, dove debuttarono Jannacci e Gaber, e passarono musicisti e attori come Paolo Poli, Cochi e Renato, Bruno Lauzi, e sempre a Milano fondò nel 1978 il Teatro del Buratto e diresse il Teatro Verdi –; il campo delle arti visive – fu scenografo, illustratore, pittore, fondò la galleria d’arte La Muffola, dove esposero artisti come Luzzati, Pericoli, Rossello, Ceretti –; quello del giornalismo e della scrittura – collaborò con La Notte e il Corriere dei Piccoli e per oltre 18 anni con Enzo Biagi, realizzando i disegni delle schede dei programmi condotti dal giornalista; e quello dell’animazione culturale e dell’organizzazione teatrale, anche a livello istituzionale – e qui l’elenco delle sue attività è lungo, a cominciare dalla fondazione di Astra, Associazione teatro ragazzi, nel 1977.
Mentre sono al telefono con Claudio Madia, altro nome noto legato a L’albero azzurro di cui Madia fu primo conduttore insieme a Francesca Paganini, mi accorgo che il discorso su Tinin, che fu amato amico e amatissimo maestro, scivola altrove. E precisamente su tutto il lavoro meno visibile svolto in tanti anni di lavoro in campi che si nutrirono l’uno l’altro e che comunicarono l’uno con l’altro dando luogo a una ricchezza di esperienze, di studi, di sperimentazioni e di relazioni in grado di dar luogo a una cultura professionale solidissima, elargita con naturalezza, spontaneità e grande generosità.

Insomma, un eclettismo capace di dare una misura di ricerca umana e professionale indefessa che spaziava ovunque la curiosità portasse, e con una forte vocazione pedagogica. Perché Tinin e Velia Mantegazza, come capita ad alcune personalità molto creative e la cui creatività ha a che fare con una dimensione collettiva – come il teatro, lo spettacolo, il giornalismo – dove l’opera è il risultato di una macchina che funziona solo se si è capaci di lavorare con gli altri, sono stati e continuano a essere anche due grandi maestri, capaci di far crescere accanto a sé il talento e i percorsi professionali degli altri.
E infatti una delle parole che torna di più nella conversazione con Claudio Maida è squadra. Torna la capacità di Tinin e Velia di creare squadre di lavoro, di fare squadra, una dimensione collettiva di esperienza in cui ognuno è spinto a dare il meglio di sé e delle proprie competenze, non per una idea di successo o di performance fine a se stessa, ma per un profondo rispetto dello spettacolo, del teatro, della musica, del pubblico, in particolare di quello dei bambini.
Claudio mi spiega che una delle grandi virtù dei Mantegazza è stata la capacità di fare rete, di far comunicare ambiti, come portare nel teatro per i bambini i migliori artisti, attori e musicisti sulla piazza, per esempio quelli conosciuti all’epoca del Cab64, come la Vanoni, Paoli, Ricki Gianco. Ma nello stesso tempo anche dare credito a persone giovani e poco conosciute, all’inizio del loro percorso di lavoro e di vita, magari in ambiti aut off. Per esempio, l’interesse di Tinin per i circhi, la giocoleria, il teatro di strada (in Italia poco frequentato, fino a non molti anni fa), i burattini, le forme di spettacolo più popolare – interesse che si concretizzò in una serie di azioni per sostenerlo e promuoverlo –, andò ad alimentare da una parte la qualità e la vivacità di programma televisivi come L’albero azzurro, dall’altra fece sì che ambiti considerati marginali o desueti acquistassero visibilità o riacquistassero impulso e freschezza, si rinnovassero, contaminandosi con forme ed esperienze di discipline d’arte contemporanee.
In questo senso, il carattere più autentico dei Mantegazza è stato quello di essere fondatori, ispiratori, studiosi e sperimentatori, sempre attenti al sociale, capaci di pensare al plurale, di tramandare esperienze e conoscenze, tecniche, tradizioni, saperi.
Dei bambini i Mantegazza, nel tempo, si innamorarono, senza alcuna di quelle posture manierate e sentimentali che possono contrassegnare il comportamento di chi si dedica loro. Ironici, spesso sarcastici, ma anche sornioni e affettuosi, quello che apprezzavano incondizionatamente era la ricchezza del mondo e dell’immaginario infantile. Per esempio una disposizione giocosa all’errore, all’imperfezione come terreno di divertimento e apprendimento senza le pastoie del misurarsi a tutti i costi con la performance autoriale. Ricordando l’audizione che sostenne alla Rai per essere preso alla trasmissione L’albero azzurro, a cui Mantegazza assistette, Madia mi dice: «Non avevo la preoccupazione di mostrarmi bravo a tutti i costi. Mi concedevo il diritto di sbagliare come sbagliano i bambini, con la leggerezza di farlo, considerando l’errore un’opportunità in più. Forse per questo gli piacqui. Questa era anche la sua filosofia che nel tempo ho sempre più fatta mia.»
Mentre lo ascolto ricordare Tinin Mantegazza con parole di autentica gratitudine, mi accorgo di avere la tentazione, fatale in queste situazioni, di pensare che i tempi di cui si sta parlando non sono i nostri. Che nella Milano e nell’Italia degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, quando Tinin e Velia Mantegazza cominciarono il loro straordinario percorso artistico e intellettuale, forse era tutto diverso e tutto possibile, perché erano epoche contrassegnate da una spinta ideale, sociale, umana diversa, e da una forza e una vivacità oggi impensabili. La tentazione di pensare che temperamenti creativi così poliedrici, oggi, in cui il lavoro è sempre più parcellizzato e specialistico, sono impossibili da esprimere, coltivare, e che raramente figure così carismatiche e non convenzionali possano trovare ascolto, spazio, riconoscimento.
Non lascio, però, che il pensiero prenda corpo, perché una cosa mi pare di intuire nelle parole di chi Tinin e Velia li ha conosciuti bene. E cioè che la loro storia insegna che ognuno di noi il proprio tempo è chiamato a conoscerlo e costruirlo, che ognuno di noi il proprio spazio deve imparare ad abitarlo, farlo proprio e cambiarlo insieme agli altri, esattamente come hanno fatto loro, con costanza, impegno, dedizione, studio e passione inesauribili. E questo è quello che di più importante probabilmente può fare un artista per le generazioni di oggi e del futuro.
Gli interrogativi sullo statuto dell’opera d’arte che la riflessione di Arthur C. Danto solleva potrebbero coinvolgere tutta la storia dell’estetica, pur nascendo da un singolare e fortunato incontro avvenuto a Manhattan nel 1964. È qui che, nei locali della Stable Gallery, veniva esposta per la prima volta Brillo Box, l’opera iconica di Andy Warhol, una delle più note dell’artista americano e fenomeno inaugurale di un nuovo modo di pensare l’arte. Da questa novità, incarnata da banali scatole di detersivo esposte in una galleria, trasfigurate in opere d’arte, prende avvio la filosofia dell’arte di Danto, che ruota, com’è noto, attorno a una domanda chiave: che cos’è un’opera d’arte? O meglio, che cosa rende un’opera d’arte tale, quando dal punto di vista estetico e percettivo nessuna differenza sostanziale permette di distinguerla da un altro oggetto banale, di uso quotidiano? E quindi che cosa differenzia, non da un punto di vista estetico, bensì essenziale, ontologico, le comuni scatole di detersivo Brillo (seppur disegnate, com’è noto, dall’artista James Harvey) vendute nei supermercati americani, dalle Brillo di Warhol, trattandosi in apparenza di oggetti indiscernibili?
Se è vero che la filosofia è fatta di domande ben poste, è subito chiaro che quella di Danto, occasionata dall’incontro con l’opera di Warhol, nasconde dietro la sua semplicità una complessa valenza filosofica: la riposta è tutt’altro che scontata, come testimoniano i dibattiti attorno alla sua teoria; la problematica che essa solleva lungi dall’essere evasa. Davanti all’opera di Warhol, davanti a un ready-made duchampiano, in una sala qualunque di un qualunque museo di arte contemporanea non è poi così insolito che qualcuno si chieda “perché questa cosa qui è un’opera d’arte”? Accanto a questo interrogativo, più specifico e più noto, ne emerge un secondo che, come si accennava all’inizio, riguarda più in generale la storia dell’estetica e del rapporto che la filosofia può intrattenere con l’arte. Qual è dunque questo rapporto e che cosa differenzia l’estetica come disciplina filosofica da una filosofia dell’arte, che Danto dice di voler praticare a scapito appunto della prima, seguendo una traiettoria che da Hegel lo porta fin dentro il dibattito analitico contemporaneo sull’essenza dell’opera d’arte?
Se le opere d’arte sono per Danto sempre a proposito di qualcosa (aboutness), se esse sono significati incarnati (embodied meanings), per identificarle e definirle non occorre, secondo il filosofo americano, ricorrere all’estetica e ai suoi classici canoni, primo tra tutti la bellezza, o almeno non più: nel caso emblematico delle Brillo, per esempio, nessuna qualità esteriore le definisce in quanto opere, ma è solo una catena di rimandi tra significato e interpretazione che ne sancisce l’ingresso nel “mondo dell’arte”. Quest’ultimo è un aspetto della particolare torsione che Danto fa subire all’idea di matrice hegeliana di fine dell’arte (sebbene nelle sue lezioni di Estetica Hegel parli più di bella arte come qualcosa di passato, piuttosto che di morto o di finito): essendosi la pratica artistica affrancata da ogni ricerca estetica attorno alla bellezza, se nulla di bello potrà ancora esistere, che ne è dell’opera d’arte oggi? Se l’arte non basta più a se stessa, se essa ha bisogno di molto pensiero per essere compresa e definita, qual è il rapporto che con essa può avere la filosofia?

Andy Warhol, Brillo Box, 1964 acrilico su legno, 33 Å~ 40,7 Å~ 9,2 cm ˝ Andy Warhol Foundation, SIAE 2020 Collezione privata.
Questi temi, filosoficamente densi, sono tutti diffusamente affrontati nei dialoghi e nelle interviste che Demetrio Paparoni, storico dell’arte e critico, fondatore della rivista Tema Celeste, ha intrattenuto con Danto nel corso di diversi anni, prima di pubblicarle nel volume Arte e Poststoria. Conversazioni sulla fine dell’estetica e altro (Neri Pozza, 2020). Scambi a due o tre voci (in due delle quattro conversazioni presentate sono coinvolti anche l’artista Mimmo Paladino e il filosofo Mario Perniola), che permettono di gettare ancora uno sguardo sugli ultimi sessant’anni della produzione artistica contemporanea, attraverso il sodalizio intellettuale e l’amicizia che legava Paparoni al filosofo statunitense. Della filosofia e della postura critica di Danto, Paparoni fornisce un accessibile e sintetico resoconto nel saggio di apertura (“Nella stanza di Judy”), avendo cura di mettere in prospettiva l’apporto del filosofo statunitense rispetto alla sua postura di critico d’arte e illuminando, col potere rivelatore della “presa diretta”, importanti nodi concettuali del pensiero di Danto. Le tappe comuni di un percorso tutto interno al mondo dell’arte contemporanea (condiviso con altri intellettuali, critici e artisti, come Sean Scully, amico comune) vivificano, infatti, le conversazioni contenute nel volume, un lungo e ininterrotto dialogo cui il lettore è di volta in volta invitato a prendere parte, pur beneficiando dello statuto dell’osservatore esterno, o di chi sbircia dal buco della serratura: come quando Paparoni racconta che Danto e la moglie Barbara Westman possedevano in casa una Brillo Box, “la versione su fondo bianco, la più nota […] La tenevano nella stanza in cui ricevevano gli amici nell’appartamento dell’Upper West Side, davanti al fiume Hudson”. Tuttavia, continua Papaproni,“non si trattava di una Brillo Box di Warhol, ma di un rifacimento di Bidlo (Brillo Soap Pads Box/Pasadena Version, 1969, data di esecuzione 1991)”. Quest’aneddoto è quanto mai significativo per tematizzare due punti chiave del pensiero di Danto, che il volume curato da Paparoni solleva, quello di post-storia e quello di fine dell’estetica.
Attraverso lo sviluppo intrinseco dell’arte – afferma Danto in una delle conversazioni –è emersa la vera forma della questione filosofica riguardante la natura dell’arte, vale a dire: perché un oggetto (per esempio la Brillo Box) è un’opera d’arte, mentre un altro oggetto assolutamente identico al primo dal punto di vista percettivo (per esempio una scatola di Brillo) non lo è? Pensavo che ciò riguardasse solo il caso di Warhol, ma la medesima questione si è sollevata lungo tutto il fronte dell’arte più o meno nello stesso momento (1965). Preferirei quindi dire che, a un dato momento, l’arte in quanto sforzo collettivo, attraverso il suo sviluppo interno, portò a coscienza la propria questione filosofica. (p. 61)

Se la storia dell’arte, intesa come progressione lineare, culmina con la rottura provocata dalle Brillo di Warhol, se è Warhol, più di Duchamp, a sancire il carattere di passato dell’arte (la differenza è da ritrovarsi, per Danto, nel diverso scarto che i due artisti producono tra l’oggetto e l’opera d’arte), a decretare la fine dell’estetica e l’inapplicabilità dei suoi concetti; se, quindi, la storia dell’arte come ricerca formale della compiuta bellezza dell’opera finisce, quali scenari si profilano, che cosa diventa l’opera d’arte?
Una volta terminata la narrazione, non esiste più una direzione storica privilegiata. Ciò corrisponde all’estremo pluralismo tipico della fase poststorica dell’arte. A tale livello di separatezza, può esistere qualcosa che equivalga a uno stile? Credo che questa sia veramente una domanda difficile; basti pensare ai problemi sollevati dall’arte dell’appropriazione. Credo che questa sia veramente una domanda difficile; basti pensare ai problemi sollevati dall’arte dell’appropriazione. Pensiamo a Mike Bidlo o a Sherrie Levine: ogni stile è a disposizione degli artisti nel momento in cui essi decidono di avvalersene. (p. 62)
L’opera d’arte diventa allora un “oggetto non stabile”, come suggerisce Perniola nella conversazione cui prende parte (p.67), plurale da un punto di vista stilistico ma anche temporale, storico: la fine dell’arte non coincide affatto con la sua morte o la sua scomparsa, ma con una trasformazione, un’apertura. Paparoni ricorda, a tal proposito, un’altra opera che ha nutrito la riflessione di Danto, il video Judy’s Bedroom (1994), di David Reed, che dà il titolo al suo saggio. L’opera di Reed è una manipolazione digitale della scena del film di Hitchcock, Vertigo (1958), in cui Judy è nella sua stanza da letto, alle sue spalle è ben visibile un quadro, una natura morta. Reed sostituisce il quadro presente nella scena originaria con un suo dipinto astratto, realizzato nel 1990, creando così, dice Danto, una “impossibilità storica”: mentre una natura morta, indeterminata nello stile e nell’epoca non suscita alcun problema, un dipinto astratto degli anni ’90 non potrebbe mai essere davvero presente nella scena del film.

David Reed, Judy’s Bedroom, 1992 Installation view at Museum für Moderne Kunst, Frankfurt. In the permanent collection of Museum für Moderne Kunst, Frankfurt. ˝ David Reed. Courtesy dell’artista.
Il video di Reed, rileva Paparoni, mostra dunque un tempo storico ibrido, figlio di due momenti temporali diversi e distanti, incompatibili in una visione lineare e progressiva del tempo (p. 31), ma compatibili con la teoria di Danto secondo cui essenzialismo – ovvero la necessità propria di una filosofia analitica di trovare una definizione universalmente valida di opera d’arte – e storicismo, ovvero la presa in carico della storicità delle opere d’arte, intesa come possibilità storica della loro esistenza, non sarebbero tra loro in contraddizione : è proprio il fatto che ci sia, credo, un’essenza dell’arte– afferma Danto in un altro suo testo – che rende possibile il pluralismo artistico. Se, in tal senso, ci riferiamo a un altro momento cruciale dell’arte contemporanea spesso citato da Danto, l’affermazione dell’Appropriation Art– tornando quindi alle Brillo di Bidlo che il filosofo possedeva in casa, o pensando ad altre opere spesso citate, anche in queste conversazioni, come le fotografie di Sherrie Levine – vediamo come si produca uno scarto rispetto alla domanda iniziale, un salto che però ne è una diretta conseguenza. Se la differenza tra un banale oggetto e un’opera in apparenza indiscernibile risiede nella capacità di quest’ultima di incarnare un significato e quindi di richiedere interpretazioni, storiche e filosofiche, che cosa differenzia invece altre opere, per esempio quelle appropriazioniste, dalle semplici copie, che cosa conferisce loro lo statuto di opera d’arte originale? La copia della copia, per scimmiottare il gergo platonico, diventa opera d’arte nel momento in cui si fa carico di esigenze storicamente determinate e suggerisce nuove domande sullo statuto dell’opera, forzandone i limiti. Pur essendo simile o identica a un’opera del passato, dice Paparoni, “essa esprimerà comunque il suo momento storico grazie al suo significato incarnato, grazie al fatto cioè che essa porta con sé le motivazioni che hanno spinto l’artista ad appropriarsi di un’opera realizzata in precedenza da altri, con la differenza che non sarà il suo valore visivo a definirne il significato ma le motivazioni filosofiche che porta con sé.” (p. 32). Ecco quindi uno dei punti più interessanti che queste conversazioni permettono di sollevare: non tanto una riflessione sull’essenza dell’opera d’arte, quanto piuttosto un’interrogazione sulla sua storicità e sul rapporto che essa può stabilire con la storia (dell’arte), con il proprio tempo e col concetto stesso di tempo. Questo è forse il lascito più interessante della filosofia dell’arte hegeliana, che la filosofia dell’arte di Danto ci permette di raccogliere.