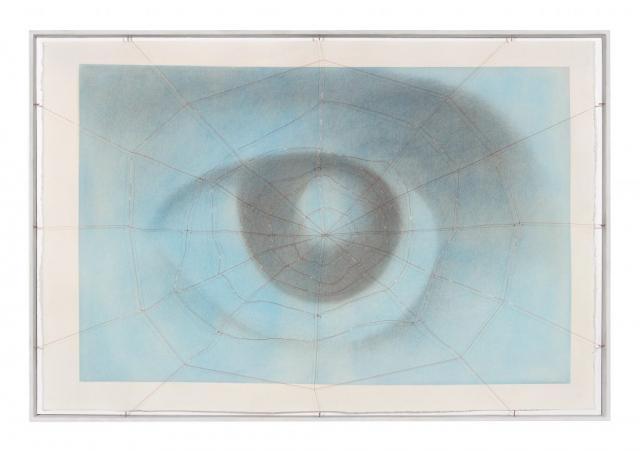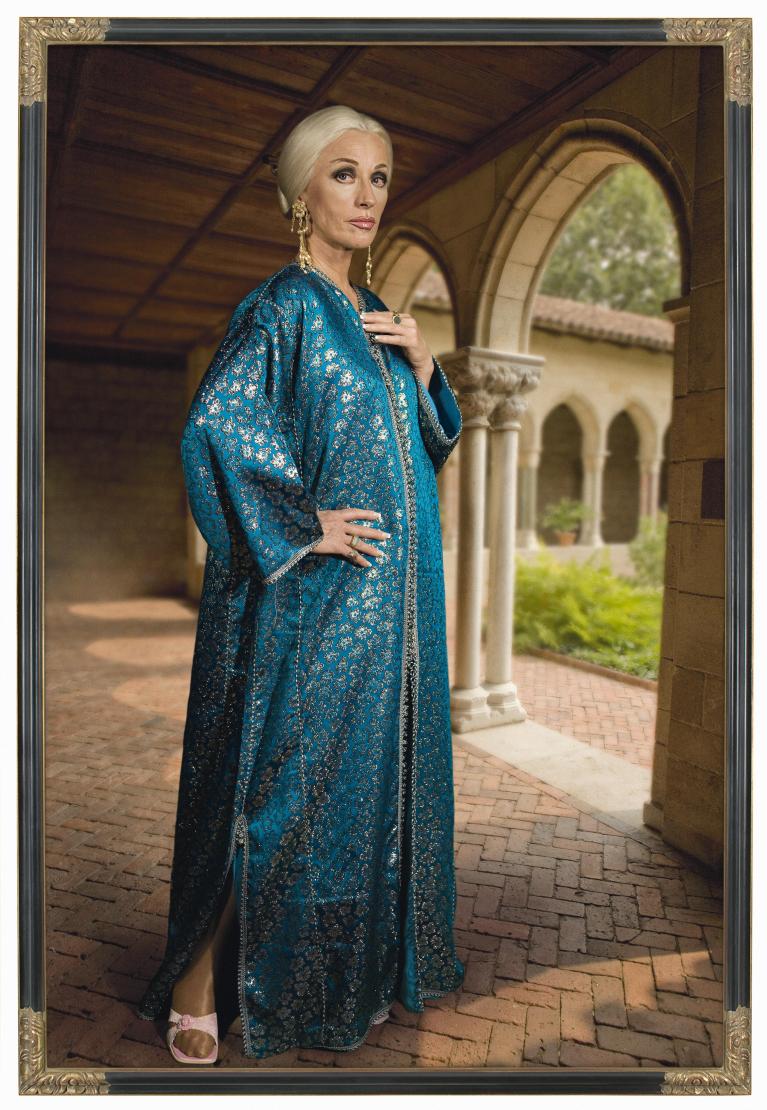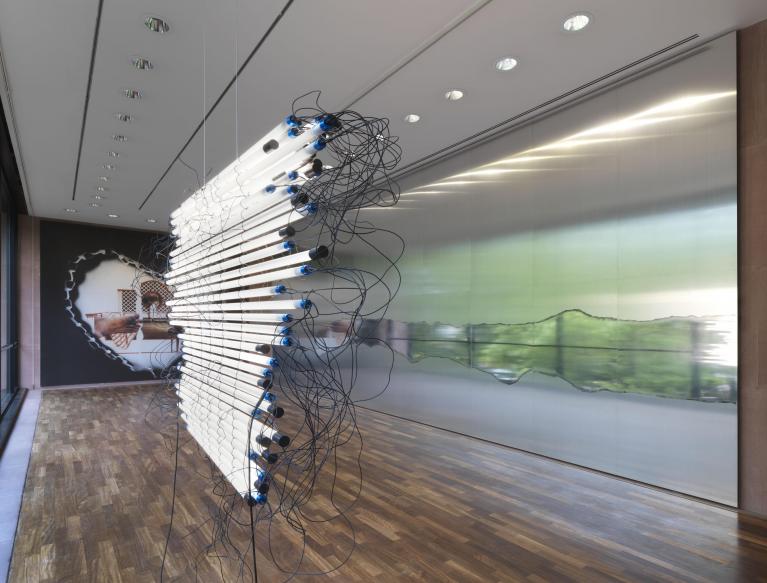Nella notte tra il 7 e l'8 agosto 1943 l'aviazione alleata sgancia le sue bombe sulla città di Milano. Replicherà con altrettanta violenza nelle notti tra il 12 e 13 e tra il 14 e 15 agosto.
La Stampa del 14 agosto, scrive: “Milano ha subito un nuovo violento bombardamento. Si può dire che nessun rione, nessuna zona, nessuna strada centrale o periferica di Milano sia stata esente dal suo doloroso e sanguinoso contributo. Il centro ha avuto deturpazioni che rimarranno a testimonianza dello scarso spirito di civiltà dei nostri nemici. La periferia e i sobborghi, dal canto loro, hanno sofferto mutilazioni tali da meritare agli anglosassoni l’appellativo di gente inumana.”
Milano è stata per tutto il primo novecento una città cantiere. Per sua scelta ideologica, economica, artistica. È la città dell'Esposizione Universale del 1906, del Futurismo di Marinetti, Sant'Elia e Boccioni, dei nuovi quartieri operai affidati alle migliori menti dell'architettura razionalista, dei piani regolatori “fascistissimi” degli anni trenta. Demolire e ricostruire non la spaventava, sentendosi parte di un progetto di trasformazione talmente radicale da accettare la perdita – in una sorta di partita doppia – con la conquista della modernità. Ma la cesura violenta, smisurata, esorbitante, causata dall'indiscriminata violenza dei bombardamenti del '43 la sconvolge nell'intimo.
Non che non ne avesse già subiti dall'inizio del conflitto mondiale, ma erano bombardamenti mirati e contenuti. Abbastanza rovinosi, comunque, da far sfollare decine di migliaia di abitanti nelle campagne del milanese. Scelta, a posteriori, oculatissima che ha contenuto il numero delle morti civili dopo le notti brutali dell'agosto del '43.
La ferita per la città è devastante. L'ermetismo degli anni trenta di Salvatore Quasimodo non ha più voce. Il poeta cambierà lingua per poter esprimere lo sgomento:
Invano cerchi tra la polvere,
povera mano, la città è morta.
È morta: s’è udito l’ultimo rombo
sul cuore del Naviglio. E l’usignolo
è caduto dall’antenna, alta sul convento,
dove cantava prima del tramonto.
Non scavate pozzi nei cortili:
i vivi non hanno più sete.
Non toccate i morti, così rossi, così gonfi:
lasciateli nella terra delle loro case:
la città è morta, è morta.
(Milano, agosto 1943)
Da pochi mesi il greco/romano Alberto Savinio, pittore, scrittore, compositore, intimamente milanese come lo fu Stendhal, ha dato alle stampe per Bompiani un libro omaggio a Milano, Ascolto il tuo cuore, città, che per ironia della sorte (una sorte beffarda) diventa l'ultima testimonianza di come fosse la città prima delle perdite ingenti – sconvolgenti, anzi – causate dai bombardamenti. In un articolo sul Corriere della Sera del 7 settembre di quell'anno, girando per le macerie del centro storico il suo sguardo vaga, amaro e a ciglio asciutto:
“E quando nel meriggio del 26 agosto in una luce smagliante mi affacciai sotto la volta della stazione Centrale, anche Milano mi apparve come colta in istantanea dall’occhio spietato della macchina fotografica, ritta ma traballante, gli innumerabili occhi delle sue case fissi in uno sguardo vitreo, gli arti contorti in movimenti da città manichino, impillaccherata dalla testa ai piedi, «insudiciata» dalla morte. (…) La morte «insudicia». Insudicia quello che era pulito, intorbida quello che era limpido, inlaidisce quello che era bello, intenebra quello che era luminoso, istupidisce quello che era intelligente, immiserisce quello che era ricco.”
Insomma, la morte, come scriverà in tutt'altro contesto Roberto Saviano in Gomorra, “La morte fa schifo”. In quegli stessi giorni si sta concludendo la collaborazione di Giorgio Scerbanenco con il Corriere. Una breve parabola, proprio negli anni della guerra, che produrrà un paio di romanzi a puntate e un corposo numero di racconti. L'ultimo pubblicato, prima della fuga in Svizzera nel settembre del 1943, è del 27 agosto. S'intitola La casa in piedi e racconta di uno sfollato che dopo ogni bombardamento inforca la bicicletta, fa ottanta chilometri per giungere in città a vedere le condizioni del suo quartiere, per poi tornare in campagna e raccontare agli altri vicini sfollati quali case si sono salvate, quali invece sono irrimediabilmente perdute:
“Arrivò a Milano, discese in piazzale Loreto e continuò a piedi attraversando tutta la città. Le case bruciavano, fumo, polvere, soldati, quelli dell'Unpa col bracciale rosso, un vecchio teneva in mano la catena della sua bicicletta e la guardava, stupito che si fosse rotta proprio quando più ne aveva bisogno. Vezzari arrivò a fatica nei paraggi di casa sua. Quasi non si orientava più. I crolli e gli sventramenti avevano cambiato la fisionomia del paesaggio. Ma la vide subito, laggiù, la sua casa: era ancora in piedi. Intorno montagne di macerie, mozziconi di mura maestre.”
Non perdiamo di vista le date: il 25 luglio Mussolini rassegna le sue dimissioni al Re. I milanesi, gli italiani tutti, scendono in piazza e festeggiano la fine del regime, la guerra sembra davvero finita. Ma non è così, a detta del nuovo capo del governo. La guerra continua (Badoglio cerca di temporeggiare in realtà, nel tentativo di contenere l'eventuale reazione spropositata del sospettoso alleato tedesco). I bombardamenti su Milano di agosto sembrano insensati. Gli inglesi, nei raid degli anni precedenti, s'erano dimostrati capaci di fare bombardamenti mirati, su obiettivi strategici: caserme, stazioni, fabbriche.

Nel '43 è l'intero centro storico, strategicamente ininfluente, ad essere preso di mira. Milano come la conosciamo oggi è il risultato di quei devastamenti. Nessuna città italiana ha subito un fuoco di fila di tali proporzioni, il 60% del suo cuore antico subirà danni irreversibili, cambiandogli il volto irrimediabilmente. Solo Dresda avrà un destino più tragico: città dal punto di vista militare irrilevante, gioiello del barocco europeo, rasa al suolo, come tragicamente e straordinariamente raccontato da Kurt Vonnegut in Mattatoio n. 5.
Arturo Tofanelli, in Memorie imperfette, ricorderà quei bombardamenti con queste parole:
“I bombardamenti su Milano dell’agosto 1943, ebbero effetti materiali e psicologici disastrosi. Dopo la terza incursione in meno di una settimana, la città restò paralizzata e mezzo vuota. Rimaneva acuta in tutti noi l’incomprensione di quella barbara impresa; anche i più decisi sostenitori della causa alleata erano incapaci di trovare una giustificazione a lume di logica.”
La storiografia a venire e l'immaginario collettivo hanno sempre in qualche modo glissato sull'argomento. La teoria militare mirava con queste azioni di guerra a “infiacchire” il morale della popolazione nemica, cercando di indebolire l'appoggio al regime fascista. Che in realtà era già di suo scemato, come raccontano i festeggiamenti alla caduta di Mussolini appena tre settimane prima. Un bombardamento indiscriminato come quello prodotto dagli alleati, invece, per chi le bombe le vedeva cadere sulla propria testa, creava solo ripugnanza e disperazione. Gli inglesi lo sapevano, ad essere sinceri: Londra fu a lungo teatro di bombardamenti a tappeto da parte delle forze dell'Asse. Ma questo più che infiacchire, saldò gli anglosassoni attorno a Churchill. Eppure tanto quanto la cinematografia del dopoguerra ha fatto dei bombardamenti sulla popolazione inerme di Londra la prova della malvagità di Hitler, nessuno ha mai giudicato come insensati, se non addirittura, terroristici, i bombardamenti degli alleati sul cielo di Milano.
Le forze aeree degli alleati sapevano come e dove colpire. Lo hanno dimostrato in più e più bombardamenti mirati. Persino l'aver fatto terra bruciata attorno al Duomo, evitando però la cattedrale (forse per non entrare in rotta di collisione con le autorità ecclesiastiche) lo dimostra. Ma nessun dubbio, finito il conflitto, poteva sorgere sui liberatori. La storia, lo sappiamo, la scrivono i vincitori. Parlare di crimini di guerra è ancora oggi argomento da toccare con i guanti parlando di quei fatti lontani quasi ottant'anni. E nessuna autorità americana ha mai chiesto scusa per la più dolorosa ed evitabile delle carneficine causate da un bombardamento: la tragedia dei “piccoli martiri di Gorla” del 1944 (ma questa è un'altra storia).
Il novecento è un secolo colmo di testimonianze. Non solo fogli scritti, soprattutto immagini. In quei tragici giorni, con la sede del Corriere in fiamme, Vincenzo Carrese, che aveva da qualche anno fondato la sua agenzia fotografica, quella che diverrà la gloriosa Pubblifoto, girò per la città assieme ai suoi colleghi per testimoniare la tragedia. 3300 fotografie, documenti preziosissimi che ora, selezionati e organizzati, sono diventati una bella mostra alle Gallerie d'Italia voluta da Mario Calabresi: “MA NOI RICOSTRUIREMO. La Milano bombardata del 1943 nell'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo”. Essendo Calabresi un giornalista “naturale” ha trovato ovvio attualizzare un patrimonio documentario di tali dimensioni facendo rifotografare da Daniele Ratti alcuni di quei luoghi bombardati oggi, nei giorni della pandemia (come fosse una nuova battaglia da combattere per i milanesi). Operazione didascalica eppure efficace. Anche per mostrare come quella guerra nulla c'entri con questa pandemia. La Milano delle macerie è abitata da un popolo che opera, cammina, gira in bicicletta, si fa la barba per strada. La Milano confinata dal coronavirus è intonsa, a colori e vuota. All'apparenza più morta della città morta dei versi di Quasimodo. Eppure c'è qualcosa di intimamente meneghino in questa idea del confronto di quella Milano con questa Milano.
Nell'ultima pagina del racconto di Scerbanenco si legge: “La sua casa era rimasta in piedi ma senza dirselo sentì che era caduta con le altre, perché la nostra casa è fatta anche delle altre case; e se le mura, materialmente, non erano state colpite, il focolare era stato straziato.” Palazzo Marino, Piazza San Fedele, L'Ospedale filaretiano, la Galleria, la Scala, Palazzo Reale, Piazza Fontana, Sant'Ambrogio, Santa Maria delle Grazie, l'identità profonda della città deturpata. La morte, per dirla con Savinio aveva insudiciato tutto. Ma l'indole milanese non si ferma alla constatazione della tragedia: “Il primo giorno vidi Milano «insudiciata» dalla morte. Poi la notte calò e uno spettrale silenzio. L’indomani, già Milano s’illimpidiva.” Non a caso il racconto di Scerbanenco (pensate a quanto siano distanti i due autori per stile e quanto vicini nelle conclusioni) termina così: “Guardò poi il ritratto del figlio, appeso alla parete. Era un po' inclinato. Lo rimise dritto.”
Antonio Greppi, primo sindaco di Milano dopo la Liberazione (scrittore e commediografo, non dimentichiamolo) prometterà ai suoi cittadini: “Molto si è distrutto, ma noi tutto ricostruiremo con pazienza e con la più fiduciosa volontà”. Fu un lavoro immane che cambiò ancora una volta il volto della città. L'immensa mole di macerie fu trasferita dalla città abitata verso nord ovest, in una zona ancora agreste dove Piero Bottoni, negli anni della ricostruzione, sognerà e realizzerà proprio con quelle macerie uno dei “fatti urbani” (così lo chiamò Aldo Rossi) più importanti della città: il Monte Stella. Opera estrema di land art, sogno di una montagna nel cuore della pianura, tumulo della guerra, sacrario civile di un popolo mai domo, pronto ad ogni ripartenza.
INFORMAZIONI UTILI
Mostra MA NOI RICOSTRUIREMO. La Milano bombardata del 1943 nell'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo
9 ottobre – 22 novembre 2020
Gallerie d’Italia – Piazza Scala, Piazza della Scala 6, Milano
Dal 9 al 29 ottobre ingresso da Via Manzoni 10, dal 30 ottobre in poi ingresso da Piazza della Scala 6
Orari
Da martedì a domenica 11.00 –19.00 (ultimo ingresso ore 17.30)
Lunedì chiuso
Ingresso
Dal 9 al 29 ottobre 2020 intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per clienti del gruppo Intesa Sanpaolo, convenzionati, scuole e minori di 18 anni;
dal 30 ottobre al 22 novembre intero 10 euro, ridotto 8 euro, ridotto speciale 5 euro per clienti del gruppo Intesa Sanpaolo e under 26, gratuito per convenzionati, scuole e minori di 18 anni
Informazioni
Modalità di visita in sicurezza, informazioni e prenotazioni su www.gallerieditalia.com, info@gallerieditalia.com, Numero Verde 800.167619